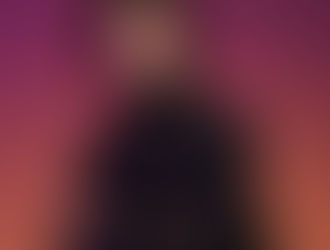Risultati di ricerca nel sito
716 risultati trovati con una ricerca vuota
- Le incompatibilità nelle società di capitali titolari di Farmacia.
Quali sono le incompatibilità sussistenti per un socio non farmacista di una società di capitali che è titolare di una farmacia? Si applicano anche ai soci - non farmacisti - le incompatibilità dell'art. 8 della legge 362/1991? Per rispondere al quesito richiamiamo la ricostruzione operata di recente dalla Corte costituzionale così come recepita dal Consiglio di Stato. Oggetto del giudizio costituzionale era l’art. 8, comma 1, lett. c), della l. n. 362d el 1991, il quale dispone l’incompatibilità “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. L’impostazione licenziata come conforme a costituzione è quella per cui “la causa di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991 non è riferibile ai soci, di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia”, ma può applicarsi “solo al socio che risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia”. A giudizio della Corte il punto decisivo per determinare l’incompatibilità è, pertanto, proprio il collegamento o meno con la effettiva “gestione” della farmacia. Seguici e Rimani Aggiornato In aggiunta ad argomenti di esegesi testuale, la Corte ha osservato, su un piano sistematico, come “l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo – che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale –, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest’ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio. Contattaci Se hai un Quesito Essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991”. Torna alla Home Legale Oggi
- Edilizia: Acquisto su carta, quali garanzie per l'acquirente?
Oggi la legge è chiara, il preliminare su immobile da costruire deve garantire l'acquirente, scopriamo come. La normativa di settore è dettata dal decreto legislativo 122 del 2005 che è stato recentemente emendato dal Codice della Crisi di Impresa nel 2019 nella parte centrale del testo, la piu' importante per quel che ci riguarda. Il primo punto – stabilito nell'articolo 6 – è che il contratto preliminare o il contratto relativo al trasferimento di diritti reali di godimento su immobile da costruire deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale atto quindi sarà demandato ad un Notaio al quale è imposto di seguire tutte le prescrizioni della nuova legge ed in particolare la verifica sulla stipula della fideiussione obbligatoria per il costruttore oltre che della polizza assicurativa all'atto del trasferimento. Sono queste due le chiavi portanti della norma oltre che il Fondo indennitario su cui si tornerà piu' avanti. Il costruttore infatti è obbligato, a pena di nullita' del contratto (nullità che puo' essere fatta valere unicamente dall'acquirente) a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento. Come ha avuto modo di evidenziare il Tribunale di Torino nella pronuncia del 29.09.2021 tale garanzia fideiussoria concerne anche le somme versate dall’acquirente a titolo non di acconto, bensì di “caparra confirmatoria” ex art. 1385 c.c.. La fideiussione deve garantire sia il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi ma anche nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo. La fideiussione quindi va a garantire a sua volta l'obbligo di stipula dell'assicurazione a cui il costruttore è tenuto. La mancata consegna dal costruttore all'acquirente della polizza assicurativa determina la nullità del contratto stipulato. Ma anche in questo caso la nullità potrà essere fatta valere solo dall'acquirente, e ciò con il chiaro scopo di evitare la comminatoria di una nullità strumentale fatta valere dal costruttore. Trattasi quindi di nullità relativa. Ma a cosa serve l'assicurazione indennitaria? La polizza assicurativa indennitaria prevista dalla legge avrà durata decennale e sarà a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori è volta alla copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Ecco quindi che il ruolo del Notaio, nel su menzionato modello di contratto da stipularsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, riveste un ruolo centrale per l'individuazione della fideiussione e la menzione della polizza assicurativa nel successivo contratto di alienazione. Sussistono poi tutta una serie di ulteriori garanzie come: - diritto di prelazione per il promissario acquirente - esenzione dalla revocatoria fallimentare - Istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti che non hanno ottenuto l'immobile. E' opportuno precisare che le garanzie descritte scattano al verificarsi di uno stato di crisi del costruttore, secondo standard ben individuati e precisamente si intende verificata la "cristi del costruttore" in una delle seguenti date: a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto; b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria. Un buon compromesso per l'acquisto dell'immobile, soprattutto in questo periodo di Bonus, consentirà di dormire sogni tranquilli Sei un costruttore, o un acquirente? Hai domande sull'argomento? Legale Oggi
- Recupero Borghi e Centri Urbani, è arrivato il bando.
Piccoli Comuni con residenti fino a 5.000 abitanti, nonché i Comuni istituiti con la fusione tra centri che hanno, ognuno, popolazione fino a 5.000 abitanti ma non solo. Per poter beneficiare dei finanziamenti non basta il numero di abitanti, devono essere comuni collocati in aree interessate da: – dissesto idrogeologico; – decremento della popolazione residente; – disagio insediativo; – inadeguatezza dei servizi sociali essenziali. Oggi però il piano si puó estendere ad altre tipologia di Comuni. Tipologia di interventi ammissibili Recupero e la riqualificazione dei centri storici All’interno dei centri storici, i Comuni possono individuare zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie. Si tratta di interventi di: risanamento; conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; miglioramento dei servizi Banda ultralarga Le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti di connessione veloce e ultraveloce possono essere destinatarie delle risorse previste in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015. Stampa quotidiana Previste misure per garantire la vendita dei quotidiani anche nei piccoli Comuni. Prodotti a chilometro zero La legge prevede la promozione del consumo e della commercializzazione di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Parliamo di prodotti il cui luogo di produzione, di coltivazione o di allevamento della materia prima sia situato entro 70 chilometri da quello di vendita e per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto. Inoltre, si prevede anche che i piccoli Comuni destinino specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane La legge dispone la predisposizione di un Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo a: collegamento delle scuole poste in tali aree; coordinamento tra i servizi, pubblici e privati; collegamento dei Comuni montani con i Comuni capoluogo di provincia e regione; informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative. Servizi È prevista la facoltà di istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali per fornire servizi anche in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica e postale. Questo per quanto concerne la legge salva Borghi N. 157/2017 cosi come attuata dal DPCM del 23 luglio 2021 con l’elenco dei 5.518 piccoli Comuni sotto i 5 mila abitanti che potranno beneficiare delle risorse concesse dalla cosiddetta legge “Realacci” per opere di riqualificazione e recupero dei centri storici nonché per la valorizzazione dei medesimi comuni (L. 6 ottobre 2017, n. 158). Ma non solo infatti nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro. L’Investimento è suddiviso in due linee d’intervento: la Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati e la Linea B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 20 dicembre 2021 entro massimo le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022 Sul sito del Ministero. Il piano vale sia per gli investimenti su beni Immobili che per beni Mobili inoltre al contributo concesso sulla base dell’Avviso pubblicato è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. per Approfondimenti Contattaci Seguici sui Social Legale Oggi
- Separazione e Divorzio senza Legale, conviene veramente?
Come ormai ben noto oggi è possibile procedere alla separazione civile, e quindi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio - divorzio - senza ricorrere al Tribunale, ed almeno teoricamente, anche senza farsi assistere da un avvocato. La procedura è molto semplice, basterà recarsi presso l'ufficio dello stato civile ove si è contratto il matrimonio civile e richiedere in un primo accesso la raccolta dei documenti da parte dell'ufficio, soprattutto ove uno dei due coniugi non sia dello stesso Comune, e quindi faccia riferimento ad un differente ufficio anagrafico. Reperiti i documenti, l'ufficiale dello stato civile convocherà per due volte i coniugi i quali dovranno manifestare la volontà di dar luogo alla separazione, elemento che dovrà essere confermato dopo 30 giorni dal primo incontro. I requisiti per procedere in Comuni sono 1) l'assenza di pretese economiche, ivi incluse questioni di carattere patrimoniale (si pensi alla casa coniugale); 2) l'assenza di figli minori, incapaci o se maggiorenni non autosufficienti. L'ufficiale dello Stato civile quindi previo assenso delle parti annoterà la separazione sull'atto di matrimonio, all'esito della 2a convocazione. Tale iter dovrà essere ripetuto all'esito dei 6 mesi per dar vita al Divorzio. Le condizioni per potere ottenere la separazione o il divorzio in Comune sono: L’accordo tra le parti sugli aspetti della separazione o il divorzio, vale a dire, il mantenimento, l’abitazione della casa, la sorte del contratto di affitto, mentre non potranno essere oggetto di accordo i trasferimenti patrimoniali. Si evidenzia che l'ufficiale dello Stato civile, o il Sindaco non potranno entrare nel merito degli accordi. I trasferimenti immobiliari, così come ogni ulteriore accordo dovrà essere regolato tra le parti o mediante contratto o tramite notaio, con rischi e costi connessi che renderebbero inutile l'aver avviato la procedura dinanzi al Comune. Sulla impossibilità di procedere ai trasferimenti immobiliari, e sulla importanza invece di procedere tramite Tribunale è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 21761, 29 luglio 2021 le Sezioni Unite ha chiarito la piena validità delle clausole negli accordi di separazione e divorzio aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili in favore dell’altro coniuge o dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) ai fini del mantenimento, ritenendo anche possibile procedere a immediata trascrizione dell’accordo (dopo la sentenza di divorzio o l’omologazione), senza la necessità di procedere per atto notarile per rendere valido il trasferimento, essendo l’accordo inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice, in quanto tale considerabile come atto pubblico ex art. 2699 c.c., che fa piena prova fino a querela di falso. Tale aspetto potrà fari riflettere sulla reale necessità o meno della modalità di separazione tramite Tribunale o mediante procedura semplificata Comunale. Ti serve un aiuto per inquadrare la vicenda? Contatta il Blog! Legale Oggi
- Autorizzazione Farmacia e Fallimento, illegittima la decadenza se manca il contraddittorio.
Facciamo il punto: La decadenza dall'autorizzazione della farmacia è prevista nei casi dell'art. 113 del Testo unico, per quello che qui interessa: A), a seguito della dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, e D) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; Cosa accade se a seguito del fallimento la farmacia viene chiusa per oltre 15 giorni, e la decadenza venga disposta non a causa diretta del fallimento, ma a causa della perdurante chiusura prevista dal comma d) dell'art. 113? Orbene il Tar Lazio nella recentissima pronuncia ha risposto che: “salva la ricorrenza di particolari ragioni di urgenza, è illegittimo il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia che, a seguito della chiusura dell'esercizio per oltre 15 giorni, sia stato disposto, ai sensi dell'art. 113 comma 1 lett. d), t.u. delle leggi sanitarie, senza una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l'assegnazione di termini per deduzioni” Infatti “ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett, d) del t.u. delle leggi sanitarie la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia a causa della chiusura dell'esercizio protrattasi per oltre 15 giorni può essere disposta solo nel caso in cui la chiusura non sia stata previamente notificata alla competente Autorità ovvero nel caso in cui questa, a seguito della notifica, non abbia acconsentito alla chiusura. Tale mancato consenso, però, non può tradursi nella semplice mancanza di assenso, ma deve essere esplicito e motivato” (T.A.R., Lazio, Roma sez. III , 20/11/2003 , n. 10435); Autorizzazione della Farmacia e Fallimento, illegittima la decadenza se manca il contraddittorio. Tar Lazio n. 10708/2021. Puo' interessarti anche: "Diritto Farmaceutico" Legale Oggi a cura dell'avv. Aldo Lucarelli
- Edilizia ed Urbanistica: Per l'abuso edilizio, il prefetto interviene se il Comune è fermo!
Quante volte è giunta la notizia di un accertato abuso edilizio a cui tuttavia non è seguita nessuna attività ripristinatoria da parte del Comune? Con la legge 120 del 11 settembre 2020 per fare fronte alla sempre crescente carico di lavoro a cui sono soggetti gli uffici tecnici dei Comuni, ed ancor di piu' al fine di ovviare alle inerzie dei Comuni italiani, è stato disposta la modifica dell'art. 41 del testo unico in tema di leggi edilizie, DPR 380/01 che ha previsto l'intervento diretto del Prefetto in caso di inerzia degli uffici comunali per i casi di abusi edilizi da rimuovere con demolizione accertata. Infatti in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento esecutivo di abbattimento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. Al fine di coordinare i rapporti tra Prefettura e Comune, è inoltre previsto che entro il termine di 180 giorni i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione. Va tuttavia precisato che il potere del Prefetto è un potere "sussidiario" ed in caso di inerzia da parte del Comune, tant'è che la Cassazione nella pronuncia 46194/2021 ha precisato che la nuova legge (120/2020) non ha inciso sulle attribuzioni del giudice dell’esecuzione di sospendere o revocare l’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di condanna. L'intervento del Prefetto quindi rimane un rimedio "ulteriore" e soggetto a precisi limiti. Legale Oggi
- Aste: L'acquisto dell'immobile all'asta
L'acquisto di un immobile oggi è una prassi molto diffusa, meno pratico invece è capire come procedere all'acquisto di un bene sia esso mobile o immobile con la procedura telematica dettata dal Governo tramite la piattaforma nazionale del Portale Telematico. Per prima cosa è necessario individuare l'immobile che interessa, o il bene mobile che si intende acquistare. E' possibile consultare gli avvisi oggi disponibili sui siti nazionali governativi o privati, ne esistono diversi da astegiudiziarie.it ad idealista.it a kijiji.it casa.it o immobiliare.it, o altri, (ci scusino se non citati) ogni sito rimanderà all'asta di riferimento ove è necessario verificare una serie di dati e precisamente: tipo di asta, telematica o tradizionale, data di vendita, data di presentazione dell' offerta , modalità di pagamento, soglia minima di offerta. Questi dati servono a confezionare la domanda, ma non sono sufficienti. Sarà necessario infatti individuare ancora il professionista incaricato, sia esso un Notaio, un Avvocato o un Commercialista, nonché l'autorità di riferimento, Tribunale, il luogo ed il numero di registro. Quest'ultimo - il numero di registro - è infatti utile per rintracciare la pratica presso il Tribunale ove è avviata la procedura, ma attenzione per accedere all'intero fascicolo consigliamo l'ausilio di un legale che segua la pratica. Non è ancora tutto. E' necessario quindi una volta individuati tutti i dati su riportati, consultare la documentazione dell'asta e precisamente l'avviso di vendita redatto dal professionista con tutte le indicazioni per procedere alla domanda di partecipazione ed alla somma minima necessaria per procedere (di solito il 10% della somma offerta), e la somma base chiamata offerta minima, solitamente individuata nel 75% della somma base d'asta. Non dimenticate però che l'atto piu' utile per avere una visione di cio' che si sta cercando di acquistare sarà la Consulenza del Tecnico depositata in Tribunale, e pubblicata unitamente all'avviso di asta sui siti internet descritti, o reperibile a richiesta presso il Delegato alla vendita. Nella Consulenza Tecnica e nella relazione notarile ad essa annessa, sarà possibile rintracciare la "storia" dell'immobile, la consistenza urbanistica, i rapporti con i creditori ipotecari ed ogni altra informazione degna di nota. La consulenza tecnica sarà quindi la carta di identità dell'immobile da acquistare. Tornado all'offerta invece, la somma pari al 75% del prezzo base sarà infatti sufficiente - ove siate fortunati - solo ove non vi siano offerte poste alla base d'asta, e non ci sia quindi la gara sulle offerte, ove prevista. Sarà quindi poi necessario procedere alla presentazione dell'offerta, nelle modalità stabilite, che saranno tradizionali cartacee o, come piu' spesso ora accade, telematiche, tramite PEC. Una volta partecipata alla gara, buona fortuna e vinca il migliore! Se hai domande su come orientarti nelle procedure esecutive mobiliari o immobiliari, sia telematiche che tradizionali contattaci e potremo guidarti passo per passo. L'acquisto dell'immobile all'asta conviene ma attenzione ai passaggi necessari per l'offerta telematica. Leggi la guida. Studio Legale Angelini Lucarelli LegaleOggi
- Farmacia e Stress da tamponi, non si poteve prevedere?
Le farmacie durante le festività natalizie sono state prese letteralmente d'assalto causa della normativa anti covid che prescrive la necessità di un tampone antigenico ove non si sia in possesso del Green Pass rafforzato, per intenderci quello rilasciato dalle autorità a seguito della doppia ed in alcuni casi tripla dose di vaccino anti Covid - 19. Vi sono poi i casi dei guariti che avevano ricevuto già una doppia dose, anch'essi quindi in possesso del Green Pass rafforzato, pass obbligatorio per poter accedere agli eventi natalizi come cene e feste. E le Farmacie? sono diventate il presidio n.1 anti covid, giusto, ma attenzione al sovraccarico di lavoro che ha portato tutto il sistema delle Farmacie sotto stress ed in alcuni casi ad un vero e proprio assedio, come il caso della Lombardia ove la Regione ha assicurato una vera e propria task force pubblica per garantire lo svolgimento dei tamponi molecolari ed antigenici, e sempre in Lombardia è stato poi chiesto proprio alle farmacie di allungare i tempi e gli orari per poter eseguire test. Non solo. Sarà anche richiesto ai medici di famiglia di poter sottoporre ai tamponi i propri pazienti. Oppure il caso dell'Abruzzo ove l'assessore alla Sanità ha diramato un comunicato in cui si invita ad effettuare il Test molecolare di conferma solo per l'accertamento della variante Omicron, si legge nel comunicato della Regione Abruzzo “Si raccomanda ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti – si legge nel documento – di riservare il test di conferma alle sole condizioni ritenute indispensabili”, come ad esempio la necessità di effettuare una valutazione preliminare per la possibile presenza di variante Omicron" Alla ricezione del referto di positività attraverso il sistema telematico Attra-2, l’autorità di sanità pubblica dovrà provvedere solo alla prenotazione del tampone molecolare di fine isolamento per il soggetto positivo e di fine quarantena per i suoi contatti, secondo le tempistiche già previste dai protocolli sanitari vigenti. La disposizione regionale si è resa necessaria alla luce dell’insostenibile sovraccarico operativo che si registra in tutte le strutture negli ultimi giorni e tiene conto del perfezionamento delle performance analitiche dei test antigenici attualmente in uso, che rende meno rilevante l’eventualità di falsi negativi. Ma come si fa a mettere in atto una simile disposizione? si vedrà! Nel frattempo In tutte le grandi città Italiane si registra lo stop alle prenotazioni per i tamponi, stante la presenza di lunghe file di attesa per procedere al tampone davanti alle farmacie. Nell'ultima settimana di Dicembre nelle farmacie lombarde sono stati effettuati oltre 865 mila tamponi, con una media giornaliera che supera i 123 mila test. (fonte ansa). E le farmacie sono chiamate a questo immane sforzo operativo con il proprio organico ordinario, il tutto come effetto distorto dell'ultima normativa anticovid varata a Dicembre. Farmacia e Tamponi Covid Legale Oggi
- Stress da problemi Legali?
Prima di avviare una pratica legale, una negoziazione oppure una causa, è necessario comprendere i rischi ed i benefici, nonché i costi a cui si può andare incontro in caso di sconfitta o di rigetto della domanda. Spesso infatti capita di avere aspettative non realizzabili oppure paure eccessive. Calcolare i costi e le opportunità di riuscita è il primo passo per avviare una controversia legale. Scrivi a Legale Oggi, esponi il tuo quesito e quale è il tuo scopo, ed avrai una valutazione complessiva della vicenda e l’indicazione delle possibili strade da percorrere anche con il legale da Te scelto. Lo studio di fattibilità sui costi e benefici è infatti il primo passo da intraprendere per risolvere il problema senza stress dovuti a tempi e costi nascosti. Legale Oggi offre uno studio di fattibilità prima di avviare ogni pratica a soli 29 euro, sceglierai tu poi la strada da percorrere ed il professionista di fiducia. Legale Oggi Dubbio o problema legale. Inquadra il problema, non perdere tempo! Sei un Avvocato o un consulente legale? il Blog "Legale Oggi" fornisce collaborazione anche ad Avvocati e Consulenti per l'inquadramento e la risoluzione della controversia.
- L'interdittiva antimafia può essere rivolta ad una persona fisica non imprenditore?
Ci è stato posto un interrogativo semplice nella forma ma complesso nella sostanza, il punto della vicenda verte sulla questione se la persona fisica che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società, possa essere destinatario di una informativa antimafia di tipo interdittivo. Si premette la risposta per poi scendere nel dettaglio della normativa, e la risposta non puo' che essere negativa al suddetto interrogativo. L'interdittiva antimafia non puo' essere applicata ad una persona fisica che non sia imprenditore oppure operatore economico. Questa la sintesi a cui è giunta la giustizia amministrativa, infatti..se è vero che le informative interdittive sono applicabili anche ai provvedimenti di tipo abilitativo-autorizzativo, va considerato che l’accertamento antimafia sulla persona fisica (anche nella veste di direttore tecnico, dipendente, socio ed amministratore) è pur sempre funzionale ad una valutazione di permeabilità criminosa dell’impresa individuale o societaria cui la medesima è collegata e che abbia chiesto una licenza, una concessione, un’autorizzazione o di contrattare con la P.A. ovvero, come nel caso concreto, l’iscrizione ad un Albo. Come ha avuto modo di focalizzare una recente pronuncia del Tar di Reggio Calabria infatti - la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione, a carico di determinati soggetti individuati dall’art. 85 del D.lgs. n. 159/11, della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (art. 84, comma 2), mentre l'informazione antimafia consiste “nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”, (art. 84, comma 3); - ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. n. 120/2014, “le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i)”. In particolare, si legge alla lettera f) che non devono sussistere, nei confronti del titolare dell’impresa (nel caso di impresa individuale) o del legale rappresentante, “le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; - il citato art. 67 prevede che l’applicazione di una misura di prevenzione impedisce di ottenere “iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati” e che il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto da tali autorizzazioni. Sulla esclusione dell'applicabilità alla persona fisica slegata dall'attività di impresa depongono poi elementi di carattere testuale e logico-sistematico: a) la definizione di informativa antimafia interdittiva, emergente dal tenore letterale del menzionato art. 84 c.a.m. che, rispetto alla comunicazione, “presenta un quid pluris individuabile nella valutazione discrezionale da parte del Prefetto del rischio di permeabilità mafiosa capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa…interdicendole l’inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l’Amministrazione o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione” (cfr. parere n. 1060 del 12 maggio 2021 dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato). b) l’elenco tipizzato dei soggetti sottoposti a verifica antimafia indicato nell’art. 85 c.a.m a seconda che i destinatari dell’interdittiva siano un’impresa individuale (comma 1) ovvero associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese (comma 2). La sottoposizione a verifica antimafia di una persona fisica, quindi, deve essere necessariamente funzionale a significare eventuali condizionamenti criminosi nei confronti di un’impresa individuale o societaria organizzati dalla mafia, onde prevenire il rischio di inquinamento dell’economia legale; ed infatti, per la ditta individuale si richiede la sottoposizione a verifica del titolare o del direttore tecnico o dei familiari conviventi; per le società, associazioni, consorzi, etc., la platea di soggetti sottoposti a verifica è estesa ad altre categorie di persone, quali i soci, i legali rappresentanti, i membri dei collegi sindacali, etc… oltre a tutti i familiari conviventi. Come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3, l’informazione interdittiva antimafia riguarda specificamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli “operatori economici”.. ipotizzare l’interdicibilità di una persona fisica non imprenditore significherebbe forzare inammissibilmente la tenuta costituzionale del sistema antimafia, fuoriuscendo dai limiti “strutturali” dell’istituto dell’informazione interdittiva che da misura amministrativa di tipo cautelare e preventivo finirebbe per tramutarsi in una sorta di anticipazione di pena accessoria tipica dell’ordinamento penale (v. artt. 32 bis e ss. c.p.), in violazione di ogni principio di legalità formale e sostanziale e di “prevedibilità” della sanzione; Legale Oggi cfr. Tar Reggio Calabria n. 3/2022 e CdS Adunzanza plenaria 6.04.2018 n. 3
- Arbitrato e Società: E se gli arbitri non rispettano i termini?
L'arbitrato è la modalità sempre più diffusa di risoluzione delle controversie tra privati, senza accedere ad un Tribunale. Sempre piu' spesso, sia in ambito Societario, Bancario ed Assicurativo, la modalità di risoluzione delle controversie è la devoluzione ad un procedimento arbitrale. Esistono altre modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra cui la Negoziazione Assistita e la Mediazione, l'uso dell'una o dell'altra procedura dipenderà dagli interessi in gioco, visto che in alcuni casi prescritti dalla legge la Mediazione o almeno il tentativo di mediazione è obbligatorio, si pensi al caso delle ipotesi di malasanità. Ove invece la scelta è rimessa alla libera determinazione delle parti accade sovente che sia l'arbitrato la modalità piu' utilizzata, soprattutto in tema di diritto societario e di dispute interne alle società. Non è infatti raro trovare negli statuti societari predisposti da commercialisti, avvocati o notai, una clausola di compromesso arbitrale a cui devolvere la controversia insorta tra i soci o tra le cariche sociali. Ricordiamo che è costante la giurisprudenza in tema societario della non devolvibilità in arbitrato delle risoluzione di controversie su diritti indisponibili, e di annullamento di delibere societarie relative all'approvazione del bilancio annuale. (Cass. Civ. 13031/14). Fatta tale premessa, scopo del presente articolo è quello di focalizzarsi sui tempi dell'arbitrato. Infatti come disposto dall'art. 820 del codice di procedura civile gli arbitri dovranno pronunciarsi entro un termine stabilito dalle parti, ed accettato nella convenzione di arbitrato. La convenzione di arbitrato è quell'atto in cui l'arbitro, d'accordo con le parti chiamate, indica le modalità di svolgimento dell'arbitrato, e le regole da seguire che potranno essere di puro diritto o secondo equità. Rimane quindi il nodo del termine; Se non è disposto dalla convenzione di arbitrato è la stessa legge che fissa il termine finale in 240 giorni dalla accettazione dell'incarico, termine entro cui l'arbitro è chiamato a depositare la propria decisione, appunto il "lodo" arbitrale. Il termine puo' essere prorogato su richiesta delle parti, o in casi specifici come la necessità di assumere delle prove nel limite di 180 giorni. (art. 820 cpc). L'arbitrato attenzione che non è soggetto alla sospensione feriale, trattandosi di procedimento frutto di autonomia negoziale. Ma cosa accade se non viene rispettato il termine per la pronuncia dell'arbitrato? La risposta è prevista dalla combinazione degli articoli 821 e 829 cpc ai sensi dei quali il lodo è nullo ove non sia rispettato il termine prescritto o vi sia una proroga illegittima, ma attenzione, tale nullità si verifica solo se la parte che intende approfittarsi della norma, prima della deliberazione del lodo, abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza e quindi l'ipotesi di nullità. Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento. La ratio della norma è chiara, questa infatti impone alla parte che voglia denunciare la nullità del lodo per mancato rispetto del termine, di dichiarare la propria volontà di eccepire la nullità ben prima di conoscere l'esito del lodo, ed evitare così di proporre eccezioni di nullità solo strumentali all'esito del lodo infruttuoso. Su tale aspetto si è occupata spesso la Cassazione, anche in un nostro recente caso, ed ha statuito che: "in tema di arbitrato, questa Corte ha avuto infatti modo di ribadire più volte che, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 6, il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è di per sè sufficiente a determinarne la nullità, costituendone il mero sostrato di natura fattuale, cui deve fare riscontro, ai sensi dell’art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà di far valere la decadenza, la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata, il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale, trattandosi invece di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest’ultima non può essere fatta valere (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2012, n. 889; 26/03/2004, n. 6069; 15/11/ 1984, n. 5771);" Ti è piaciuto l'argomento? hai un quesito particolare da sottoporre? L'arbitrato è la modalità sempre più diffusa di risoluzione delle controversie tra privati, senza accedere ad un Tribunale.
- Edilizia ed Urbanistica: L’impugnazione da parte del vicino.
Stop ai ricorsi per solo principio! Il Consiglio di Stato prende posizione e sottolinea come debba sussistere un concreto interesse alla impugnazione per un ripristino concretamente utile da parte del vicino e non è sufficiente una mera legittimazione emulativa... è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato; L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo. Adunanza Plenaria CdS 22/2021 Legale Oggi L'impugnazione da parte del vicino;