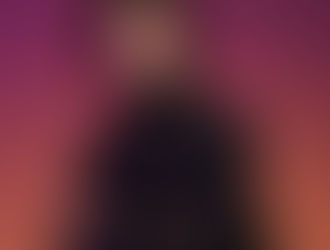Risultati di ricerca nel sito
715 risultati trovati con una ricerca vuota
- L’associazione sportiva e le responsabilità del presidente
La questione della responsabilità nelle associazioni non riconosciute è un tema complesso dove si intrecciano norme tributarie e principi civilistici. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) svolgono un ruolo centrale nel panorama sportivo italiano. Tuttavia, la gestione di tali enti comporta responsabilità giuridiche rilevanti, in particolare per il presidente e per i soggetti che ne rappresentano l’attività verso l’esterno. Comprendere quando e perché il presidente risponde personalmente è fondamentale per una corretta amministrazione dell’associazione. Nella maggior parte dei casi, l’ASD è costituita come associazione non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36–38 del Codice civile. Tali enti non sono dotati di personalità giuridica, con la conseguenza che non esiste una separazione patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello delle persone fisiche che agiscono in suo nome. L ’art. 38 c.c. stabilisce che: Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. La norma individua un principio fondamentale: ovvero che la responsabilità personale non deriva dalla carica ricoperta, ma dall’attività concretamente svolta. la responsabilità del presidente: quando sussiste Il presidente dell’ASD risponde personalmente, solidalmente e illimitatamente quando: ha sottoscritto contratti (locazioni, forniture, collaborazioni); ha assunto obbligazioni verso terzi in nome dell’associazione; ha gestito direttamente l’attività economica o amministrativa; ha agito come rappresentante effettivo dell’ente. In tali casi, il creditore può agire: sul patrimonio dell’associazione; anche sul patrimonio personale del presidente che ha agito. In queste realtà, prive di personalità giuridica, il patrimonio dell'ente non è del tutto separato da quello di chi agisce in suo nome. Parliamo delle associazioni non riconosciute come quelle da sportive oppure professionali ad esempio di infermieri. A livello fiscale tributario é opportuno richiamare Il principio di trasparenza (Art. 5 TUIR) e la responsabilità fiscale. Secondo l'articolo 5 del TUIR, i redditi delle associazioni senza personalità giuridica (equiparate alle società semplici per questo aspetto) sono imputati a ciascun associato indipendentemente dalla percezione effettiva, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Come accade quindi in caso di irregolarità ad esempio in caso di Omessa Dichiarazione? Se il Presidente (rappresentante legale) omette di presentare la dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate emetterà avvisi di accertamento. Le sanzioni amministrative per l'omessa dichiarazione ricadono in primis sull'associazione, ma per il principio della responsabilità solidale e personale (Art. 38 c.c.), il Presidente che ha agito in nome e per conto dell'ente risponde con il proprio patrimonio personale. Attenzione, sebbene le sanzioni tributarie siano personali, il recupero delle imposte evase avviene pro-quota sui singoli associati in virtù del regime di trasparenza. Capitolo a sé riguarda la Responsabilità del Presidente durante la vigenza del rapporto associativo. (Contrattuale) Finché il rapporto associativo è attivo, tra l'associato e il Presidente (nonché verso l'associazione stessa) intercorre un rapporto di natura contrattuale. Il Presidente dell’associazione è quindi considerato un mandatario in quanto tale ha il dovere di gestire l'ente con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.). Se l'associato quindi subisce un danno patrimoniale (es. deve pagare tasse o sanzioni perché il Presidente non ha presentato la dichiarazione), può agire contro il Presidente per responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.). La presenza del rapporto associativo é da considerare come un vantaggio per l'associato: In questo caso, l'onere della prova è agevolato: l'associato deve solo dimostrare l'esistenza del rapporto associativo e il danno ; spetta al Presidente dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Leggi il blog e rimani informato, trova il tuo caso tra quelli svolti Cosa accade dopo le dimissioni dalla qualifica di associato? Un associato é libero di uscire dall’associazione? Quando un associato presenta le dimissioni, il vincolo contrattuale si scioglie. Tuttavia, le pendenze fiscali relative al periodo in cui era socio rimangono. Responsabilità Extra-contrattuale (Art. 2043 c.c.) dell’ex associazione Dopo le dimissioni, ove emergono debiti o sanzioni per fatti accaduti durante la vigenza del rapporto ma accertati successivamente, la natura della responsabilità del Presidente nei confronti dell'ex socio può mutare o integrarsi con la responsabilità extracontrattuale (Aquiliana). L’associazione sportiva e le responsabilità del presidente Nel nostro caso ove il comportamento del Presidente (l'omessa dichiarazione dei redditi) configura un fatto illecito che arreca un "danno ingiusto" al patrimonio dell'ex socio ( ormai terzo rispetto all'associazione) , quest'ultimo può richiedere il risarcimento dei danni, ma quale é la differenza tra il periodo in cui vigeva il rapporto associativo e dopo lo scioglimento di tale rapporto? Sciolto il rapporto associativo l’ex socio deve dimostrare non solo il danno, ma anche il dolo o la colpa del Presidente ed il nesso di causalità diretto tra l'omissione e la sanzione subita e ciò in quanto dopo le dimissioni il rapporto tra l’ex associato ed il suo presidente é un rapporto tra estranei. Hai un caso specifico? Contattaci Non secondario è il compito del tempo, la responsabilità contrattuale si prescrive solitamente in 10 anni, quella extracontrattuale invece in “soli” 5 anni. Questo é il lasso temporale entro cui si potrà agire. In caso di sanzioni per omessa dichiarazione, l'ex socio che ha pagato pro-quota le imposte (per il principio di trasparenza del TUIR) ha sempre il diritto di regresso verso l'associazione e può agire contro il Presidente per il risarcimento del danno subito a causa della sua mala gestione. Hai un quesito? Contattaci Sarebbe utile verificare se lo statuto dell'associazione preveda clausole specifiche di manleva o limitazione di responsabilità (anche se queste non sono opponibili al fisco, hanno valore mi nei rapporti interni tra soci). Studio legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacista e consulenza
Se l’obiettivo principale del farmacista è quello di fare consulenza ed evitare l'integrazione di cause di incompatibilità o decadenza previste dalla Legge 124/2017 e dal D.Lgs. 258/2006 si profila per questo farmacista la possibilità di operare come libero professionista consulente indipendente. Abbiamo visto nel post “ farmacista e nutraceutica” che il farmacista può effettuare consulenza individuale sulla base del codice deontologico, ma quale é il codice ateco più idoneo per aprire una partita iva ? Per operare come consulente senza configurare una gestione o proprietà di un'altra farmacia (che causerebbe la decadenza in caso di concorso), il codice ATECO più corretto e neutro è solitamente legato all'attività professionale intellettuale. Farmacista e consulenza Il codice più indicato per un farmacista che svolge attività di consulenza (scientifica - non nel senso di informazione scientifica su cui si dirà inseguito -, tecnica o gestionale) potrebbe essere quello relativo al n. 74.90.99 relativo a “ Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (non classificate altrove)” Ma perché questo codice? Si tratta ad avviso di chi scrive di un codice "ombrello" che permette di fatturare consulenze professionali senza legare l'attività a una struttura specifica (come una parafarmacia o un deposito all'ingrosso). Non implica il commercio di farmaci, evitando sovrapposizioni pericolose con la normativa di settore. E’ da evidenziarsi infatti che l’attività di consulenza non deve essere prestata a favore di competitor diretti che possano configurare una violazione del patto di esclusività o della normativa regionale (se trattati si farmacia da concorso) e comunque tale non generare concorrenza sleal e in caso di rapporti tra più farmacie private. In tema di contributi all' ENPAF , sarà necessario verificare se i contributi derivanti dalla Partita IVA possono essere integrati nella posizione esistente. Consulenza ed informazione scientifica Come ben noto l’ 7, comma 2, della Legge 362/1991 (come modificato dalla Legge sulla Concorrenza 124/2017) rappresenta lo scoglio più duro per un farmacista titolare o socio che desideri operare nel settore della consulenza, ma mai nel canale (vietato) dell'informazione scientifica. Mentre per altre forme di consulenza ad esempio gestionale, amministrativa o tecnica è possibile trovare uno spazio di manovra con i codici ATECO generici, l'attività di Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) è oggetto di un divieto esplicito e rigoroso. (Art 7 legge 362/1991). "La partecipazione alle società [titolari di farmacia] è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica." Questa norma punta a prevenire il conflitto di interessi, si vuole evitare che chi prescrive (medico), chi promuove (informatore) e chi dispensa (farmacista) siano lo stesso soggetto o abbiano interessi economici incrociati che potrebbero influenzare le scelte terapeutiche a danno del SSN o del paziente. Ma non é questo l’ambito della nostra indagine, ci chiediamo infatti quale sia lo spazio da consulente del farmacista senza cadere nei vincoli di legge. Abbiamo già visto nel post sulla nutraceutica che esiste spazio per la consulenza in farmacia ma cosa dire nell’ambito di applicazione per i vincitori di Concorso straordinario? Per chi ha partecipato al concorso straordinario, il rischio di decadenza è altissimo ove ci si soffermi sul concetto di informazione scientifica oppure in caso di contestazione da parte di Asl e Regione Ma esiste una distinzione tra "Consulenza" e "Informazione scientifica”? Se l’ idea di " consulenza " coincide con l'attività di ISF presso i medici per conto di un'azienda farmaceutica, la risposta è semplice: l'incompatibilità è assoluta. Tuttavia, il confine si sposta se la consulenza è di carattere regolatoria come la Redazione di dossier tecnici, vigilanza interna e consulenza su normative (senza contatto con i medici prescrittori). Oppure sia rivolta alla formazione interna e non ad una promozione commerciale. In questi casi, l'uso del codice 74.90.99 (che abbiamo visto prima) è fondamentale perché definisce l'attività come "professionale e tecnica" e non come "informazione scientifica" (che avrebbe codici specifici. Ecco quindi che la consulenza ammessa in farmacia può ritenersi ammesso anche in caso di requisito da concorso ove non si estenda tale deduzione alle ipotesi vietate 🚫 (legge 362/1991 e bandi di concorso) elementi questi che non potranno che essere analizzati nel singolo caso specifico sulla base di contestazioni circostanziate. Certo che rimane il divieto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, per i concorrenti, (art 8 legge 362/1991) ma allora come rendere compatibile la consulenza residuale con l’attività di farmacista? A questa contestazione, si potrebbe replicare che lo svolgimento di una libera professione intellettuale (lavoro autonomo puro) non costituisce tecnicamente un "rapporto di lavoro", ma un'attività professionale. Se così non fosse, il farmacista non potrebbe nemmeno fare il perito per il tribunale o scrivere articoli scientifici retribuiti. L'art. 8 c) non vieta la "produzione di reddito diverso", ma vieta la "dipendenza" da un altro datore di lavoro. Per muoversi in tale direzione la consulenza dovrà restare nell'alveo dell' opera intellettuale saltuaria. Hai un quesito? Leggi il blog in diritto farmaceutico oppure contattaci La consulenza con Partita IVA (lavoro autonomo) non è tecnicamente un "rapporto di lavoro" inteso in senso subordinato (dipendente). Tuttavia, se la consulenza è prestata in modo continuativo, esclusivo e prevalente per un solo committente, la ASL potrebbe tentare di riqualificarla come "parasubordinata" o "dipendente camuffata", innescando la decadenza. La consulenza dovrebbe quindi mantenere i caratteri dell'episodicità o comunque della pluralità di committenti, per non inficiare l'obbligo di "gestione diretta e personale" della farmacia. Da ultimo, due parole sulle conseguenze della violazione. La giurisprudenza e gli ordini professionali sono molto severi su tale punto. Si andrà dalla sospensione dall'albo: Per un periodo non inferiore a un anno sino alla decadenza dalla titolarità: L'ASL o la Regione possono avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia vinta a concorso. Leggi pure: Leggi il blog e rimani informato Quindi la consulenza del farmacista , nei limiti sopra esposti ed anche a pagamento potrà svolgersi come libera professione in farmacia (ma anche altrove) e potrà riguardare l’uso corretto dei farmaci secondo le prescrizioni, la consulenza su integratori e nutraceutici, l’educazione a stili di vita salutari, oltre al supporto alla aderenza terapeutica compresa la consulenza nutrizionale non clinica (no diete terapeutiche né prescrizioni). Leggi pure: Farmacia la decadenza dall’autorizzazione Si tratta di ipotesi di studio che necessitano la conferma da parte della Asl e dell’Ordine di appartenenza. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per la Farmacia Avv Aldo Lucarelli
- Concorso in caso di esclusione va impugnata sempre la graduatoria finale
In caso di esclusione dal concorso (es farmacisti, notaio, magistratura) é sufficiente l’impugnazione dell’esclusione oppure é obbligatorio impugnare anche la graduatoria finale? A tale quesito risponde in modo cristallino una recente sentenza del TAR Lazio secondo cui La mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile (Sul punto copiosa giurisprudenza tra cui T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- bis , 17 dicembre 2025, n. 22884; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; Consiglio di Stato, Sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959). Concorso in caso di esclusione va impugnata sempre la graduatoria finale Pertanto, il partecipante ad un concorso, che abbia impugnato il proprio atto di esclusione, ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti. leggi i post in tema di concorsi e graduatorie clicca qui Conseguentemente, il partecipante ad un concorso, che ha impugnato il proprio atto di esclusione ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti (TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; v. anche: Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148). Leggi pure Concorso Farmacie quando L’impugnazione é possibile solo dopo la partecipazione Sussiste pertanto una ragione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione delle graduatorie, in quanto anchel’accoglimento del ricorso non produrrebbe alcun risultato utile all’interessato che non ha impugnato la graduatoria che quindi rimarrebbe “cristallizzata” Seguici e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Eredità e successione il caso della cassetta di sicurezza
L'apertura di una cassetta di sicurezza in presenza di una cointestazione e di un erede minore è una procedura rigorosa che richiede il rispetto di passaggi legali precisi. Leggi il blog e trova il tuo caso in tema di Eredità altrimenti contattaci Come aprire la cassetta di sicurezza cointestata in caso di scomparsa di uno degli intestatari. Nonostante la cointestazione (spesso a firma disgiunta), alla morte di un cointestatario la banca blocca la cassetta non appena riceve la comunicazione del decesso. Per aprirla è necessaria la presenza di un Notaio o Funzionario dell'Agenzia delle Entrate, attenzione non è possibile aprirla autonomamente, difatti la banca non lo permetterà non appena abbia la legale conoscenza del decesso di uno degli intestatari. È obbligatorio che l'apertura avvenga alla presenza di un notaio o di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate per redigere l'inventario del contenuto. Devono essere convocati tutti gli eredi (il coniuge superstite e i rappresentanti dei figli). Ai fini della individuazione del valore è necessaria una Perizia degli oggetti: Se all'interno sono presenti gioielli o preziosi, il notaio solitamente richiede l'assistenza di un perito per stimarne il valore. Cosa accade in caso di figli minori? Ove tra gli eredi vi sia un minore, la legge prevede una tutela speciale per evitare conflitti di interesse o pregiudizi verso il suo patrimonio: L'autorizzazione del Giudice Tutelare: Per procedere all'apertura e alla successiva divisione dei beni (accettazione dell'eredità), il genitore superstite deve presentare un ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale di residenza del minore. Accettazione con beneficio d'inventario: Per legge, i minori possono accettare l'eredità solo con il beneficio d'inventario. Questo protegge il minore: se il defunto avesse debiti, il minore risponderebbe solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. Ma come dividere la somma ritrovata? Una volta inventariata la somma di denaro, la divisione segue le regole della successione legittima (se non c'è un testamento), quindi in caso di cointestazione ove la cassetta era cointestata tra i due coniugi, si presume che la metà del contenuto (50%) appartenga già al coniuge superstite. Solo l'altro 50% cade in successione. Le quote ereditarie (su quel 50% caduto in successione), al coniuge spetta 1/3 della quota del defunto, mentre per i figli si dividono i restanti 2/3 in parti uguali tra loro. Capitolo a sé merita la gestione della quota del minore La somma spettante al figlio minore non può essere spesa liberamente dal genitore. Il Giudice Tutelare disporrà che la somma venga depositata su un conto corrente vincolato intestato al minore. Il genitore potrà prelevare somme da quel conto solo previa autorizzazione del Giudice e solo per necessità urgenti o per l'interesse esclusivo del figlio. Leggi pure: L'accettazione tacita e la rinuncia all'eredità Studio Legale Angelini Lucarelli Aldo Lucarelli
- Divorzio Assegno divorzile e 40% del TfR
Diritto di Famiglia, in caso di Divorzio, quale é la sorte del Trattamento di fine rapporto ( t.f.r. )? TFR, la Quota del 40% prevista dall’Art. 12- bis , l. n. 898/1970, Spetta al congiunge anche in caso di Assegno divorzile attribuito con finalità esclusivamente assistenziali Il riconoscimento, in favore del coniuge divorziato, della quota del quaranta per cento del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 12- bis , legge n. 898/1970 non può essere negato per il solo fatto che l’assegno divorzile sia stato attribuito con finalità esclusivamente assistenziali e non anche compensativo-perequative. Di fatti, l’art. 12- bis , su menzionato, rappresenta uno strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi, finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di una entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio. Leggi il blog in diritto di famiglia Si tratta di una misura diretta a favorire il coniuge divorziato, riconoscendo il diritto a godere almeno in parte di quella componente del patrimonio rappresentata dall’indennità di fine rapporto (t.f.r.), specie in considerazione della sua natura di retribuzione differita . (Cass 32910/2025) Studio Legale Angelini Lucarelli
- Quali patti parasociali per la tutela della minoranza in una Srl
Come si tutela il socio di minoranza in una Srl in caso di acquisto da un terzo della quota di maggioranza? Quali sono le funzioni dei patti parasociali? Quale é la differenza tra un patto parasociali ed una clausola della statuto? Patto parasociale e contratto preliminare di vendita delle quote Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza tra i quesiti che ci sono stati posti con attenzione particolare ai rimedi per la tutela del socio di minoranza. È possibile tutelare il socio di minoranza in una S.r.l. in caso di acquisizione della società da parte di terzi, soprattutto se l'acquisizione comporta un cambio di controllo, attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei patti parasociali . Scopri la nostra esperienza in diritto societario Patti Parasociali Vs Clausole dello Statuto I patti parasociali sono accordi contrattuali stipulati tra i soci (o alcuni di essi) a latere del contratto di società, che vincolano i firmatari ad adottare un determinato comportamento, ma che non hanno efficacia esterna e non vincolano la società (a differenza dello statuto ). Di seguito sono elencate le clausole più comuni utilizzate per la tutela del socio di minoranza in un contesto di acquisizione: 1. Clausole di Co-Vendita Questa è la clausola più importante per la tutela del socio di minoranza in caso di cessione di controllo: • Diritto di Accodamento Se il socio di maggioranza (o un gruppo di soci che detiene il controllo) riceve un'offerta vincolante da un terzo per l'acquisto della propria partecipazione, il socio di minoranza ha il diritto di vendere anche la propria quota allo stesso terzo acquirente e alle medesime condizioni economiche (stesso prezzo e termini). Questo tipo di clausola garantisce al socio di minoranza una "via d'uscita" in caso di cambiamento della compagine sociale e gli permette di beneficiare del "premio di maggioranza" spesso incluso nel prezzo pagato per il pacchetto di controllo. 2. Clausole di Trascinamento con Bilanciamento Questa clausola è spesso richiesta dal socio di maggioranza o dal potenziale acquirente per garantire l'acquisto dell'intera società, ma deve essere bilanciata per la minoranza: • Diritto di Trascinamento ( Drag-Along ): Obbliga il socio di minoranza a vendere la propria partecipazione insieme alla maggioranza, qualora quest'ultima riceva un'offerta per l'acquisto del 100% delle quote. • Tutela per la Minoranza: Per bilanciare questo obbligo, la clausola deve prevedere che la vendita avvenga alle medesime condizioni economiche della maggioranza e, soprattutto, che l'offerta sia soggetta a un prezzo minimo o a una valutazione oggettiva della società, in modo da evitare che la minoranza sia costretta a vendere a un prezzo non equo. 3. Clausole di Blocco e Prelazione Queste clausole mirano a stabilizzare l'assetto proprietario e a impedire l'ingresso di soci non graditi: • Patto di Prelazione Se un socio intende vendere le proprie quote a un terzo, è obbligato a offrirle prima agli altri soci (inclusa la minoranza) alle stesse condizioni pattuite con il terzo. Consente alla minoranza di evitare l'ingresso di un terzo "sgradito" acquistando essa stessa la partecipazione in vendita. • Patto di Blocco (o non alienazione): Un accordo che vincola i soci a non cedere le proprie partecipazioni per un periodo di tempo determinato. 4. Clausole di Exit (Uscita) Offrono al socio di minoranza la possibilità di uscire dalla società in determinate circostanze: • Opzione di Vendita ( Put Option ): Attribuisce al socio di minoranza il diritto di vendere la propria partecipazione al socio di maggioranza (o agli altri soci) a un prezzo predeterminato o determinabile, al verificarsi di determinate condizioni (es. cambio di controllo, mancato raggiungimento di specifici risultati, o violazione dei patti parasociali). 5. Tutela nella Governance e Amministrazione Sebbene non direttamente legate all'acquisizione, queste clausole sono essenziali per tutelare la minoranza in generale, anche dopo un cambio di controllo: • Diritto di Veto o Quorum Rafforzati: Previsione di quorum deliberativi più elevati (nello statuto o nei patti) per delibere relative a materie di particolare importanza (es. operazioni straordinarie, aumenti di capitale, modifica dell'oggetto sociale, nomina e revoca degli amministratori). Tale tipo di clausola conferisce al socio di minoranza un potere di blocco (veto power) su decisioni strategiche che potrebbero danneggiare i suoi interessi. Assistenza legale per società ed imprese • Nomina di un Amministratore (o di un Sindaco) di Minoranza: Attribuzione alla minoranza del diritto di nominare uno o più membri dell'organo amministrativo o di controllo. Garantisce accesso alle informazioni e la possibilità di sorvegliare la gestione. Quali patti parasociali per la tutela della minoranza in una Srl Quali patti parasociali per la tutela della minoranza in una Srl Attenzione, I patti parasociali hanno efficacia solo tra le parti firmatarie (i soci che li sottoscrivono). In caso di violazione, la sanzione tipica è il risarcimento del danno , a meno che non siano previsti meccanismi diversi (come penali). Patto para sociale e preliminare di vendica di quote Altre tipologie di patti sono riferibili a prezzi di vendita quote ad una certa data o ad accordi preliminari di vendita da prevedere nel patto ma da collegare ad un contratto preliminare vero e proprio a cui il patto stesso rimanda. É il caso della vendita di quote con effetti successivi al patto e previsti in un apposito contratto preliminare di cessione quote. Leggi i casi svolti e trova ispirazione per risolvere il tuo caso specifico altrimenti contattaci In questa ipotesi specifica il patto parasociale è un contratto atipico (spesso contenente clausole tipiche come sindacati di voto o di blocco) che ha la funzione di regolamentare i rapporti tra i soci nel tempo, influenzando la governance o la circolazione delle partecipazioni. Mentre il contratto preliminare (o compromesso) è l'accordo con cui le parti si obbligano reciprocamente a stipulare un futuro contratto definitivo, in questo caso, il contratto definitivo di cessione delle quote. Il caso qui descritto è l'esempio di un collegamento negoziale tra i due contratti: • Il Patto Parasociale definisce l' Obbligazione Condizionale (o Potestativa) a vendere o acquistare (es. attraverso una Put Option esercitata dal socio di minoranza). Hai un quesito? O un tuo caso? Contattaci • Al momento dell' Esercizio dell'Opzione (o del verificarsi della condizione) il Patto Parasociale fa nascere l' Obbligo di Stipulare un ulteriore contratto: il Contratto Preliminare di Cessione Quote . Ma quali sono i vantaggi di questo doppio approccio, tra patto parasociale e preliminare di cessione quote? Certezza Legale (Patto): Il patto fornisce la base legale e i criteri per la futura operazione di exit. Se il socio di maggioranza non rispetta l'obbligo nato dal patto, il socio di minoranza può richiedere il risarcimento del danno (e/o l'escussione di una penale). 2. Esecuzione Specifica (Preliminare): Una volta stipulato il Contratto Preliminare, se la parte obbligata si rifiuta di stipulare il definitivo di cessione, la parte lesa può ricorrere al rimedio più potente: l' Esecuzione Specifica dell'Obbligo di Contrarre (art. 2932 c.c.). Leggi il blog e trova il tuo caso Con tale meccanismo quindi si passa da una tutela risarcitoria (tipica del patto para sociale) ad una possibile sentenza (obbligo a contrarre ai sensi dell’art 2932 cc) che può produrre gli effetti del contratto definitivo non concluso, trasferendo forzatamente le quote e ordinando il pagamento del prezzo, rendendo l'obbligo di vendita "reale" (anche se nato da un accordo obbligatorio). In tale prospettiva il Patto Parasociale crea l'obbligo di disciplinare l'uscita (la Put o Call), mentre il Contratto Preliminare è lo strumento che garantisce l'efficacia forzata dell'obbligo di trasferimento delle quote. In ogni caso per ottenere efficacia reale (opponibile alla società e ai terzi) è preferibile inserire le tutele più importanti direttamente nello Statuto della S.r.l., quando possibile Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per L’impresa Avv Aldo Lucarelli
- La Penale contrattuale e la Consistenza negativa nella risoluzione dell’appalto
affrontiamo il tema della consistenza, ovvero il procedimento di calcolo avviato dalla Stazione Appaltante all’esito della risoluzione dell’appalto. Può la consistenza andare in negativo per l’applicazione delle penali contrattuali? Come si applica l’indennizzo assicurativo in caso di consistenza? La "Consistenza" (Conto Finale) non è un semplice conteggio dei lavori eseguiti, ma una liquidazione finale che mette a confronto: 1. Crediti dell'Appaltatore: Il valore delle opere regolarmente eseguite e contabilizzate fino alla data della risoluzione (secondo l'Allegato I.14). 2. Debiti dell'Appaltatore (Oneri Aggiuntivi). Quindi il verbale di consistenza redatto a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore può andare in negativo . • Verbale di Consistenza: ha lo scopo di accertare e quantificare le prestazioni che l'appaltatore ha regolarmente eseguito fino al momento della risoluzione. • Viene anche redatto l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che restano a disposizione della Stazione Appaltante (SA). • Calcolo del Credito/Debito: A seguito della risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, la Stazione Appaltante procede al calcolo delle somme dovute, che includono: 1. Il valore delle opere regolarmente eseguite (quantificate nel verbale di consistenza). 2. Le eventuali somme dovute a titolo di risarcimento del danno e/o penali (se previste dal contratto). 3. Altre possibili pretese della SA (es. costi per la nuova esecuzione in danno, ecc.). La Penale contrattuale e la Consistenza negativa nella risoluzione dell’appalto Arriviamo al nostro caso ovvero Il Saldo Negativo (Consistenza in Negativo): • L'appaltatore ha diritto al pagamento solo del valore delle prestazioni già regolarmente eseguite e dei materiali utili. • Da tale importo, la Stazione Appaltante ha il diritto di detrarre (trattenere) le somme liquidate a titolo di penali e/o risarcimento del danno subite a causa dell'inadempimento dell'appaltatore (es. per il ritardo o la mancata conclusione dell'opera). • ove l'importo totale delle penali, dei risarcimenti e degli altri oneri a carico dell'appaltatore (di cui la SA ha diritto di trattenuta) supera il valore delle prestazioni eseguite (il credito dell'appaltatore), il saldo finale del rapporto contrattuale risulterà negativo per l'appaltatore. In questo caso, l'appaltatore non solo non riceverà alcun pagamento, ma sarà debitore della Stazione Appaltante per la differenza. In sintesi, la consistenza in negativo non è un atto di per sé, ma è il risultato contabile che si ottiene quando, dal credito dell'appaltatore per le opere eseguite, vengono sottratte le passività a suo carico, in primis le penali e i risarcimenti dovuti alla Stazione Appaltante. Gli articoli di riferimento sono l’art 108 del d.lgs 50/2016 del vecchio codice, oggi sostituto dalle procedure dell’articolo 122 del d.lgs 36/2023 in tema di “risoluzione per inadempimento” a cui si aggiunge l’articolo 126 in tema di penale . Ma come si calcola l’indennizzo assicurativo? L'indennizzo assicurativo ovvero la Cauzione Definitiva (Art. 117 del D.Lgs. 36/2023), è tipicamente prestata tramite polizza fideiussoria assicurativa. La Cauzione Definitiva (solitamente pari al 10% dell'importo contrattuale) ha la funzione esplicita di garantire la Stazione Appaltante contro gli oneri derivanti dall'inadempimento e dalla Le fasi sono così sintetizzabili: 1. Accertamento del Debito: Il DL/DE e il RUP redigono lo Stato di Consistenza e, successivamente, il Conto Finale definitivo. Questo documento accerta l'ammontare preciso del debito dell'appaltatore verso la SA (o della perdita netta della SA). 2. Escussione della Cauzione: Se il Conto Finale risulta negativo per l'appaltatore, o se comunque la SA ha subito dei danni (es. costi per il completamento) che non può recuperare sui crediti residui dell'appaltatore, la SA attiva la procedura di escussione della cauzione definitiva, notificando alla compagnia assicurativa (o alla banca) l'inadempimento e il danno subito. 3. Finalità dell'Indennizzo: L'indennizzo (cioè il pagamento da parte della compagnia assicurativa) serve a coprire il gap finanziario. La SA utilizza la somma garantita dalla polizza per: • Coprire le penali maturate non ancora trattenute. • Coprire le maggiori spese sostenute per affidare l'esecuzione dei lavori a un terzo. • Coprire eventuali altri danni risarcibili previsti dal contratto. La SA ha l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno subito per poter escutere la cauzione. La somma erogata dalla compagnia assicurativa non può superare l'importo garantito dalla polizza (ad esempio, il 10% del contratto) ed è destinata a coprire il saldo passivo emerso dal procedimento di Consistenza. In breve: il risultato negativo del calcolo di Consistenza (Conto Finale) è la prova del danno che la Stazione Appaltante utilizza per richiedere l'indennizzo alla compagnia che ha emesso la Cauzione Definitiva. Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per l’impresa Avv Aldo Lucarelli
- Deblistering farmacia e Case di Cura
Il deblistering in farmacia opportunità per la farmacia, impegno aggiuntivo per le RSA e Case di cura Affrontiamo il tema del deblistering in farmacia in relazione al caso-scuola di un rapporto con una Casa di Cura con una pluralità di pazienti Il servizio di Sistema di Dosaggio Personalizzato (SDP), o deblistering, in una Casa di Cura (o Casa di Riposo/RSA) richiede una chiara documentazione per garantire la sicurezza del paziente, l'autorizzazione al riconfezionamento e il rispetto della normativa sulla privacy. Leggi i casi nel sito dedicato alle farmacie Il farmacista deve acquisire un'autorizzazione esplicita da parte del diretto interessato, in quanto si tratta di un servizio sanitario che coinvolge il trattamento dei suoi dati personali e la modifica della confezione originale del farmaco. • Consenso Informato al Servizio SDP e Informativa Privacy Passo due: Il servizio SDP si basa sul Piano Terapeutico del paziente e non può essere avviato senza l'assenso e la chiara definizione della posologia da parte del medico. • Prescrizione/Piano Terapeutico Dettagliato : Documento ufficiale del medico (Medico di Medicina Generale/MMG, specialista o medico responsabile della struttura) che attesta la terapia in corso e la posologia esatta (dose, via, frequenza e orario di somministrazione) per ogni singolo farmaco. • Autorizzazione alla Gestione Esterna (Implicita/Esplicita): In alcuni contesti, è richiesto un atto che attesti che il medico curante è a conoscenza e autorizza la gestione della terapia tramite SDP esterno (farmacia), accettando la collaborazione tra farmacia e staff della Casa di Riposo. Spesso questo è implicito nella prassi o in accordi di servizio, ma è sempre preferibile una chiara comunicazione. Deblistering farmacia e Case di Cura Deblistering farmacia e Case di Cura il problema di un accodo quadro chiaro e la necessità di un protocollo L’ accordo con casa di cura: Poiché il servizio è erogato in collaborazione con la struttura, devono esserci atti che formalizzino l'accordo e le procedure operative. • Accordo/Contratto di Servizio (Farmacia-Struttura) Si tratta di un atto formale che definisce i termini della collaborazione tra la farmacia e la Casa di Riposo. Questo documento dovrebbe ( ad avviso di chi scrive e salvo ratifica o osservazioni in sede Regionale ) includere: • Le responsabilità specifiche del farmacista e del personale infermieristico/sanitario della struttura (ad esempio: chi ordina, chi riceve, chi conserva, chi somministra). • Le Procedure Operative Standard ( POS) per la gestione, lo stoccaggio, la somministrazione e la gestione dei farmaci non riconfezionabili o di scorta. • Elenco Pazienti Aderenti : Un elenco della struttura che attesta quali ospiti hanno espresso il consenso e usufruiscono del servizio SDP tramite quella specifica farmacia, permettendo al personale sanitario interno di operare correttamente. Hai un caso? Contattaci • Documentazione di Tracciabilità : La farmacia deve conservare i fogli di lavorazione del riconfezionamento, in conformità con le Norme di Buona Preparazione (NBP) modalità inerenti gli aggiornamenti delle prescrizioni. In sintesi, l'approccio è triangolare: 1) Consenso del Paziente, 2) Prescrizione del Medico e 3) Accordo formale con la Struttura (che dovrebbe dotarsi di un suo protocollo) Per la Casa di Riposo o RSA, l'atto più importante per il farmacista è l'Accordo/Contratto di Servizio siglato con la Direzione della Struttura. Tale documento non solo formalizza la collaborazione, ma stabilisce le procedure e le responsabilità, essenziali in un contesto residenziale. Leggi i casi per la farmacia sul blog dedicato Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Risarcimento del danno per errore medico al coniuge separato
Errore medico risarcimento del danno in caso di separazione, cosa prevede la giurisprudenza? In tema di responsabilità per errore medico , il coniuge superstite ha diritto al risarcimento del danno collegato al rapporto di famiglia/parentela anche ove sussista una separazione dal coniuge che ha subito il danno, e nel caso di specie, era deceduto. La sussistenza di una separazione infatti non collide con il diritto al risarcimento del danno parentale, spetta infatti al danneggiante, il questo caso il medico, dimostrare l’assenza o la dissoluzione del rapporto. Si applicheranno in tal caso le presunzioni di legge (art 2727 cc) per arrivare al rapporto affettivo. Leggi pure: Il risarcimento del danno da Malasanita responsabilità del medico e della struttura responsabilità per errore medico e separazione Questo il principio sancito dalla Cassazione 2025 n.31373 che ha sottoeago come sia irrilevante la sussistenza di una separazione tra coniugi al fine di escludere il risarcimento del danno parentale. Leggi il blog trova il tuo caso o contattaci Spetterà invece al danneggiante l’onere di provare (eventualmente) l’assenza di qualche legame affettivo. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Il risarcimento danni e l’incertezza eventistica
Affrontiamo il delicato e complesso tema del risarcimento danni da perdita di chance alla luce delle coordinate del Consiglio di Stato e della Cassazione ove vi sia quel grado di incertezza definita come Incertezza eventistica o probabilistica. Il risarcimento dell’evento incerto e probabile Nella struttura dell’illecito civile, la chance si colloca nell’ambito dell’accertamento nesso di causalità materiale ed è una figura sostanzialmente elaborata per garantire una forma di ristoro nei casi in cui, applicando la regola del “più probabile che non” (c.d. probabilità cruciale), non sia raggiunta (o non sia possibile raggiungere) la prova che quella determinata condotta è causa dell’evento di evento. La giurisprudenza civile ha affrontato il tema della chance, soprattutto nel campo della responsabilità medica, seguendo impostazioni ermeneutiche differenti. La prima impostazione è costituita dalla tesi cd. eziologica che identifica la chance con un “bene astratto” e futuro, ossia un bene che il danneggiato avrebbe probabilmente ottenuto se non vi fosse stato il comportamento illecito altrui, appunto un’occasione persa: essa si configurerebbe, pertanto, come un mezzo per dimostrare in modo meno rigoroso, ove sia particolarmente difficile fornire la prova, il nesso intercorrente tra la condotta illecita e l’evento. Leggi il blog e trova il il tuo caso altrimenti contattaci In questa logica, la chance viene pertanto riportata nell’ambito del lucro cessante, e non del danno emergente, e viene ad integrare, oltre ad una particolare tipologia del cd. “danno futuro”, anche un sostanziale escamotage per superare le difficoltà dell’accertamento del nesso di causalità in ordine ad un evento finale auspicato dal danneggiato. Del tutto diversa l’impostazione della cd. tesi ontologica che, al contrario, identifica la chance con un bene che esiste nel patrimonio del danneggiato e che va risarcito quale danno attuale da tenere distinto dal bene finale che l’interessato aspira a ottenere o a conservare; in questo caso, il danno sarà pertanto da riportare alle categorie del danno attuale e del danno emergente ed il danneggiato dovrà provare, sotto il profilo causale, la lesione della chance , nella sua effettiva consistenza e nella sua derivazione causale dal comportamento del danneggiante e non la probabilità del cd. danno finale (in questi termini, sarebbe risarcibile, quale bene giuridico autonomo, la mera possibilità di raggiungere il risultato sperato). Entrambe le tesi non sono esenti da critiche. Ai sostenitori della c.d. chance eziologica si obietta di aver sovrapposto inammissibilmente la dimensione della causalità con quella dell'evento di danno, mentre a quelli della c.d. chance ontologica si contesta la creazione di una impredicabile fattispecie di danno in re ipsa , che prescinde del tutto dall'esistenza e dalla prova di un danno-conseguenza risarcibile. In questo contesto si inserisce una terza tesi, sostenuta recentemente dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993), che, nel condividere le critiche mosse alla teoria eziologica ed ontologica, ha proposto un nuovo sistema di classificazione della chance , introducendo la dicotomia chance patrimoniale - chance non patrimoniale: - la chance patrimoniale presuppone un interesse pretensivo e postula la preesistenza di un quid su cui incide la condotta sfavorevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione in senso migliorativo (il partecipante ad un concorso, ad esempio, è portatore di una preparazione che preesiste all’intervento soppressivo del preposto esame). - la chance non patrimoniale è connessa a diritti della persona, ha natura non pretensiva e opera in particolare nell’ambito della responsabilità sanitaria (l’intervento del sanitario sul quadro patologico del paziente crea una chance prima ancora che, eventualmente, pregiudicarla colpevolmente e, quindi, la condotta dell’agente si colloca su un piano di pregressa condizione sfavorevole non suscettibile di costituire un quid inteso quale preesistenza favorevole) Scopri i casi in tema di civile e risarcimento danni Per integrare gli estremi del danno risarcibile, secondo la Suprema Corte, “ la perdita di chance dovrà peraltro attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (la sottrazione di un biglietto della lotteria appare irrilevante a fini risarcitori), senza che ciò costituisca (come erroneamente opinato talvolta in dottrina) una "contraddizione in termini costituita dalla possibilità di istituire un nesso causale fondato sul più probabile che non con un evento di danno rappresentato da una possibilità non probabile", essendo evidente, in tale ricostruzione, la confusione concettuale tra l'analisi del nesso eziologico e quella dell'evento di danno lamentato. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, non come regola (a)causale, ma come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento ” (sent. n. 28993/18 cit). Leggi il blog e trova il tuo caso La Suprema Corte, dunque, dopo aver superato la distinzione tra chance ontologica e chance ontologica, ha chiarito che la chance di tipo patrimoniale si caratterizza per la presenza degli ordinari elementi costitutivi della responsabilità civile, ma con la rilevante particolarità rappresentata dal fatto che essa trae origine, in presenza di peculiari fattispecie, da quella che la Cassazione definisce “ incertezza eventistica ”. Nel solco di detta nuova impostazione, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “ la prova del danno da perdita di chance si sostanzia: a) nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni; b) nell’accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno, con la precisazione che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l’incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata) ” (così, Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2023, n. 25910). Mentre nel diritto privato le ipotesi più ricorrenti riguardano la responsabilità medica (quando si imputa la mancata attivazione di una cura o intervento sanitario il cui esito sarebbe stato tuttavia incerto), nel campo del diritto amministrativo la lesione della chance viene invocata per riconoscere uno sbocco di tutela (sia pure per equivalente) a quelle delle aspettative andate irrimediabilmente deluse a seguito dell’illegittimo espletamento (ovvero del mancato espletamento) di un procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2021, n. 6268). In particolare, il tema della chance è stato affrontato in diritto amministrativo , tenendo conto della specificità dell’illecito civile della pubblica amministrazione che, sotto il profilo strutturale, si caratterizza per le particolari modalità di prova del danno ingiusto, ovvero la dimostrazione della spettanza del bene della vita, da accertare secondo la logica del “più probabile che non” (sono ancora attuali le “parole” della Suprema Corte che, nella storica sentenza n. 500/99, subordinò la ristorabilità dell’interesse legittimo, oltre che al riscontro dell’illegittimità dell’atto lesivo, alla formulabilità di “ un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno dell’istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta ”). In caso di illegittimità del provvedimento vincolato (salvo che per vizi meramente formali o procedimentali), il giudizio di spettanza del bene della vita è senza dubbio più agevole, non incontrando il giudice i limiti del sindacato di merito dell’atto amministrativo. In caso di annullamento di un provvedimento discrezionale o tecnico-discrezionale, invece, laddove residuino margini valutativi in capo alla pubblica amministrazione procedente, al giudice è impedito il c.d. giudizio prognostico e, solo all'esito del satisfattivo riesercizio del potere, potrà dirsi accertata la spettanza del bene della vita. Vi sono tuttavia dei casi in cui, dopo l’annullamento dell’atto, alla pubblica amministrazione è oggettivamente impedita la riedizione del potere amministravo, con conseguente impossibilità di effettuare il giudizio di spettanza del bene della vita. Di fronte a tale evenienza, la giurisprudenza amministrativa è, parimenti a quella civile, divisa tra la teoria ontologica ed eziologica (la questione era stata portata anche all’attenzione dell’Adunanza Plenaria, che, tuttavia, con sent. n. 7/2018, non l’ha definita, restituendo gli atti alla Sezione remittente). Ritiene tuttavia il Collegio che il tema della risarcibilità della chance andrebbe vagliato alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, che, come su osservato, individuano l’ ubi consistam della particolare figura giuridica in esame nella c.d. incertezza eventistica (in questi termini, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2024, n. 2647). L’incertezza eventiatica ed il risarcimento danni L’icastica espressione utilizzata dalla Suprema Corte può essere “calata” nel diritto amministrativo, per vagliare profilli di ristorabilità dell’interesse legittimo nei casi in cui, in nuce , sia impossibile effettuare il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita secondo il rigido schema causalistico del “più probabile che non”. Questa nuova “dimensione” del danno da perdita di chance può trovare cittadinanza anche nel settore della responsabilità civile della pubblica amministrazione, sempre che ricorrano i seguenti i seguenti elementi costitutivi: a) una condotta colpevole dell'agente; b) un evento di danno, consistente nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza della possibilità perduta di conseguire il bene della vita finale; c) la relazione causale tra tale condotta e l’evento di danno (dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità; in altri termini, deve essere possibile formulare un giudizio di “spettanza della chance”), mentre l’incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità di conseguire il bene della vita si sarebbe comunque realizzata; dunque può dirsi che è incerto, sul piano eventistico, il giudizio di spettanza del bene della vita finale); d) una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non, che devono essere derivanti in modo diretto e immediato dal fatto lesivo (c.d. casualità giuridica). Così ricostruiti i termini del dibattito, va altresì osservato che la domanda risarcitoria per la perdita di chanc e è, per l’oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato (la posizione della giurisprudenza, limitatamente a detto aspetto, appare ormai consolidata, come da ultimo affermato da Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2024, n. 2892). Tornando dunque all’esame dell’azione risarcitoria, occorre evidenziare che la domanda della ricorrente ha ad oggetto il danno evento identificato nel mancato conseguimento del bene della vita finale (ovvero il conseguimento di una miglior canale) e non già quello derivante dalla definitiva perdita della possibilità di raggiungerlo. Del resto, soltanto con l’adozione della gravata nota, che di fatto ha definitivamente consumato il potere del Ministero di pronunciarsi sulla travagliata vicenda in esame, si è cristallizzata l’impossibilità di formulare il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, nei termini in precedenza chiariti dal Collegio. Pertanto, in questo quadro di irrisolvibile “incertezza eventistica”, stante l’assenza di una base conoscitiva solida che consenta di effettuare una gara virtuale vera e propria, e, conseguentemente, di formulare in nuce il giudizio di spettanza del bene della vita, la domanda risarcitoria, così come allo stato formulata dalla ricorrente, non può essere accolta Tar Lazio 8785/2025. Assistenza legale in giudizi di ogni ordine e grado . Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci
Una farmacia nata da concorso o una farmacia con soci paritari, come può liberarsi ⛓️💥 dalle catene di una gestione insoddisfacente e liquidare i soci scomodi? Spesso per liquidare i soci il problema maggiore risiede nella ricerca dei fondi necessari e nella compatibilità che un’operazione del genere possa avere a livello farmaceutico e fiscale. Nel presente post affrontiamo il caso della trasformazione della farmacia con scopo di finanziamento e liquidazione dei soci scomodi L’ipotesi di partenza é la semplice trasformazione da Snc ad Srl seguita dalla vendita delle quote. Ne abbiamo parlato in altro post. Ma la semplice trasformazione da Snc a Srl, seguita dall'acquisto delle quote dei soci uscenti da parte della società, spesso fallisce perché non permette di far emergere l'avviamento (creando problemi di patrimonio netto) o perché la società non ha riserve sufficienti per l'acquisto di azioni proprie. Leggi pure Trasformazione della farmacia problemi e limiti operativi La soluzione tecnica più efficace in questo caso è strutturata come un Merger Leveraged Buyout (MLBO) usato in ambito commerciale e bancario con imprese che hanno grandi flussi di cassa (cash flow) ma adattato (ad avviso di chi scrive) anche alla realtà della farmacia e delle situazioni medie, sopratutto per quelle farmacie post concorso straordinario che vogliono “liberarsi” degli associati/soci non più interessati alla gestione della farmacia (dopo i tre anni) Leggi pure Concorso straordinario farmacie e la prescrizione dell’azione risarcitoria Lo scopo nel presente caso é quello di liquidare i soci con fondi esterni garantendo la tenuta patrimoniale e fiscale della farmacia. Vediamo nel dettaglio tale strada: A) il punto di partenza é la creazione di una nuova società chiamata New Company (NewCo) nella forma della Srl e valutare di procede ad una fusione inversa con la nostra farmacia. Consulta il sito dedicato alla farmacia Vedremo perché questo metodo può essere idoneo al nostro scopo rispetto ad altri. B) La Nuova società (poco capitalizzata) potrà quindi chiedere un finanziamento bancario , a società del settore che conoscono la redditività dell’operazione. Non perdetevi d’animo se la banca sotto casa non approva l’operazione, vi sono esperti del settore che ben conoscono le potenzialità dell’operazione per la stabilità dei flussi di cassa garantiti dalle #farmacie, a tal proposito un business plan vi sarà di aiuto. Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci arriviamo quindi alla fase C) ovvero l’acquisizione delle quote. La Srl acquisterà il 100% delle quote della Snc (o la maggioranza di controllo). Seguici on Line Con tali 3 semplici passaggi si potranno liquidare i soci e la 💊 farmacia Snc diventerà una controllata al 100% della Nuova Srl. Abbiamo quindi liquidato gli ex soci/associati ma dobbiamo ora procedere alla incorporazione della farmacia nella Srl, quindi procediamo alla “fusione per incorporazione” . La situazione di arrivo in questa fase é quella di una nuova Srl che ha incorporato la Snc, dopo aver acquisto le sue quote. Il prezzo pagato dalla Srl spesso é un valore alto, che ha in sé un valore di mercato molto più alto del valore contabile (patrimonio netto contabile della Snc), avremo quindi nel bilancio post-fusione, una differenza contabile chiamata “ Disavanzo da fusione”. Ricordiamo infatti che il problema che ci é stato chiesto di affrontare riguarda la liquidazione di soci della Farmacia Snc con capitali che al momento non erano disponibili nella società e che sono stati creati con un finanziamento esterno. Qualcuno chiederà, ma perché non é stato contratto un finanziamento direttamente dalla Farmacia? L’apertura diretta di un finanziamento per liquidare i soci avrebbe creato un enorme debito a fronte di attività contabili basse (i mobili e le scorte), rischiando di erodere il capitale (art. 2482 ter c.c.). Con la fusione invece il disavanzo da fusione viene imputato nell'attivo dello Stato Patrimoniale della Srl come Avviamento Il tutto ai sensi dell’ 2504-bis comma 4 Codice Civile (fusione e disavanzi) ed Art. 2426, punto 6 Codice Civile inerente i criteri di valutazione e ammortamento dell’avviamento. Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci, quale é il risultato di questa operazione? Avremo ottenuto un finanziamento nel passivo, ma anche un grosso asset (l'Avviamento) nell'attivo della nostra Srl con un Patrimonio Netto positivo ed in equilibrio. Arriviamo quindi al secondo problema ovvero quello dell'Ammortamento Fiscale dell’avviamento. Civilisticamente l'avviamento emerso dal disavanzo è iscrivibile. Tuttavia, fiscalmente è neutrale (non deducibile) a meno che non si compia un atto specifico, ma quale? L’affrancamento del disavanzo pagando un’imposta sostitutiva sui valori affrancati e ottenendo la possibilità di ammortizzare fiscalmente l’avviamento. (15, comma 10-ter, del DPR 917/1986 ) lo scopo é quello di far diventare fiscalmente deducibile l’ammortamento dell’avviamento iscritto civilisticamente. Una volta affrancato, l'avviamento è ammortizzabile (generalmente in 18 anni). Farmacia ed Impresa due facce della stessa medaglia Andiamo verso la fine del percorso, il debito è ora in pancia alla Srl operativa (la farmacia). I flussi di cassa generati dalla vendita dei farmaci verranno utilizzati per pagare le rate del mutuo fatto per liquidare i soci. Poiché gli interessi passivi sono deducibili (ma entro il limite del 30% del ROL), si ottiene un ulteriore vantaggio fiscale. Conclusivamente nel lungo percorso descritto abbiamo 1) liquidato i soci, 2) trovato fondi esterni alla #farmacia, 3) mantenuto un equilibrio fiscale, 4) gestito la società trasformandola in una impresa più snella e trasparente. Per una alternativa a questa strada lunga ma interessante 🧐 vi sarà un altro post, leggi il blog in diritto societario e e farmaceutico e trova il tuo caso o contattaci Un consiglio pratico, operazioni societarie hanno un senso ove vengano pianificate con cura in anticipo sia in termini di costi che di sostenibilità futura. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Non costituisce consulenza
- Concorso Farmacie il danno da mancata apertura
Tornano sempre le stesse domande sui dubbi da concorso straordinario e sugli strascichi delle aperture e delle mancate aperture. ma se avevamo vinto la farmacia ed uno degli associati si è tirato indietro, questo comportamento è fonte di danno da responsabilità? Se si di quale tipo di responsabilità si tratta? In quanto tempo si prescrive l'azione al risarcimento danni? Ma se è passato molto tempo dalla partecipazione del lontano 2013, come associato ero obbligato comunque ad aprire con gli altri associati? Tante domande a cui negli anni abbiamo sempre risposto, ora passando il tempo se ne aggiunge una ancora piu' interessante, Quanto tempo ho per fare causa all'associato che si è tirato indietro dall'associazione facendo perdere il diritto all'apertura di tutta l'associazione? Scopri il sito sul diritto farmaceutico ed i casi per farmacie e farmacisti Premesso quanto chiesto ora vediamo quanto segue. Secondo la giurisprudenza, il rapporto associativo in un concorso ha natura di rapporto di natura contrattuale. Ciò porta con sé alcune semplici e "drastiche" deduzioni in ordine alla responsabilità ed al tempo di prescrizione, per quello che segue. Si deve infatti osservare che il dott. Tizio il dott. Caio ed il dott. Sempronio nel lontano 2013 si erano uniti per partecipare al concorso farmacie sulla base di un vincolo associativo basato su matrice pubblica, ovvero un bando valido ed efficace, quindi sarà difficile sostenere che i rapporti tra loro non fossero correlati da un rapporto di natura contrattuale, sancito per l'appunto dall'associazione. Se quindi si tratta di rapporto di natura contrattuale andrà da sé che il mancato perfezionamento dell'apertura di una sede, per il recesso ad nutum (cioè ingiustificato) di un associato, sarà fonte di responsabilità ovvero di danno per gli altri rimasti coinvolti nella non apertura per il comportamento dell'associato "ribelle". Ma di quale danno? un danno di natura contrattuale, per l'appunto la cui prescrizione è di 10 anni dal fatto e non di soli "5" come se fosse stato un danno tra estranei, ovvero di un danno da responsabilità aquiliana ex art. 2043. Farmacie da concorso straordinario, il danno da mancata apertura a causa dell'associato Farmacie da concorso straordinario, il danno da mancata apertura a causa dell'associato Sui punti sopra esposti abbiamo qualche cenno di giurisprudenza che sembra confermare tutti i nostri sospetti. ed infatti secondo il Tribunale di Napoli "... Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata, sebbene la fattispecie in esame vada ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale." E' invero pacifico il principio secondo cui il giudice ha la facoltà di qualificare come contrattuale od aquiliana la domanda di risarcimento del danno, a prescindere dall'inquadramento adottato dall'attore ed alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio. Al riguardo la Suprema Corte con recente pronuncia ha, infatti, affermato che “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il Ministero della ### a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l'infezione sebbene l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento extracontrattuale)”(cfr. Cass sent. n. 10049/2022). Hai un caso? leggi il blog o contattaci Ciò posto, in termini generali si osserva come il nostro ordinamento giuridico preveda due diverse ipotesi di responsabilità civile: la responsabilità contrattuale , derivante dall'inadempimento di un'obbligazione assunta e disciplinata dall'art. 1218 cc, il quale dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” e la responsabilità extracontrattuale per violazione del principio del neminem ledere, disciplinata dall'art. 2043 cc secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. segui la pagina on line Giova evidenziare come, contrariamente a quanto avvenga con la responsabilità extracontrattuale, che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, ma solamente un comportamento che abbia violato il principio generale del neminem ledere, la responsabilità contrattuale basi la propria natura proprio sulla esplicita violazione di uno specifico dovere, che deriva da un vincolo obbligatorio sussistente tra le parti e rimasto inadempiuto. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti, in caso di responsabilità contrattuale al creditore spetterà provare solo l'inadempimento del debitore ed il danno dallo stesso cagionato, mentre spetterà al debitore, al fine di sottrarsi dal risarcimento, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Fatte tali necessarie premesse, ritiene il Tribunale che, nella specie, tra le parti in lite si fosse perfezionato un accordo associativo finalizzato alla partecipazione, nella modalità della forma associata, al bando di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche indetto con determina, la cui prova è data dalla stessa presentazione delle domande di partecipazione al bando in modalità di partecipazione associata da parte delle tre candidate, con indicazione della referente del gruppo nella persona di (cfr. domande partecipazione concorso) . Concorso Farmacie ed il vincolo scaturente dalla partecipazione Con la presentazione delle domande di ammissione al concorso in forma associata deve, pertanto, ritenersi sorto un vincolo obbligatorio tra le parti in relazione all'espletamento della indicata procedura concorsuale, la cui normativa - espressamente richiamata dal bando - prevedeva la sussistenza del gruppo per l'assegnazione della sede farmaceutica e per il suo mantenimento nel successivo periodo decennale, salvo forza maggiore, morte o sopravvenuta incapacità. ..." (cfr. Trib. Na. n. 10792/2022 del 02-12-2022) Ed il danno.. "... Da ultimo, deve ritenersi altresì sussistente il danno subito dalle attrici a seguito del recesso dalla partecipazione al concorso da parte della convenuta e consistente segnatamente nella mancata assegnazione della sede farmaceutica al gruppo associato rispetto alla quale si erano posizionate utilmente nella graduatoria definitiva. Quindi: Alla luce di quanto sopra esposto, va affermata la responsabilità contrattuale della convenuta per la mancata assegnazione alle attrici della sede farmaceutica di cui al concorso indetto .. (concorso straordinario farmacie indetto ai sensi dell'art. 11 DL 24 gennaio 2012 n. conv. in L. 24 marzo 2012 n. 27) e per il quale le parti avevano presentato domanda in modalità di partecipazione associata, con il conseguente diritto delle attrici al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede. ..." Conclusivamente sebbene il concorso sia terminato in quasi tutta Italia, gli strascichi delle sue vicende avranno vita per lo meno sino a che l'ultimo decennio dal fatto non sarà scaduto! Seguici per novità ed aggiornamenti in diritto farmaceutico. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli Il post è un caso studio, frutto del pensiero del proprio autore, non è una guida né una consulenza,