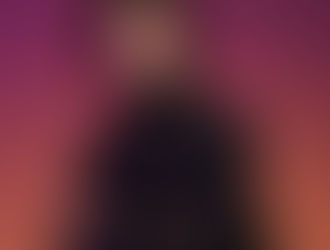Risultati di ricerca nel sito
716 risultati trovati con una ricerca vuota
- Concorso Ordinario farmacisti e vincolo dei 10 anni
È incontestato il principio della incompatibilit à tra aspirazione alla assegnazione di una delle sedi oggetto di concorso e cessione della sede già in titolarità – scolpito dalla previsione del bando di concorso (punto 2, comma 6) secondo cui costituiva requisito di partecipazione quello di “ non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni” alla data di scadenza del termine di presentazio ne della domanda, in relazione al quale la nota 4 prevedeva che “tale condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede”. Leggi pure: L’associazione di farmacisti Dispone il punto 11 del bando che, durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate nel termine di quindici giorni, quelle non aperte entro sei mesi dalla data di accettazione “ nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori ” siano assegnate scorrendo la graduatoria medesima (in ciò ricalcando il disposto dell’art. 11, comma 6, d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012). Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Nella nota 13 del predetto art. 11 è poi precisato che, per sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori, “si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione/apertura di una delle sedi previste dal bando di concorso straordinario , vinta da un farmacista già titolare di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria”. Concorso Ordinario farmacisti e vincolo dei 10 anni La clausola di cui al punto 11 del bando, letta unitamente alla relativa nota esplicatrice, rende evidente che le sedi già nella titolarità dei partecipanti al concorso straordinario , una volta che questi abbiano acquisito la titolarità di una delle sedi oggetto del medesimo concorso straordinario ( per effetto della assegnazione/accettazione della stessa ), sono sottratte alla loro disponibilità (in virtù del principio generale che preclude la titolarità contestuale di un duplice esercizio farmaceutico) , essendo destinate ad ampliare il bacino delle sedi suscettibili di assegnazione sulla scorta dello scorrimento della graduatoria concorsuale. Il riferimento contenuto nella nota 4 al punto 2.6 del bando di concorso, quindi, alla “assegnazione” della sede oggetto di concorso straordinario, quale (apparente) dies ad quem del regime di incedibilità dell’esercizio farmaceutico (a pena di esclusione dal concorso straordinario), lungi dall’essere interpretabile quale ponte di transizione al diverso regime di piena disponibilità, costituisce il punto di saldatura con la regola di indisponibilità collegata alla (essa, sì, diversa, rispetto a quella ispiratrice del precedente regime di incedibilità , a pena di esclusione dal concorso) ratio della destinazione delle sedi “resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori” ai concorrenti beneficiari dello scorrimento della graduatoria di concorso. Leggi pure: "Le scure del TAR sulla trasformazione della Farmacia" La nota 13, laddove fa riferimento alle sedi che “si rendono vacanti a seguito di accettazione/apertura di una delle sedi previste dal bando di concorso straordinario…”, correla causalmente la vacanza della sede, quale presupposto per la sua assegnazione in virtù dello scorrimento della graduatoria, alla “accettazione/apertura” della sede oggetto di concorso straordinario. Tale interpretazione è conforme al disposto di cui all’art. 112, comma 3, R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934. Deve infatti osservarsi che, nelle more dell’autorizzazione/apertura della farmacia assegnata all’esito del concorso straordinario, si realizza un effetto di indisponibilità del precedente esercizio farmaceutico, destinato a mettere capo alla decadenza della corrispondente autorizzazione per effetto della acquisizione della nuova: sì che gli eventi che dovessero verificarsi nelle more tra l’assegnazione/accettazione ed autorizzazione/apertura della nuova sede, tali da determinare l’impossibilità di apertura di quest’ultima, rileverebbero come fattispecie risolutiva della assegnazione della sede oggetto di concorso straordinario (coerentemente con il disposto di cui all’art. 11 lett. d) del bando, a mente del quale le sedi non aperte entro sei mesi dalla accettazione sono assegnate secondo la graduatoria ai concorrenti successivi) e, nel contempo, riespansiva del pieno potere dispositivo del titolare della precedente autorizzazione. Del resto, lo stesso art. 112, comma 3, R.D. n. 1265/1934, sebbene faccia discendere l’effetto decadenziale della pregressa autorizzazione dal conseguimento della seconda (“ottenuta la seconda”), fa risalire la fattispecie impeditiva della decadenza alla precedente fase dell’assegnazione. Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Sul piano strettamente logico « non avrebbe senso consentire la partecipazione al concorso straordinario solo al farmacista rurale che non abbia disposto della farmacia nei dieci anni antecedenti al medesimo concorso, per poi legittimare la cessione dopo la sua conclusione (Cons. Stato, sez. III, 3 giugno 2019, n. 3681) Leggi pure Farma Diritto il sito accanto ai Farmacisti Questa ricostruzione avallata dal Consiglio di Stato nel 2024 (3683) é il frutto di un progressivo affinamento della giurisprudenza dal 2012 anno di avvio del maxi concorso straordinario ed ora sarà il punto di partenza dei nuovi concorsi ordinari nei quali andrà chiarita la questione della ammissibilità di coloro che hanno ceduto la precedere sede ( in chiave personale o da società di persone) rispetto a coloro che invece derivano dalla mera cessione di quote di Farmacia sotto forma di Srl ai quali é difficile attribuire (salvo smentite) una simile sanzione stante la non coincidenza tra Farmacia azienda autorizzata e singola partecipazione minoritaria. Hai un quesito leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Subappalto casi pratici
affrontiamo su richiesta di un nostro lettore un tema spinoso per la contrattualistica commerciale e gli appalti, ovvero il subappalto e le differenze con altre tipologie di contratti come la manodopera, la fornitura, ed il lavoro intellettuale. differenza tra subappalto e contratto autonomo Nell’interpretazione dell’art. 105, comma 3, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (secondo cui «non si configurano come attività affidate in subappalto […] l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante») Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema occorre muovere dalla premessa che le prestazioni oggetto di siffatti contratti sono rivolte a favore dell’operatore economico affidatario del contratto di appalto con il soggetto pubblico e non invece direttamente a favore di quest’ultimo, come avviene nel caso del subappalto. L’impostazione del problema in termini di deroga rispetto alla disciplina del subappalto della norma sull’impiego di lavoratori autonomi del medesimo art. 105, comma 3), non tiene conto della differenza specifica che intercorre tra i due tipi di contratti, che emerge anche dalle norme sopra richiamate. L’art. 105, comma 3, cit. non è una norma derogatoria prescrive infatti «Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto […]»). La norma in questione pertanto delimita i confini rispetto alla nozione di subappalto applicabile nella disciplina sui contratti pubblici, ma non è una norma derogatoria del regime sul subappalto (né di natura eccezionale). La distinzione tra le due figure contrattuali (subappalto e lavoro autonomo) si fonda non solo, sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto . Le prestazioni alla base dei due contratti sono infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del subappalto, il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto stipulato con l’amministrazione , sostituendosi all’affidatario; nell’altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario che le riceve, inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all’amministrazione appaltante. Nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono quindi diversi quantomeno sul piano funzionale. Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è immediatamente estendibile, se non si dimostri che il contratto di lavoro autonomo costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto. CdS 4150/2021 Subappalto e fornitura di materiale In merito, che i contratti di subappalto e di fornitura, pur se in qualche caso vicini tra loro, si differenziano comunque nei loro elementi essenziali. La fornitura, disciplinata nell’ambito dello schema legale del contratto di somministrazione di cui all’art. 1159 e ss. del codice civile per le prestazioni di beni, consiste in una forma contrattuale ove una parte si obbliga a eseguire nei confronti di un’altra parte delle prestazioni periodiche o continuative di beni, verso il pagamento di un corrispettivo. Diversamente, il contratto di subappalto di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici descrive quella forma contrattuale in cui un terzo affida l’esecuzione di una parte dell’opera, nella sede di cantiere, a proprio rischio e mediante una propria organizzazione di mezzi e personale Orbene, la distinzione tra le due forme contrattuali ricade sull’assunzione del rischio finale d’impresa: con il subappalto, il subappaltatore si sostituisce all’affidatario della commessa nei confronti dell’Amministrazione, mentre con la vendita o fornitura la prestazione di base, seppur effettuata da altri, è acquisita nella stessa organizzazione aziendale del cliente acquirente o somministrato, il quale si accolla al riguardo il rischio d’impresa discendente da un eventuale difetto o difformità della prestazione. Come ben precisato dal Consiglio di Stato sul punto, “la distinzione tra le figure contrattuali si fonda non solo sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei tipi di contratto. Le prestazioni sono infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del subappalto, il contratto è stipulato con l’amministrazione, sostituendosi all’affidatario; nell’altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario che le riceve, inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all’amministrazione appaltante. Nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; diverso è il caso in cui la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è estendibile, se non si dimostri che il contratto costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4150 e TAR Campobasso 45/2024 L’Amministrazione dovrebbe pertanto dimostrare, la sussistenza nel caso di specie di un contratto di subappalto. Subappalto e contratti di cooperazione e fornitura Ed invero prevede: “Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: … c bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti cooperativi di cooperazione servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”. Ritiene la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V, 19/05/2020, n. 3169; Cons. Stato, V, 24 gennaio 2020, n. 607) che con i “contratti di cooperazione servizio e/o fornitura” la legge faccia riferimento ai contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa ovvero, quei beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento. I terzi contraenti, quindi, non eseguono una parte della prestazione oggetto dell’appalto ma procurano all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per la sua esecuzione. A detti contratti, dunque, l’amministrazione aggiudicatrice resta completamente estranea Porta a questa conclusione in primo luogo la formulazione letterale della disposizione che specifica che le prestazioni dei terzi contraenti sono rese “in favore dei soggetti affidatari”, così individuando chiaramente i destinatari delle prestazioni nelle imprese concorrenti e non nelle stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, V, 27 dicembre 2018, n. 7256; contra Cons. Stato, III, 18 luglio 2019, n. 5068 secondo cui con la formula riportata si allude alla “direzione giuridica della prestazione, ovvero al fatto che l’unica relazione giuridicamente rilevante… è quella esistente tra stazione appaltante e soggetto affidatario” . L’art. 105 del Codice dei contratti pubblici precedente ed oggi l'art. 119 del nuovo codice degli appalti, contiene la disciplina del subappalto; il comma 3 lettera D precisa che non rientrano nel subappalto le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Se il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (comma 2), i contratti di cooperazione continuativa, di converso, non hanno ad oggetto la prestazione affidata , ma quei beni e servizi dei quali l’impresa aggiudicataria necessita per poter, essa sola, eseguire la prestazione oggetto del contratto d’appalto. In definitiva detti contratti si caratterizzano per la “direzione soggettiva”, in quanto resi all’impresa aggiudicataria, e per l’“oggetto del contratto” che è altro rispetto alla prestazione in affidamento con il contratto d’appalto. A prescindere dagli aspetti peculiari di ogni vicenda, infatti i criteri di qualificazione sopra ricordati – direzione soggettiva della prestazione ed oggetto del contratto – consentono di risolvere in maniera sufficientemente attendibile anche i casi dubbi, assumendo carattere dirimente stabilire se l’impresa aggiudicataria, stipulando un contratto di cooperazione continuativa, si sia limitata a procurarsi il bene strumentale alla prestazione da rendere all’amministrazione, ovvero abbia affidato al terzo cooperante l’esecuzione di una parte (o frazione) della prestazione assunta nei confronti dell’amministrazione che non era in grado di eseguire.[…] Pertanto, come già ritenuto dalla Sezione (Cons. Stato Sez. V, 19/05/2020, n. 3169 cit) quando il terzo cooperante (o che svolga servizi o fornisca beni) esegue una parte della prestazione oggetto del contratto d’appalto che l’impresa aggiudicataria non sa o non può eseguire, si è fuori del subappalto, ed è corretta l’esclusione dalla procedura di gara. Pertanto il ricorso al subappalto andava necessariamente indicato in sede di partecipazione alla procedura evidenziale CdS 3856/2023 A ciò consegue che la mancata dichiarazione circa il conferimento in subappalto di una parte rilevante dei servizi oggetto dell’affidamento deve essere necessariamente sanzionata con l’esclusione dalla procedura evidenziale, avuto altresì riguardo alla necessità della stazione appaltante di procedere anche alla verifica in capo alla ditta subappaltatrice del possesso dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 del Codice. Va infatti ritenuto che “consentire ad un terzo cooperante di svolgere una parte della prestazione significherebbe porre l’amministrazione in rapporto con un soggetto del quale non è mai stato accertato il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione previsti dall’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla disciplina di gara” (Cons. Stato Sez. V, 19 maggio 2020 n. 3169 cit). Leggi il blog sull'impresa o contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Società a controllo pubblico e revoca dell'amministratore a chi compete?
La revoca dell'amministratore nella società di capitali a controllo pubblico a chi compete? Il quesito nasce dalla partecipazione pubblica nella società, puo' la partecipazione pubblica di un ente (Comune) derogare alle norme in tema di società di capitali, (SRL/SAPA/SPA) ai fini della revoca dell'amministratore? Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Come vedremo, la risposta è negativa. Ed infatti con specifico riferimento alle società per azioni con partecipazione pubblica , è stata ribadita la giurisdizione del giudice ordinario , quanto alla controversia relativa alla revoca dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c., in quanto trattasi di atto posto in essere dall'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di avvalersi dello strumento societario, emanato avvalendosi degli strumenti che il diritto comune attribuisce al socio e dunque interamente regolato dal diritto privato, come si evince chiaramente dal testo del richiamato art. 2449 c.c., il quale individua nello statuto sociale, e dunque in un atto fondamentale di natura negoziale, la fonte esclusiva dell'attribuzione al socio pubblico della facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla sua partecipazione, con la correlata facoltà di revocarli (Cass. S.U. n. 29078 del 11/11/2019). I principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza (Cass. S.U.n. 16335/2019), oltre che dello stesso Consiglio di Stato (cfr. Adunanza Plenaria 3 giugno 2011 n.10), confermano il fatto che la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto privato solo perché l'Ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni : il rapporto tra società ed ente pubblico azionista è, in altri termini, di assoluta autonomia. Società a controllo pubblico e revoca dell'amministratore a chi compete? Ciò significa che all'ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sugli atti di gestione e sull’attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi , ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario dei quali dispone nella sua qualità di socio. Società a controllo pubblico e revoca dell'amministratore a chi compete? Del resto, il richiamo alla disciplina del codice civile in materia di società di capitali per quanto non diversamente stabilito dalla legge - e salve deroghe espresse -, trova esplicita e chiara conferma normativa nell'art. 4, comma 13, quarto periodo, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, oltre che nell'analogo art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016. Trattasi di previsioni normative che fungono da "clausola ermeneutica generale" di chiusura (in senso privatistico) e che entrambe esprimono rilevanza significativa. Il profilo involgente la disciplina di diritto pubblico, segnato dall'agire dell'ente pubblico come autorità, si esaurisce nella scelta iniziale dell'ente di costituire una società, o di parteciparvi, nel mentre il profilo privatistico è relativo alla adozione, durante lo svolgimento dell’attività sociale, degli atti (c.d. "a valle" di quella scelta iniziale) che l'ente pone in essere avvalendosi degli strumenti che il diritto comune gli attribuisce nella sua qualità di socio. Leggi pure: "Fallimento della SRL e piccoli debiti" Va pertanto riaffermata la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 21299/2017), senza che possa influire sulla correttezza di tale conclusione la circostanza che nella specie la società dalla cui carica è stato revocato l'amministratore era una società a responsabilità limitata, anziché una società per azioni. Tale differenza (SRL/SPA) che, come ricordato da Cass. S.U. n. 4309/2010, non preclude di estendere alle società a responsabilità limitata i principi dettati per le società per azioni a partecipazione pubblica , ove tale partecipazione assuma connotazioni analoghe per le prime, consente di affermare come non sia esigibile un espresso richiamo alla previsione di cui all’art. 2449 c.c., specificamente per le società per azioni con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. Hai un quesito? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli avv.. Aldo Lucarelli
- Criteri di aggiudicazione ed immodificabilità della graduatoria
ll Il principio di invarianza negli appalti ed i criteri di aggiudicazione delle offerte Il principio di invarianza delle medie, quale codificato dall’art. 108 comma 12 del d.lgs. n. 36 del 2023, oggi è come già ereditato dal precedente codice. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Ed invero secondo tale disposto normativo “ Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara ”. Criteri di aggiudicazione ed immodificabilità della graduatoria Scopri il sito su appalti ed impresa Il principio di invarianza negli appalti Tale principio era già espresso – dall’articolo 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 “.. ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.. ”. Il principio di invarianza negli appalti: Come chiarito dalla giurisprudenza nel vigore del previgente codice (Consiglio di Stato, 2021 n. 8460) il principio di invarianza opera nel senso della “ cristallizzazione delle offerte ” e della “ immodificabilità della graduatoria ” ed integra un’espressa eccezione all’ordinario meccanismo del regresso procedimentale per positiva irrilevanza delle sopravvenienze, obbedendo alla duplice e concorrente finalità: Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema a) di garantire, per un verso, continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, cioè di quella soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta si presume senz’altro anomala, situazione che ingenererebbe una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche (cfr. Cons. Stato, V, 22 gennaio 2021, n. 683;); b) di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima, traendone vantaggio (cfr. Cons. Stato, Sez V, 2 novembre 2021, n. 7303;). Il principio di invarianza è pertanto finalizzato anche a tutelare l’affidamento medio tempore maturato dai partecipanti alla gara ed è volto altresì a salvaguardare l’interesse delle amministrazioni alla stabilità degli assett i definiti e consolidati dalla chiusura di alcune fasi di gara, con riguardo alla determinazione della soglia di anomalia e al calcolo delle medie per i punteggi attribuiti alle offerte. Ciò, nonostante l’eventuale successiva esclusione di taluno dei concorrenti e nonostante l’evidente rischio che, nelle more della partecipazione, la permanenza in gara del concorrente in seguito escluso abbia sortito taluni effetti in punto di determinazione delle medie o delle soglie di anomalia. Leggi il blog in appalti La ratio di tale principio, quale ricostruito dalla giurisprudenza, consiste pertanto, come già accennato in precedenza, nel neutralizzare il rilievo sul piano procedimentale di tutte le vicende che seguono la fase di verifica preliminare delle offerte, al fine di sterilizzare “ l’alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente correlata alla partecipazione di fatto di un concorrente solo successivamente estromesso della gara ” (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013). Peraltro vi è da evidenziare che l’irrilevanza delle modifiche successive è stata nel nuovo codice riferita alla aggiudicazione definitiva, in continuità peraltro con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo il quale con il principio di invarianza della soglia di anomalia, la legge intende evitare la retrocessione della procedura di gara fino alla (ri)determinazione della soglia di anomalia delle offerte (ossia della soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta si presume senz’altro anomala), quando, già intervenuta l’aggiudicazione del contratto, sia disposta, anche in via giudiziaria, l’esclusione dell’aggiudicatario (o di altro concorrente) per carenza dei requisiti di partecipazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2019, n. 572). Si è chiarito, infatti, che la "fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte" a conclusione della quale, ai sensi dell'art. 95, comma 15, citato, non è più consentita la modifica della soglia di anomalia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2020, n. 7332 e CdS 5319/24) Contattaci per un tuo caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia Società di Persone ed Amministratore non farmacista
Puo' una Società di farmacisti nella forma di società di persone avere un amministratore che non sia né socio né farmacista? Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Il quesito apparentemente semplice ci è giunto all'attenzione in quanto nella questione prospettata la Farmacia è gestita da associati farmacisti nella forma della società di persone e non di una SRL e, sebbene sia gestista da quattro associati, nessuno di questi intende (piu') assumere (anche) la veste di amministratore della società, Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani ed il motivo attiene semplicemente alla pesantezza delle mansioni da svolgere che nella figura del Farmacista dipendente e amministratore di società si vanno a sommare, a discapito delle ore libere per altre cose. Da qui quindi il quesito, sebbene sia noto che nelle SRL è possibile avere un amministratore esterno, tale organizzazione, ovvero società di persone su base paritaria ed amministratore unico non socio né farmacista è possibile? La risposta è positiva seppure con alcune precisazioni. Ed infatti come ben noto le società di persone sono enti non dotati di personalità giuridica e pertanto delle obbligazioni sociali rispondono i soci illimitatamente con il proprio patrimonio, eccetto nella configurazione della SaS (società in accomandita di persone) nelle quali è prevista una duplicità di soci, accomandati (limitatamente responsabili fino alla quota conferita) e accomandatatari, (illimitatamente resposabili) e di diritto anche amministratori. Cio' posto oggi è ammissibile avere anche nelle società di persone nella duplice forma di società semplici o di società in nome collettivo, un amministratore che non sia socio e cio' in ossequio a giurisprudenza che ha ammesso tale ricostruzione con deduzioni logiche molto convincenti sebbene non espressamente previste dal codice civile, ma nemmeno vietate. Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema L'assunto in base al quale è ammessa l'amministrazione in capo ad un non farmacista consiste nella riforma del diritto societario che ha espressamente ammesso nella compagine sociale anche non farmacisti, ecco quindi che ove non si tratti di compagine sociale, l'amministratore avrà un ruolo di dipendente della società seppure apicale, che non svolgerà alcuna delle funzioni riservate ai farmacisti, da qui l'assenza di incompatibilità derivanti dalla legge 362/1991. Leggi il Blog in Diritto Farmaceutico Quanto al lato societario invece l'ammissibilità è stata ricavata alla luce di una considerazione, ovvero ove la legge avesse voluto vietare tale figura, quella di amministratore di società di persone non socio, lo avrebbe fatto, come nel caso delle SaS ove per l'appunto l'amministrazione è riservata solo ai soci accomandatari. Articoli di Diritto Societario e Commerciale Impresa Ecco quindi che nelle farmacie gestite da società di persone, SS società semplice, o snc, società in nome collettivo, è ammissibile la figura di una amministratore esterno non socio, a patto che nel registro delle imprese di competenza non siano depositati patti sociali che escludano o limitino la responsabilità dei soci , e ciò con il preciso scopo di evitare che con espedienti tecnici si giunga - anche nelle società di persone - ad una forma di responsabilità limitata. Hai un quesito specifico da risolvere? Contattaci Possiamo quindi concludere che facendo tesoro delle ricostruzioni operate dalla Cassazione Civile n. 13761/09 e dal Tribunale di Roma sezione Imprese del 2021, n. 4971, e Consiglio Notarile Massima 100/2020, è ammissibile la nomina di un amministratore esterno nelle società di persone e per quanto attiene al nostro caso anche di un soggetto non farmacista. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Rimedi in caso di mancato pagamento negli appalti
Cosa fare in caso di mancato pagamento da parte della Stazione appaltante? Per rispondere al quesito é opportuno evidenziare che la stazione appaltante sarà responsabile dei mancanti paganti nei confronti dell’appaltatore e dei suoi sub appaltatori ove siano stati comunicati ed autorizzati Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Leggi pure: Subappalto casi pratici e rimedi Il primo ordine di problemi attiene quindi alla regolare esecuzione del contratto da parte della società appaltatrice ed in caso di uso di subappaltatori alla corretta comunicazione, valutazione ed autorizzazione degli stessi. Hai un quesito in tema di appalti ed impresa? Contattaci senza impegno Cosa fare in caso di mancato pagamento del subappaltatore? Il subappaltatore autorizzato avrà quindi diritto ad essere pagato e tale diritto si materializza sia verso il prototipo sub committente a sua volta appaltatore che verso la stazione appaltante anche mediante il meccanismo previsto dall’art 119 del nuovo codice degli appalti ovvero il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante. Leggi pure Risoluzione dell’appalto e segnalazione Anac Cosa fare in caso di mancato pagamento del dipendente? Ove invece a non essere pagato sia il dipendente dell’appaltatore o del subappaltare questo avrei diritto ad agire sia in sede monitoria con il decreto ingiuntivo che in via ordinaria con ricorso di diritto del lavoro avverso la catena di comando dell’appalto ovvero stazione appaltante, appaltatore ed eventuale società subappaltatrice secondo le direttive previste dall’art 29 del d.lgs 276 del 2003 che regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali. Leggi pure Esclusione dall’appalto e illeciti penali Scopri il tuo caso in centinaia di casi e pareri svolti Hai un quesito in tema di impresa ed appalti? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Concorso Ordinario Farmacie ed SNC
Facendo eco dalle numerosissime pronunce che in questi anni abbiamo commentato in tema di divieto di cessione infra decennale della farmacia come azienda, nonché delle innumerevoli questioni inerenti la quota sociale sia essa di matrice personale (SNC – SAS) che di matrice di capitali (SRL a seguito di trasformazione), Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema oggi proponiamo una rassegna di giurisprudenza alla luce delle disposizioni dei vari concorsi ordinari che si affacciano all'orizzonte dopo che la Regione Emilia Romagna ha inaugurato la nuova era post concorso ordinario con la delibera di giunta regionale n. 1301 del 24.06.2024, rilevando come sussistono se non addirittura rafforzate tutte le previsioni che abbiamo già visto in tema di concorso straordinario farmacie. Segui la pagina su Facebook con articoli gratuiti quotidiani Ecco quindi che come ben noto ai sensi dell’art. 12 comma 4 della L. 475/1968: “il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento; Leggi pure: Nuove precisazioni sul limite dei dieci anni per Farmacie ricevute in successione ereditaria Tale norma fa da eco all'art. 7 legge 362/1991, così come modificato dall’art. 1 comma 157 della Legge 124/2017, ai sensi del quale le società di capitali possono essere titolari di farmacie private, avendo come oggetto esclusivo la gestione delle farmacie stesse; Alla luce di tale base normativa assume rilievo l'interpretazione del Bando Regionale, che in estrema sintesi prevede e prevede che: Divieto infra decennale: uno dei requisiti il cui possesso è necessario per poter partecipare al concorso è quello di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e permanere fino al momento del rilascio dell’autorizzazione all’apertura della farmacia; Leggi qui l'approfondimento sul divieto decennale controlli in fase di concorso farmacie: in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, l’accertamento a seguito dei controlli previsti per legge della non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, comporta l’esclusione dalla graduatoria, quando il controllo rilevi la non sussistenza di un requisito necessario per l’ammissione al concorso, compreso il mancato permanere, fino al momento dell’apertura della farmacia, della condizione di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni; Leggi qui l'approfondimento su "Farmacisti ed Incompatibilità" Applicazioni pratiche della Giurisprudenza sui divieti ai Farmacisti Come affermato dal TAR di Napoli con sentenza 1341/2023, confermata poi da Consiglio di Stato 6016/2023 (Leggi qui l'approfondimento sulla sentenza) che: “ l’applicazione della normativa previgente, per quanto concerne le cause ostative, non possa avvenire sic et simpliciter, dovendosene vagliare la compatibilità, specie alla luce dei nuovi assetti societari”, registrandosi “un disallineamento tra le fattispecie di titolarità di sedi farmaceutiche con le fattispecie delle incompatibilità dei soci farmacisti (e relativa preclusione decennale a seguito di trasferimento di titolarità di farmacia) ”; Concorso Ordinario Farmacie ed SNC: secondo il CdS 256/2023 e prima, Consiglio di Stato 229/2020 e Consiglio di Stato 2763/2022 poi: “ l’obiettivo che si prefigge il comma 4 dell’articolo 12 della legge n. 474/1968 sopra richiamato - che impone il divieto di partecipazione ad un concorso per l’assegnazione di una sede farmaceutica a coloro che hanno ceduto la titolarità di una sede nei dieci anni precedenti la partecipazione al concorso – è quello di conciliare, bilanciandoli, l’interesse privato del titolare dell’esercizio farmaceutico a conseguire un adeguato ritorno economico dalla posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, con quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, evitando la prevalenza di intenti meramente speculativi e commerciali; Concorso Ordinario Farmacie ed SNC Lo scopo è quello di evitare che il medesimo farmacista consegua, in un arco temporale inferiore a dieci anni, il doppio vantaggio consistente nel ricavo derivante dalla cessione della farmacia oltre all’assegnazione per concorso di una nuova sede farmaceutica; Farmacia e quote sociali: Inoltre, sempre come afferma la giurisprudenza richiamata, che anche la detenzione di una quota di società di persone e sua successiva cessione, intermediata dalla trasformazione societaria da società di persone a società di capitali, integra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 12 comma 4 e ricade quindi nel divieto trattandosi di stratagemma elusivo. Leggi pure: "Farmacia ed il valore delle quote sociali nel tempo" Ed infine, che anche la cessione di quote di società di capitale non derivante da trasformazione di società di persone integri gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 12 comma 4 in quanto: la stessa giurisprudenza sopra richiamata afferma che nell’ipotesi di cessione di quote di società di capitali, giuridicamente e patrimonialmente autonome dai loro soci, la preclusione decennale prevista dalla norma in oggetto deve trovare un adattamento interpretativo che salvaguardi finalità e ratio della previsione ostativa; la titolarità delle farmacie assegnate con il concorso straordinario (art. 11 D.L. 1/2012) ai farmacisti che avevano partecipato in associazione, è stata conferita da talune Regioni ai singoli farmacisti sotto forma di co-titolarità unica pro indiviso (con successiva legittimazione sancita da giurisprudenza univoca del Consiglio di Stato), mentre da altre Regioni alle società, di persone o di capitali, costituite dai farmacisti stessi; ne deriva che, in ossequio ad un criterio di pari trattamento dei farmacisti partecipanti in associazione, come il trasferimento della propria quota di co-titolarità nel decennio precedente comporta l’esclusione dalla graduatoria del concorso ordinario, allo stesso modo la cessione della propria quota sociale deve comportare la medesima conseguenza; il doppio vantaggio che il legislatore vuole evitare, come sopra evidenziato, si ha anche nel caso di cessione di quote di società di capitali; Un caso dibattuto ma che oggi è stato pacificamente risolto è quello inerente la Farmacia in forma di SNC in Co-titolarità ove uno dei soci partecipi al concorso, e bene in tale caso la rinuncia del singolo non è sufficiente: che come nel caso di titolarità individuale è possibile la rinuncia, così anche nel caso di co-titolarità o titolarità sociale è possibile la rinuncia alla titolarità, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso; Delibera Giunta Regionale Emilia n. 1301/24. Abbiamo analizzato le varie sfaccettature oggi maggiormente in auge ed ampiamente discusse all'avvio del concorso straordinario e che nel decennio dal 2012 hanno trovato risposta solo dopo ampio dibattito, ecco quindi che un quadro della situazione alla vigilia dei nuovi bandi di concorso ordinario allevierà i dubbi di tutti i candidati farmacisti che si apprestano a partecipare. Hai un quesito in diritto farmaceutico? Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie in zone disabitate
Farmacie di nuova istituzione, la localizzazione operata dal Comune è criticabile? Quali sono i criteri per individuare una nuova sede di Farmacia? Si possono insediare Farmacie in zone scarsamente abitate e quindi non sostenibili da un punto di vista economico? Potremmo dire quindi, Farmacia nel deserto? Come difendere il Farmacista dalle piante organiche inefficaci. Per rispondere a tutte queste domande che sovente arrivano possiamo fare il punto della situazione della attuale giurisprudenza, ricordando che il Comune gode si di ampia discrezionalità ma non fino al punto di creare "cattedrali nei deserti". Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Ed infatti come più volte chiarito dalla giurisprudenza, la liberalizzazione delle farmacie, attuata con il citato D.l. 1/2012, non comporta che il Comune effettui la pianificazione territoriale dando priorità alle zone meno popolate, bensì che realizzi l'obiettivo "di assicurare un'equa distribuzione sul territorio" e, solo in via aggiuntiva (dunque non esclusiva), consideri altresì l'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 4.10.2017, n. 4629). Dunque, il criterio principale cui la pianificazione delle farmacie deve ispirarsi è quello dell'equa distribuzione territoriale delle stesse, mentre il criterio dell'accessibilità assume valenza integrativa e aggiuntiva. Segui la pagina in diritto farmaceutico con articoli a tema gratuito Lo scopo perseguito dalla riforma operata con il d.l. 1/2012 non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire o mantenere sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la sopravvivenza, ma di aumentare l'accessibilità all'assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile. L'esigenza di poter servire adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un'ottica complessiva che consideri l'intero territorio comunale, rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all'assistenza farmaceutica (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 11.7.2018, n. 4231; Cons. Stato, Sez. III, 24.1.2018, n. 475; Cons. Stato, Sez. III, 22.11.2017, n. 5446). Segui la pagina su Facebook con articoli quotidiani Deve ancora rammentarsi che, nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562; id. 22 novembre 2017, n. 5446; id. 30 maggio 2017, n. 2557; Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305; Cons. Stato, Sez. III, 22-11-2017, n. 5443; Cons. Stato, Sez. III, 22-11-2017, n. 5446; Cons. Stato, Sez. III, 30-05-2017, n. 2557), non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 28/2/2018 n. 1254; 20/3/2017 n. 1250 e TAR Napoli 5691/2021). Possiamo quindi concludere evidenziando che la discrezionalità del Comune deve avere una base di "istruttoria" solida al fine di dimostrare la necessità di sedi decentrate e dall'altro deve dimostrare di aver valutato ponderando i vari interessi contrapposti che sono sia quello della fornitura del servizio farmaceutico che quello della sostenibilità economica della Farmacia intesa come azienda. Scopri il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- SaS e l’esclusione dell’amministratore
Società in Accomandita, quando il Socio Amministratore é escluso, per irregolarità Società i problemi del socio accomandatario #società Con una recente sentenza di diritto societario sulla figura e responsabilita dell'amministratore di SaS la Cassazione ha ribadito un principio risalente nel tempo ma assai importante, ovvero quando la coincidenza della qualità di Socio ed Amministratore nella SaS comporta l'esclusione dalla società in caso di responsabilità. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato gratuitamente Società in Accomandita quando il Socio Amministratore é escluso, per irregolarità. Società in Accomandita, quando il Socio Amministratore é escluso, per irregolarità E che questo sia un principio dirompente si comprende dal fatto che usualmente le vicende del Socio non si riflettono nella qualifica di Amministratore anche se incidenti sulla stessa persona. Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema In sintesi Socio ed Amministratore sono due strade autonome anche se ricadenti sulla stessa persona, ma ciò non vale per la Società in Accomandita Semplice ove obbligatoriamente l'amministratore debba essere il Socio accomandatario. Società in Accomandita quando il Socio Amministratore é escluso, per irregolarità Si è chiarito che la revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio, nelle società di persone, costituiscono situazioni affatto distinte , legate a presupposti non necessariamente coincidenti, sicché non è possibile sovrapporre la disciplina legale dell’una figura a quella dell’altra, né implica che l’eventuale revoca della carica di amministratore incida di per sé sul perdurare del rapporto sociale. (Cass., sez. 1, 8 aprile 2009, n. 8570; Cass., sez. 1, 29 novembre 2001, n. 15197); Consulta l'archivio gratuito articoli Tuttavia , si è osservato che nella società in accomandita semplice l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, sicché la sua esclusione dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale, automaticamente comporta anche la cessazione della carica di amministratore. Società in Accomandita quando il Socio Amministratore é escluso, per irregolarità In giurisprudenza si è anche affermato che il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dall’amministratore determinino, non solo la revoca del mandato, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente (Cass., sez. 1, 9 marzo 1995, n. 2736); Ciò in quanto, indipendentemente dagli obblighi che incombono sull’amministratore-socio , vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla sua qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale. Cass. 26059/22. Consulta il nostro archivio e trova il tuo caso. La tutela della società rimane quindi principio cardine a cui ispirare le responsabilità del Socio Amministratore. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- farmacie ed il divieto dei 10 anni in caso di successione
Per la prima volta dopo anni assistiamo a chiarimenti che circoscrivono il limite di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968, ai sensi del quale il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento; Seguici con articoli quotidiani sui social - l’art. 7 legge 362/1991, così come modificato dall’art. 1 comma 157 della Legge 124/2017, ai sensi del quale le società di capitali possono essere titolari di farmacie private, avendo come oggetto esclusivo la gestione delle farmacie stesse; Ed ecco la delibera 1584 della Regione Emilia Romagna secondo cui non possono partecipare utilmente e devono essere esclusi dal Concorso pubblico regionale, i farmacisti che nel decennio precedente abbiano: - trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell’azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali; - trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario; Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Ecco ecco il nuovo periodo: di specificare altresì, in via complementare a quanto indicato al punto 1, che la preclusione decennale di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968 non può applicarsi al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso , oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità”; E quindi di ribadire che il requisito di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968 deve essere mantenuto fino al momento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia; Si evidenzia poi che nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso. Tali precisazioni sono contenute nella delibera regionale Emilia Romagna 8 luglio 2024 1564 sono apprezzabili ma saranno sufficienti ad orientare le scelte della Giustizia Amministrativa? Ricordiamo infatti che la disposizione del divieto decennale é data da una norma primaria art 12 legge 475/1968 che difficilmente potrà essere interpretata da una norma di carattere Regionale con l’evidente rischio della immediata disapplicazione da parte della Giustizia Amministrativa. Attendiamo sviluppi da parte delle altre Regioni e dello stesso Governo in quanto così scritta la delibera Regionale, a modesto avviso di chi scrive , rischia di diventare una norma di interpretazione di una legge nazionale con evidente invasione di competenze Stato/Regioni. Segui il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Convivenza ed Impresa Familiare
Il convivente di fatto entra di diritto nell'impresa di Famiglia A seguito della Storica sentenza della corte costituzionale n. 148 del 4 Luglio 2024 il convivente di fatto entra di diritto nelle tutele dell'impresa familiare e lo fa dalla porta principale, ovvero quella prevista per i familiari di cui all'art. 230 bis co. 3. Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Viene quindi abrogato l'art. 230 ter previsto proprio fino ad oggi per tutele minori dle convivente di fatto. Vediamo nel dettaglio la disciplina. In forza della previsione di cui all’art. 230 -bis cod. civ., il familiare che presta la propria attività di lavoro, in modo continuativo nella famiglia o nell’impresa familiare, cioè a favore di un imprenditore a lui legato, ai sensi del comma terzo, da vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, gode di una complessiva posizione partecipativa che consta sia di diritti patrimoniali che di diritti amministrativo-gestori. Dirtti del familiare: Sotto il profilo economico, il familiare ha innanzitutto diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in caso di buon andamento dell’attività d’impresa, ha diritto ad una quota di utili e di incrementi, anche in ordine all’avviamento, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e partecipa, sempre in detta proporzione, ai beni acquistati con gli utili. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate a maggioranza, così garantendo al familiare un trattamento diverso rispetto a quello normalmente riservato ad un lavoratore subordinato in ragione del particolare vincolo di solidarietà familiare che lega i partecipanti all’impresa. Cosa è l'impresa familiare Secondo il diritto vivente l’impresa familiare non costituisce una modalità di gestione collettiva dell’impresa, bensì una forma di collaborazione all’interno di essa e la norma di cui all’art. 230 -bis cod. civ. disciplina unicamente il rapporto che si instaura tra soggetti – il familiare (o i familiari) e l’imprenditore – per effetto dello svolgimento della prestazione di lavoro, senza con ciò interferire sulla imputazione dell’attività d’impresa, di cui resta titolare l’imprenditore che è l’unico soggetto ad agire sul piano dei rapporti esterni, assumendo il rischio inerente all’esercizio dell’impresa; il diritto del singolo prestatore di lavoro non è condizionato dall’analogo diritto che spetta agli altri familiari, in quanto esso è commisurato alla qualità e quantità del lavoro prestato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 gennaio 2005, n. 874). Secondo il diritto vivente l’impresa familiare non costituisce una modalità di gestione collettiva dell’impresa, bensì una forma di collaborazione all’interno di essa e la norma di cui all’art. 230 -bis cod. civ. disciplina unicamente il rapporto che si instaura tra soggetti – il familiare (o i familiari) e l’imprenditore – per effetto dello svolgimento della prestazione di lavoro, senza con ciò interferire sulla imputazione dell’attività d’impresa, di cui resta titolare l’imprenditore che è l’unico soggetto a d agire sul piano dei rapporti esterni, assumendo il rischio inerente all’esercizio dell’impresa; il diritto del singolo prestatore di lavoro non è condizionato dall’analogo diritto che spetta agli altri familiari, in quanto esso è commisurato alla qualità e quantità del lavoro prestato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 gennaio 2005, n. 874). Questa l'impresa familiare vediamo ora la casistica in tema di Convivenza ed Impresa Familiare Dopo un iniziale contrasto, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel configurare l’impresa familiare solo qualora il titolare dell’impresa sia un imprenditore individuale , escludendo quindi nell’ambito dell’impresa gestita in forma societaria (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 novembre 2014, n. 23676). Il nuoco concetto di famiglia: Unione civile e Convivenza di fatto Ai sensi della legge n. 76 del 2016 esistono due modelli distinti: il primo, quello dell’unione civile, riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, è aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali. Quanto al secondo modello (la convivenza di fatto), la legge n. 76 del 2016 abbandona la rigida alternativa tra tutela, o no, parametrata a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio e valorizza l’esigenza di speciale regolamentazione dei singoli rapporti, siano essi quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, ovvero quelli tra genitori e figli o che si sviluppano con i terzi. Conviventi di fatto sono quindi «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un’unione civile». La convivenza di fatto implica un “legame affettivo di coppia”; quindi non vi rientra la convivenza, ancorché stabile, che sia meramente amicale, di sostegno o di compagnia. La dichiarazione anagrafica crea una presunzione di stabilità del vincolo affettivo di coppia e agevola, sul piano probatorio, il riconoscimento dei diritti in favore dei conviventi di fatto. La dichiarazione non può esser fatta da persone «vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile», così come gli stessi rapporti sono di impedimento a contrarre matrimonio (artt. 86 e 87 cod. civ.). L'approdo della Corte Costituzionale del 4 Luglio 2024 va operata inserendo il convivente di fatto dell’imprenditore nell’elenco dei soggetti legittimati a partecipare all’impresa familiare di cui al terzo comma dell’art. 230-bis cod. civ., e quindi prevedendo come impresa familiare quella cui collabora anche «il convivente di fatto». Ai conviventi di fatto, intendendosi come tali «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale» (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016), vanno dunque riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all’imprenditore. Convivenza ed Impresa Familiare Il contratto di convivenza: I commi da 50 a 63 dell'art. 1 della legge del 2016 fissano ex novo la regolamentazione dell’eventuale contratto di convivenza, mediante cui i conviventi di fatto «possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune». Il contratto di convivenza richiede ( ex comma 57, lettera a , non diversamente dal matrimonio ex art. 86 cod. civ.) lo stato libero delle parti, essendo nullo in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza. Le restanti disposizioni si innestano nel solco di precedenti normativi e giurisprudenziali, soprattutto per quanto concerne i diritti della coppia verso l’esterno, confermando o precisando facoltà già riconosciute ai conviventi (quanto ai rapporti personali i commi da 38 a 41, 47 e 48; quanto ai rapporti patrimoniali i commi 44, 45 e 49), oppure, in misura minore, sono dirette ad ampliare la tutela di costoro attribuendo prerogative nuove (vedi il comma 42 sul diritto del convivente di continuare ad abitare, per un certo periodo, nella casa di comune residenza e di proprietà dell’altro dopo la sua morte o il comma 65 sul diritto agli alimenti in seguito alla cessazione della convivenza); restano affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell’indirizzo familiare e fedeltà, durata della relazione. Unione civile e convivenza di fatto nell'impresa familiare Nella legge n. 76 del 2016 la distinzione tra unione civile da un lato e convivenza di fatto dall’altro, rileva – come si è già visto – anche con specifico riferimento all’istituto dell’impresa familiare secondo cui, «[a]l solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 […]». In forza di tale disposizione tra i familiari partecipanti all’impresa familiare deve annoverarsi la persona dello stesso sesso unita civilmente all’imprenditore. In tal senso depone quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo, a mente del quale «[i]l regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Per il convivente di fatto il legislatore, in luogo dell’inclusione del novero dei soggetti ammessi a godere del regime dell’impresa familiare, ha optato per l’introduzione di una autonoma e specifica regolamentazione. Sei interessato all'impresa familiare? Leggi gli articoli a tema in fondo alla pagina oppure contattaci Concludiamo quindi affermando che con la sentenza n. 148 del 2024 del 04 Luglio 2024 il convivente di fatto entra nella famiglia nelle tutele dell'art. 230 bis cc Hai un quesito? Consulta il sito con articoli gratuiti a tema oppure contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Medicina l’ammissione agli anni successivi e la graduatoria nazionale
Ci viene chiesto quale sia la posizione dello studente che vuole iscriversi alla facoltà di Medicina 💊 negli anni successivi al primo rispetto a coloro che avendo fatto il test non lo hanno superato. Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Esiste un privilegio di ingresso da scorrimento per i candidati che hanno fatto il test di medicina e non lo hanno superato? Può l’università iscrivere per scorrimento i candidati che sono in graduatoria nazionale e non sono rientrati? É necessario che l’Università di Medicina pubblichi un bando per gli anni successivi al primo per i posti resi disponibili? A tutte queste domande rispondiamo con la giurisprudenza recente sul tema, ma son da subito anticipiamo la risposta, non esiste un privilegio per chi é in graduatoria nazionale, l’università infatti é tenuta ad una pubblicazione di bando per i posti resi disponibili agli anni successivi per rinunce e trasferimenti. Hai un quesito in tema di concorsi e procedure?Leggi il blog o contattaci Entriamo nel dettaglio - -ai sensi del D.M. 583/2022 all.2 punti 12-15 citati dalla Università resistente, agli Atenei “è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione , rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile”…“In conformità con le disposizioni di cui all’art.3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n.264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità” … “ Da tener presente quindi che gli Atenei non possono programmare posti ulteriori per gli anni successivi che sono solo quelli resi disponibili a seguito di rinunce e trasferimenti Ma come si entra agli anni successivi a Medicina? In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno” … “I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione”; - dal testo di tali disposizioni si evince che la Università , per le iscrizioni ad anni successivi al primo (sia che si tratti di soggetti provenienti da altri corsi di Laurea sia che si tratti di studenti ammessi al primo anno nel medesimo corso di Laurea) deve svolgere una selezione, di carattere locale, distinta da quella nazionale (che invece è tesa a individuare gli studenti meritevoli di immatricolazione al primo anno); Leggi pure Esami e concorsi i criteri di valutazione delle prove - è chiarissimo sul punto l’articolo 12 dell’all. 2 DM cit.: “Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti ”: non si deve scorrere solamente la graduatoria unica nazionale per le immatricolazioni ad anni successivi al primo, ma occorre una valutazione dei crediti e delle propedeuticità, e questa non può che avvenire in modo concorrenziale e comparativo, secondo i principi di trasparenza e buon andamento (lo stesso DM infatti le qualifica come “procedure”: “Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria”); Leggi pure Medicina e Chirurgia i rischi del ricorso collettivo - come previsto in via generale dal successivo articolo 13, i medesimi principi valgono anche per chi vuole accedere ad anni successivi al primo pur non essendo inserito in posizione utile nella graduatoria unica nazionale di prima immatricolazione: Leggi pure Quando procede al ricorso contro l’esclusione dal Concorso per Farmacisti - dal combinato disposto dei punti 12 e 13 del DM cit., si evince, in sostanza, che anche coloro che sono nella posizione utile alla prima immatricolazione nella graduatoria nazionale, se vogliono accedere ad anni successivi al primo devono passare attraverso il vaglio del riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità (così testualmente il comma 12), e tale riconoscimento non può che avvenire in modo selettivo e comparativo con tutti gli altri aspiranti (siano essi nella graduatoria nazionale o meno); - la circostanza di essere in posizione utile nella graduatoria nazionale, quindi senza un giorno di frequenza del Corso di studi in Medicina, già sotto un profilo logico, NON consente di attribuire nessun vantaggio sul piano della valutazione dei crediti formativi maturati aliunde; TAR Pe. 205/2024. Blog sui casi svolti in Concorsi Esami ed Ammissioni - se cosi invece fosse (peraltro secondo una interpretazione che da ultimo pare seguita anche dal giudice di appello, cfr. Consiglio di Stato sentenza 4380 del 2024, che questo giudice non ignora), si otterrebbero ovviamente risultati non del tutto ragionevol i: - non si può quindi utilizzare la graduatoria nazionale stilata per la immissione al primo anno, per scegliere anche gli studenti meritevoli di immatricolazione ad anni successivi al primo (Tar Pe. N. 283 del 2023), - la previsione espressa della possibilità di iscrivere ad anni successivi gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque, lungi dal disporre una riserva o un diritto di precedenza a favore di questi (che non avrebbe alcun fondamento, atteso che, come già rilevato, quella graduatoria ha tutt’altra finalità), è volta a eliminare una disparità di trattamento che si verrebbe a creare, in danno dei medesimi, ove alcuni di loro, pur avendo frequentando prima altri corsi di laure e maturato CFU astrattamente idonei a consentirgli la immatricolazione ad anni successivi, si vedessero preclusa la possibilità di partecipare ai bandi o avvisi annuali per le immatricolazioni ad anni successivi, ai quali invece avrebbero potuto comunque partecipare ove non fossero risultati idonei e in posizione utile nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione; Leggi pure Concorso Sna guida al ricorso - tale previsione espressa, inoltre, disciplina l’effetto per il caso in cui alcuno di essi risulti anche vincitore in questi bandi o avvisi per la immatricolazione ad anni successivi: lo scorrimento della graduatoria nazionale per la immatricolazione al primo anni, in favore di coloro che si sono collocati in posizione successiva; - se non si pone mente a tale differenza ontologica tra i diversi tipi di immatricolazione (primo anno e anni successivi al primo) nonché alle conseguenti diverse selezioni pubbliche normativamente previste ( nazionale di prima immatricolazione e locale per i trasferimenti o iscrizioni dirette ad anni successivi), allora si rischia sì che si rischia di confondere le due graduatorie, facendogli assumere una impropria funzione, in violazione dei differenti criteri selettivi tipizzati (come stabilito anche dall’adunanza plenaria 1 del 2015); - la iscrizione ad anni successivi al primo, infatti, deve basarsi su una ulteriore e diversa selezione Scopri i casi svolti nel blog gratuito - per il primo anno i posti sono prestabiliti e si procede a coprire le vacanze attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale, dal secondo anno in poi i posti vacanti sono quelli determinati dalle cause tipizzate (rinunce, trasferimenti, ecc…) e si può procedere alle coperture mediante i trasferimenti, e comunque sempre attraverso una selezione pubblica che basata sui criteri dei crediti formativi e delle propedeuticità (cui possono partecipare anche gli iscritti nella graduatoria); - ciò del resto in modo del tutto coerente: l’articolo 12 disciplina i posti che si liberano per il primo anno a seguito dello scorrimento della graduatoria; l’articolo 13 le vacanze che si determinano con altre modalità: ai primi si provvede con lo scorrimento della graduatoria, ai secondi con “procedure” di valutazione dei crediti formativi e delle propedeuticità; Leggi pure: L’algoritmo nei concorsi ed i rischi della Intelligenza artificiale dunque, si può affermare che: 1.- ai sensi del citato DM, anche chi si è collocato in posizione utile nella selezione nazionale, e dunque è stato iscritto al primo anno, può presentare domanda per il transito ad anni successivi al primo, cioè può partecipare ai bandi che, sempre secondo il medesimo DM, l’Ateneo deve pubblicare annualmente per la copertura dei posti che si rendono disponibili (per rinunce, trasferimenti o altro) su anni successivi a quello di primo ingresso, dovendo mantenere immutato per tutti gli anni successivi il numero di iscritti fissato sulla base dei criteri dettati dal Ministero per il primo anno di corso; - se alcuni di coloro che sono stati iscritti al primo anno ottengono il passaggio agli anni successivi, si determina uno scorrimento della graduatoria a vantaggio di quelli che devono accedere ancora al primo anno, nei limiti della efficacia temporale della stessa (pure specificata nel DM); Studio Legale con attenzione ed esperienza nei concorsi pubblici l’ammissione ad anni successivi al primo non può avvenire sulla base della graduatoria di merito del concorso di accesso al primo anno ma sulla base di autonomo e diverso bando annuale che deve valutare i crediti formativi raggiunti ai fini della iscrizione ad anni successivi; - da quanto sopra, consegue inoltre che per i posti che si sono liberati negli anni successivi l’Università deve bandire avvisi annuali, prevedendo criteri basati solo sul curriculum E cosa accade a chi “fortunato” si é avvantaggiato di una posizione migliorativa con iscrizione a Medicina senza bando negli anni successivi? non si possono vanificare gli esami universitari sostenuti nelle more, ( Consiglio di Stato sentenza 9456 del 2022 e Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108)”); - in altri termini, atteso che gli ammessi ad anni successivi “per scorrimento” sono un numero molto ridotto di studenti, appare equo tutelare il loro interesse attraverso una conferma in sovrannumero.. (TAR Pe 205/2024) Contattaci per il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto dei Concorsi Pubblici