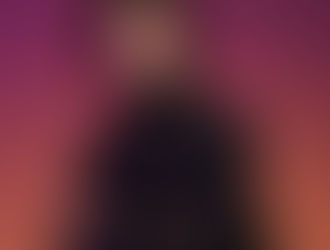Risultati di ricerca nel sito
717 risultati trovati con una ricerca vuota
- Medicina e Chirurgia - Ammissione Corsi di Laurea a numero chiuso,
mancata ammissione ai test di ingresso nelle facoltà di medicina e chirurgia Conviene fare un ricorso collettivo al Tar da parte dei Non Ammessi? Come ogni anno a Settembre ci si trova ad affrontare lo scoglio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, nei corsi di laurea che prevedono quindi un determinato numero di posti disponibili a fronte di candidati in numero sempre crescente. Per la verità quest'anno, i posti per Medici e Chirurgia sembrano essere 13.072, a fronte di una domanda meno corposa del previsto, si parla infatti di 66.638 domande circa. Dati giornalisti. La prova d'ammissione per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è composta da 60 domande a risposta multipla e deve essere completata in 100 minuti. Gli argomenti? Cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica. Negli anni precedenti secondo fondi internet, il punteggio medio nazionale registrato tra gli idonei è stato di 35,23. Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è di 39,12 a Pavia. La percentuale di idonei più alta è stata registrata a Udine (83,5%). Il punteggio più alto è stato conseguito presso l’Università Statale di Milano (82,4). I primi 100 classificati al test medicina sono concentrati in 22 atenei. Quelli con il maggior numero di candidati tra i primi 100 sono Milano-Bicocca (14), Bologna (14), Catania (10), Padova (10), Pavia (8). Fonte:sito web www.tuttoscuola.com E bene il rapporto tra candidati e posti è quindi di 1/5, per ogni posto ci sono 5 candidati, ammesso che si presentino tutti coloro che abbiano effettuato la domanda, senza poi contare tutti coloro che tornano sui propri passi o rinunciano per motivi vari, come lontananza da casa, lavoro, amore ed imprevisti vari. Accade sempre più spesso che i desiderosi di entrare, rimangano fuori per pochi punti, e questi sono coloro che sempre più di frequente affrontano la questione del ricorso alla giustizia amministrativa, quale rimedio per verificare la legittimità della propria esclusione, o posizionamento non utile in graduatoria. Il primo scoglio che viene affrontato dagli “scontenti” è quello del costo dell'accesso al ricorso davanti al Tribunale Amministrativo. E' facile trovare su internet le testimonianze dei costi dei ricorsi, che vanno sempre nell'ordine di qualche migliaio di euro per il singolo ricorrente. Ed ecco quindi che si propone come ogni anno l'annosa questione del ricorso “Collettivo” quello in cui i ricorrenti, ex rivali candidati uniscono le forze per dividere benefici e costi. In tali casi i cosi vengono ridotti del 80% - 90% a secondo del numero dei partecipanti. Ma è utile un ricorso collettivo? Per rispondere a questa domanda in modo sintetico bisogna distinguere il quesito in due parti, e quindi: 1) se da una parte è sicuramente utile da un punto di vista economico vista la possibilità di dividersi le spese; 2) dall'altra bisognerà valutare se i candidati al concorso, nella veste di ricorrenti vanteranno le medesime “pretese” nei confronti della Giustizia Amministrativa. In sintesi, se da una parte è possibile ricorre in gruppo davanti al Tar, seguendo il motto “l'unione fa la forza” anche alla luce della riduzione drastica dei costi, dall'altra servirà un buon legale che riesca a focalizzare i problemi comuni che rendano possibile un ricorso cumulativo, al fine di evitare le sempre più frequenti ipotesi di “inammissibilità” del ricorso. Per tutte le curiosità e domande, potete inviare una email all' indirizzo: Info@LegaleAeL.it ed inserire nell'oggetto il tipo di concorso di interesse, Avv. Aldo Lucarelli
- La fideiussione e le altre garanzie, cosa si può contestare alla Banca.
Vediamo nell'articolo la differenza tra la fideiussione e la garanzia autonoma, e quale è la differenza, soprattutto per quel che riguarda le contestazioni del garante verso la Banca creditrice. La fidejussione è un contratto di garanzia caratterizzato dalla accessorietà con il rapporto (debitorio) principale, mentre il contratto di garanzia è un contratto autonomo, a se' stante, volto a garantire il creditore per il fatto del debitore. La Cassazione ha piu' volte ribadito l’assoluta distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, atteso che la prima garanzia è volta a tutelare l’esatto adempimento dell’obbligazione principale altrui, che è quindi la medesima obbligazione prevista tra creditore e debitore, mentre il secondo, ovvero il contratto (autonomo di garanzia) pone sul garante un’obbligazione autonoma e distinta, votata all’indennizzo del creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro, somma che deve essere individuata o individuabile. Molto spesso tuttavia le parti nella fase iniziale del rapporto non pongono molta attenzione alla tipologia di garanzia ed alla classificazione, lasciando l'arduo compito di individuare se trattasi di fidejussione o contratto autonomo di garanzia, solo successivamente al legale o peggio al Giudice. Giova infatti evidenziare che a seconda della tipologia, sarà possibile effettuare delle eccezioni/contestazioni, sicché ove si tratti di fidejussione, il garante potrà eccepire le stesse eccezioni proprie del debitore, essendo il rapporto accessorio al debito originario, mentre ove il rapporto venga classificato autonomo di garanzia, il garante non potrà eccepire nulla di quello che deriva dal rapporto tra debitore e creditore. A tal proposito devono tenersi in debita considerazione le previsioni degli articoli 1945 e 1939 cc. secondo cui il Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità, ed ancora La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale. Tali elementi postulano l'accessorietà del rapporto tra fideiussore e creditore, e rendono quest'ultimo esposto alle eccezioni che poteva elevare anche il debitore principale, ad esempio un inadempimento, una mancata consegna, un ritardo nella prestazione e via discorrendo. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale salvo accordo di preventiva escussione del debitore principale, cosicché questi (il fideiussore) dovrà intervenire solo ove i beni del debitore originario non siano sufficienti. Sussistono poi altre due elementi sintomatici, ovvero le previsioni degli artt. 1956 e 1957 cc secondo cui il fideiussore per debiti futuri non è responsabile ove il creditore immaginiamo una banca, abbia fatto credito al debitore seppure versasse già in stato di dissesto, ed ancora in relazione al tempo, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza delle obbligazioni del debitore, purché vi sia stata una richiesta del creditore entro 6 mesi. Tali elementi corroborano e colorano la fidejussione e la rendono accessoria all'obbligazione/pagamento originario. Diversa sorte invece del contratto autonomo di garanzia che non ha nessuna delle caratteristiche sopra richiamate, e che tende a garantire maggiormente il creditore. Infatti la presenza nel contratto di statuizioni come "a prima richiesta e senza eccezioni" o di espressioni simili, essendo incompatibile con l’elemento dell’accessorietà sopra descritta, implica la ricostruzione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia. Il garante quindi non avrà nessuna delle garanzie di tutela descritte in favore del fideiussore. Resta tuttavia confermata l’operatività dell’exceptio doli, atteso che la deroga al meccanismo dell’accessorietà non può convertirsi in una incondizionata sudditanza del garante dinanzi ad ogni pretesa del beneficiario, a maggior ragione se abusiva e fraudolenta. Nel contratto autonomo di garanzia quindi il creditore non puo' abusare della propria posizione di forza nei confronti del garante. Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. (Cass. Civ.) Deve infine rilevarsi che la Cassazione a Sezioni Unite, 41994/2021 ha sancito la nullità delle clausole standard secondo il modello ABI pre inserite nei contratti bancari, trattasi delle clausole relative a – “riviviscenza”, l’art. 2 dello schema ABI dichiarava il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; – rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.” L’altra clausola contestata, ovvero l’art. 6 del predetto schema contrattuale ABI 2003, disponeva infine che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Secondo la Cassazione: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti “. Quindi da un lato la fidejussione risponde ad un principio di accessorietà, ed è soggetta alle regole descritte, dall'altra il contratto autonomo di garanzia, seppure piu' svincolato da rigide preclusioni del codice, non puo' oltrepassare il limite dell'abuso nei confronti del garante, il quale avrà come rimedio l'exceptio doli, come ad esempio il diritto di poter eccepire la sussistenza dell'anatocismo indipendentemente dal rapporto principale. Le differenze che abbiamo analizzato quindi hanno enormi risvolti in termini operativi e di tutela, capire se si é di fronte ad una fideiussione o ad un contratto autonomo di garanzia comporterà una grande differenza in termini di tutela. Hai un quesito? Contattaci Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Banca, garanzie ed eccezioni
La fidejussione è un contratto di garanzia caratterizzato dalla accessorietà con il rapporto (debitorio) principale, mentre il contratto di garanzia è un contratto autonomo, a se' stante, volto a garantire il creditore per il fatto del debitore. La Cassazione ha piu' volte ribadito l’assoluta distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, atteso che la prima garanzia è volta a tutelare l’esatto adempimento dell’obbligazione principale altrui, che è quindi la medesima obbligazione prevista tra creditore e debitore, mentre il secondo, ovvero il contratto (autonomo di garanzia) pone sul garante un’obbligazione autonoma e distinta, votata all’indennizzo del creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro, somma che deve essere individuata o individuabile. Molto spesso tuttavia le parti nella fase iniziale del rapporto non pongono molta attenzione alla tipologia di garanzia ed alla classificazione, lasciando l'arduo compito di individuare se trattasi di fidejussione o contratto autonomo di garanzia, solo successivamente al legale o peggio al Giudice. Giova infatti evidenziare che a seconda della tipologia, sarà possibile effettuare delle eccezioni/contestazioni, sicché ove si tratti di fidejussione, il garante potrà eccepire le stesse eccezioni proprie del debitore, essendo il rapporto accessorio al debito originario, mentre ove il rapporto venga classificato autonomo di garanzia, il garante non potrà eccepire nulla di quello che deriva dal rapporto tra debitore e creditore. A tal proposito devono tenersi in debita considerazione le previsioni degli articoli 1945 e 1939 cc. secondo cui il Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità, ed ancora La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale. Tali elementi postulano l'accessorietà del rapporto tra fideiussore e creditore, e rendono quest'ultimo esposto alle eccezioni che poteva elevare anche il debitore principale, ad esempio un inadempimento, una mancata consegna, un ritardo nella prestazione e via discorrendo. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale salvo accordo di preventiva escussione del debitore principale, cosicché questi (il fideiussore) dovrà intervenire solo ove i beni del debitore originario non siano sufficienti. Sussistono poi altre due elementi sintomatici, ovvero le previsioni degli artt. 1956 e 1957 cc secondo cui il fideiussore per debiti futuri non è responsabile ove il creditore immaginiamo una banca, abbia fatto credito al debitore seppure versasse già in stato di dissesto, ed ancora in relazione al tempo, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza delle obbligazioni del debitore, purché vi sia stata una richiesta del creditore entro 6 mesi. Tali elementi corroborano e colorano la fidejussione e la rendono accessoria all'obbligazione/pagamento originario. Diversa sorte invece del contratto autonomo di garanzia che non ha nessuna delle caratteristiche sopra richiamate, e che tende a garantire maggiormente il creditore. Infatti la presenza nel contratto di statuizioni come "a prima richiesta e senza eccezioni" o di espressioni simili, essendo incompatibile con l’elemento dell’accessorietà sopra descritta, implica la ricostruzione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia. Il garante quindi non avrà nessuna delle garanzie di tutela descritte in favore del fideiussore. Resta tuttavia confermata l’operatività dell’exceptio doli, atteso che la deroga al meccanismo dell’accessorietà non può convertirsi in una incondizionata sudditanza del garante dinanzi ad ogni pretesa del beneficiario, a maggior ragione se abusiva e fraudolenta. Nel contratto autonomo di garanzia quindi il creditore non puo' abusare della propria posizione di forza nei confronti del garante. Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. (Cass. Civ.) Deve infine rilevarsi che la Cassazione a Sezioni Unite, 41994/2021 ha sancito la nullità delle clausole standard secondo il modello ABI pre inserite nei contratti bancari, trattasi delle clausole relative a – “riviviscenza”, l’art. 2 dello schema ABI dichiarava il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; – rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.” L’altra clausola contestata, ovvero l’art. 6 del predetto schema contrattuale ABI 2003, disponeva infine che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Secondo la Cassazione: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti “. Quindi da un lato la fidejussione risponde ad un principio di accessorietà, ed è soggetta alle regole descritte, dall'altra il contratto autonomo di garanzia, seppure piu' svincolato da rigide preclusioni del codice, non puo' oltrepassare il limite dell'abuso nei confronti del garante, il quale avrà come rimedio l'exceptio doli, come ad esempio il diritto di poter eccepire la sussistenza dell'anatocismo indipendentemente dal rapporto principale. Le differenze che abbiamo analizzato quindi hanno enormi risvolti in termini operativi e di tutela, capire se si é di fronte ad una fideiussione o ad un contratto autonomo di garanzia comporterà una grande differenza in termini di tutela. Hai un quesito? Contattaci Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia: la decadenza dall'autorizzazione
La decadenza dall'autorizzazione è un fenomeno previsto nel regio decreto del 1934 per una serie di circostante che possono sorgere durante la vita della Farmacia e/o della società della farmacia. E, già, tale precisazione oggi è importante perché a seguito della riforma del 2017, anche le vicende della società che gestisce la farmacia possono costituire fenomeni che comportino la decadenza ove venga a verificarsi il "fallimento" della società. Tale ipotesi non era possibile se non in ambito delle farmacie comunali, prima del 2017 per i farmacisti privati, che invece oggi, accanto all'ipotesi di fallimento imprenditoriale personale, possono annoverare l'ipotesi tutt'altro che remota del fallimento societario, della società che gestisce la farmacia, procedura che seguirà l'iter di qualunque altra società commerciale, con la nomina di un Curatore, di un Comitato dei Creditori, e la sorveglianza del Giudice delegato, tutto ordinario, se non fosse altro che l'elemento particolare della vicenda risulta la "decadenza" dalla autorizzazione all'esercizio, e quindi dalla restituzione al sistema pubblico dell'autorizzazione per la sede, che quindi tornerà ad essere gestita in via provvisoria e/o vacante, in attesa di un nuovo concorso farmacie. Altri casi di decadenza sono la negligenza soggettiva del farmacista e la chiusura non autorizzata della sede. Se il primo caso, la negligenza andrà rintracciata nei profili comportamentali del farmacista titolare, e/o del direttore responsabile della sede assegnata, con particolare riguardo alle prescrizione del codice deontologico, e rispetto del divieto di commistione con l'attività medica, il secondo riguarda invece l'immotivata e prolungata (15 giorni) chiusura dell'esercizio farmaceutico, senza autorizzazione e senza il rispetto della roteazione per le farmacie di turno. E' solo il caso di precisare che ad esempio non sussiste il reato di «comparaggio farmaceutico» per chi corrompe il medico di base al fine di fargli prescrivere ai pazienti i parafarmaci prodotti dalla propria azienda. Il reato, infatti, caratterizza soltanto le «specialità medicinali» o altro «prodotto farmaceutico» e non è dunque applicabile agli integratori che sono «prodotti alimentari»”. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. penale, con sentenza n. 51946 del 16 novembre 2018. Altra ipotesi di decadenza è quella prevista per il mancato rispetto del pagamento dell'indennità di avviamento - art. 110 - per coloro che rilevano una farmacia già avviata. Sul tema abbiamo già scritto molto, (Indennità al Farmacista Uscente) il tema è caldo in quanto abbiamo avuto modo di verificare divergenze tra Regioni e Regioni in merito alla quantizzazione, oltre che un orientamento che oggi scollega l'autorizzazione all'apertura della sede con l'effettivo pagamento dell'indennità, e lasciando quindi alle parti (farmacista uscente/farmacista subentrante), l'obbligo di trovare un accordo e/o la remissione ad un giudice per la quantizzazione. Prima di chiudere la disamina (non abbiamo esaminati i casi piu' semplici di "morte" "rinuncia" "cittadinanza" "ispezioni") citiamo un recente caso del Consiglio di Stato ove il massimo organo amministrativo ha statuito che la prova effettiva del mancato funzionamento di una farmacia protratto nel tempo, puo' ricavarsi dagli accessi ispettivi e dai corrispettivi fiscali, e che, ove sussista la prova dell'effettivo non funzionamento non autorizzato, deve essere disposta la "decadenza" dall'autorizzazione, anche ove vi fossero potenziali acquirenti pronti a subentrare. Ed infatti la fonte del potere esercitato dall’amministrazione risiede nell’art. 113, primo comma, lett. d), del r.d. n. 1265 del 1934, il quale dispone che il farmacista decade dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia in caso di chiusura non autorizzata dell’esercizio per un periodo superiore a quindici giorni. Trattasi di una norma a presidio del servizio pubblico sanitario, che impone ai titolari delle farmacie un’organizzazione idonea a evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio.
- Risarcimento Specializzandi, a che punto siamo.
Facciamo il punto e l'evoluzione della vicenda dei risarcimenti per i medici ex specializzandi degli anni '80 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, e dell'evoluzione della giurisprudenza degli ultimi anni. In attesa di sapere cosa ne sarà dell'eventuale transazione, scopriamo i punti salienti della vicenda che abbiamo assistito da vicino. Esaminiamo, dopo aver commentato la sentenza della Corte di Cassazione 20278-2022 (in altro post clicca qui) che ha sancito anche nel nostro ordinamento il diritto al risarcimento del danno da inadempimento dello Stato per la mancata attuazione della direttiva comunitaria in tema di compensi ai medici specializzandi durante la scuola di specializzane, e cio' a prescindere dell'attività prestata, essendo a tal proposito sufficiente l'avvenuta iscrizione a detta scuola, già prima del dicembre 1982, purché completata successivamente al 1 gennaio 1983. E che i medici avessero diritto ad un risarcimento che andasse a coprire gli anni di studio/lavoro era già chiaro dal 1999 allorquando la prima legge (370) aveva cercato di porre un rimedio al ritardo con cui il nostro legislatore aveva trasposto nel diritto interno con il d.lgs 257 del 1991, il principio comunitario delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE. Torna alla Home E' stato necessario però un lungo cammino affinché le prime pronunce dei Tribunali potessero avviarsi verso un indennizzo che poi ha preso corpo in un risarcimento per gli anni spesi nella formazione medico specialistica. Si è così giunti alle prime sentenze della Corte di Cassazione, la piu' rilevante n. 18053 del 2019 per poi arrestarsi dinanzi al terribile dubbio di cosa potesse accadere per quei medici che alla data della direttiva fossero già iscritti e quindi fosse in corso la specializzazione. Tutti questi dubbi sono stati spazzati via dapprima dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea con la nota sentenza 590 del marzo 2020, e poi oggi, con la decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite che ha recepito tale indirizzo giurisprudenziale europeo, senza però definire la questione “quantum”. #medicina #specializzazioni #ricorso #risarcimento Va rilevato che Cass., Sez. Un., n. 20348 del 2018 (dopo un di poco anteriore precedente, di cui alla sentenza n. 19107 del 2018), provvedendo dopo la sentenza della CGUE, ha precisato che: “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.”. Infatti la corte di Cassazione ha rimesso gli atti alla sezione lavoro della Corte di Appello di derivazione, per quantizzare la somma che andrà liquidata anche ai medici in corso di specializzazione alla data di esistenza della direttiva comunitaria del 1982. Rimane da comprendere se tale risarcimento sarà nella misura prevista dalla legge del 1991, ovvero 21.500.000 di lire, quindi € 11,103 euro oppure nella minor somma disposta dalla legge del 1999 che aveva previsto 13.000.000 milioni di lire come borse di studio per gli specializzandi dell'epoca, quindi poco piu' di 6.500 euro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ecco, la rivalutazione monetaria, un tema che sarà caldo, perché non di poco conto, basti pensare che ove chiesta, la rivalutazione della somma potrebbe raddoppiare la somma, ma cio' solo ove si arrivasse al principio che la somma dovuta, una volta individuata sia una somma pagata dallo Stato Italiano quale debito di “valore”, sul punto però molte pronunce hanno analizzato i singoli anni di richiesta ed escluso la rivalutazione automatica per molteplici questioni che per questioni di spazio non sono esaminate nel presente articolo. E' il caso di precisare che l’azione di riconoscimento di indennizzo introdotta per inesatta o tardiva attuazione di direttive comunitarie sufficientemente precise ma non autoesecutive dai medici che abbiano conseguito la specializzazione successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257/1991 e che abbiano già percepito la borsa di studio ivi prevista, è di natura risarcitoria e prescinde pertanto dall’accertamento di un rapporto di lavoro e secondo la maggiore giurisprudenza deve essere avviata davanti al Tribunale di Roma, quale luogo ove è responsabile lo Stato Italiano. (Cass. Civ. 13255/2011). Il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 s’intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009 (Trib. Roma 3046/2016), salvo gli atti interruttivi della prescrizione. Il diritto al risarcimento può essere riconosciuto soltanto ai medici che abbiano frequentato un corso menzionato dagli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, avente durata minima non inferiore a quella indicata dagli artt. 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE. Nel caso di specializzazioni non ricomprese – al tempo della loro frequenza – negli elenchi allegati alle direttive, la domanda di indennizzo va rigettata, anche in assenza di contestazione, attenendo la mancata inclusione negli elenchi alla qualificazione giuridica dei fatti allegati e non alla loro esistenza (Cass. Civ. Sez. lav., 10.4.2013 n. 8764). L’inclusione della specializzazione negli elenchi in oggetto integra, dunque, un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e, in quanto tale, è anche rilevabile di ufficio. L’elencazione è tassativa, con conseguente esclusione del ricorso all’applicazione estensiva o analogica in favore di altre discipline sanitarie. (Trib. Roma 7238/2013). Hai un quesito? Contattaci Ecco quindi che con la sentenza della Corte di Cassazione 25278 del Giugno 2022 si dovrebbe essere quasi completato il quadro della articolata vicenda, attendiamo ora le determinazioni del rinvio per scrivere la parola fine per i risarcimenti degli ex giovani specializzandi, oggi medici affermati. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Medici Specializzati, si alla remunerazione anche prima del 1983
La Corte di Cassazione a sezioni unite 20278-22 ha affermato che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CE. #dottore #specializzazione #medicina Con tale pronuncia quindi la Cassazione ha dato impulso alla Corte di Appello di quantificare la remunerazione dovuta ai medici specializzati che per quegli anni ovvero 1982/1983 avevano iniziato la specializzazione, e fino alla conclusione. Nella causa in questione la somma richiesta era di € 21.500.000 di vecchie lire per anno pari a circa 11.000 euro. La formazione specialistica per avere la remunerazione prescritta dalla Corte di Giustizia Europea (590-20) e recepita dalla Cassazione a Sezione Unite 2022, deve rispondere a precisi requisiti e quindi avrà diritto 1) se iniziata prima del 29 gennaio 1982 deve essere proseguita oltre il 01.01.1983, oppure 2) deve essere iniziata a partire dal 1 gennaio 1983, data di scadenza dell'obbligo di adeguamento comunitario. Il diritto attiene alle specializzazioni riconosciute negli Stati membri, o almeno in due di detti stati, secondo quanto previsto dalla direttiva 75/362/CE. Un precedente orientamento aveva escluso infatti i medici specializzandi ante 29 gennaio 1982, ad opera della Cassazione 5509/2019. E' opportuno rammentare che trattasi di un risarcimento del danno da mancata applicazione interna (Italia) in relazione alla direttiva 82/76/Cee a sua volta riassuntiva delle direttive n. 75/362 Cee e75/363 Cee. In tal modo quindi viene riconosciuto il diritto alla remunerazione di quegli specializzandi che alla data del 31 dicembre 1982 stava già frequentando il corso di specializzazione o si era comunque iscritto ad una delle scuole pur senza ancor aver iniziato la relativa attività didattica, atteso che la normativa europea di riferimento non prevede in alcun modo la non applicazione delle disposizioni a favore della remunerazione ai corsi già in essere. Seguici sui social e rimani aggiornato Tale remunerazione, oggi liquidata a titolo di risarcimento del danno quindi vale a partire dal 1983 anche per gli iscritti in anni precedenti e proseguita successivamente a tale data; Lo Stato Italiano con sommo ritardo aveva riconosciuto il diritto solo dall'anno accademico 1991/1992 per mezzo del D.Lgs. 257/1991, con buona pace di tutti coloro che si erano iscritti, ed avevano conseguito la specializzazione durante il decennio precedente. Già qualche anno fa, questo Studio Legale, aveva intentato una controversia dinanzi ad un noto Tribunale proprio nel solco di quanto delineato oggi dalla Corte di Giustizia Europea 590-20 ed oggi la Corte di Cassazione 20278/22. Hai un quesito? Contattaci Rimane il nodo “compenso”, il quale per ora potrà essere parametrato a quanto previsto dalla legge dell'epoca, ovvero 21.500.000 di lire come prescritto dalla normativa del 1991, ma è opportuno rammentare che la legge n.370 del 1999 aveva riconosciuto una borsa di studio per gli specializzandi dall'anno 1983/1984 di lire 13.000.000. Rimane da comprendere ora la quantizzazione, a cui però sarà demandata apposita causa in Corte di Appello sezione lavoro. Consulta il nostro archivio gratuito di Studi e Pareri Puo' anche interessarti: "Medico e Consenso Informato" Studio Legale Angelini Lucarelli
- Assegno di mantenimento ad ex coniuge.. ed al terzo!
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente piu' debole che abbia iniziato una nuova relazione. L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. - Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine (però) il richiedente coniuge dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare all'epoca esistente. A titolo esemplificativo per avere diritto ancora all'assegno - di carattere compensativo - l'ex coniuge economicamente debole deve dare la prova della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza del matrimonio terminato, oppure dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Seguici e Rimani aggiornato Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti per l'appunto di carattere "compensativo" per quanto operato in costanza di matrimonio e tenuto conto altresì della durata del matrimonio poi cessato. Contattaci Con tali principi la Cassazione celebra l'esistenza di un assegno di mantenimento svincolato dalla separazione in sé considerata, ed ancorato alle vicende della coppia durante l'esistenza del matrimonio poi terminato, ecco quindi la funzione "compensativa" della corresponsione, agganciata quindi a vicende della passata vita matrimoniale. cfr Cass. Sez. Un.32198/21 Torna alla Home Legale Oggi
- APPALTI: Nuove linee Anac.
Sono state emanate nuove linee guida da parte della #Autorità Nazionale Anti Corruzione, non si tratta di novità ma di un approfondimento ed esplicazione volta a dare chiarezza su alcuni campi come gli Illeciti Professionali su cui ci eravamo già sofferti in passato su questo Blog. Non soltanto una sentenza di condanna ma anche un rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale o un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata possono incidere sulla moralità professionale di un’impresa e causarne l’esclusione da una #gara #pubblica. È quanto previsto dalle nuove linee guida approvate dall’Autorità Nazionale #Anticorruzione e sottoposte dal 18 gennaio al 28 febbraio alla consultazione pubblica online sul sito di Anac. L’atto è destinato alle #stazioni #appaltanti che devono verificare la sussistenza della causa ostativa prevista dall’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del codice dei contratti pubblici e agli operatori economici che si trovino a rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle gare. Hai un dubbio? Contattaci Il documento si prefigge di agevolare tutte queste attività, riducendo i casi di errore e favorendo la diffusione di best-practice anche per diminuire il contenzioso sulle esclusioni dalle gare da sempre molto elevato. Le linee guida stabiliscono che gli #illeciti professionali gravi possano essere causa di esclusione dalle #gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito. Si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione come ad esempio l’abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari, i #reati tributari, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati #urbanistici, i reati di corruzione fermo restando che le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, anche le condanne dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti antitrust gravi, le sanzioni comminate dall’ Anac, le false informazioni rese dai concorrenti alle gare e le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti. Seguici e Rimani Aggiornato L’esclusione dalla gara di appalto non è automatica ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di propria competenza. In caso di esclusione, la durata dell’interdizione dalle gare pubbliche è di tre anni. Gli illeciti vengono inseriti nel Casellario informatico da Anac su segnalazione delle stazioni appaltanti: nel 2021 le comunicazioni di esclusione iscritte nel Casellario informatico ammontano a circa 300 che rappresenta il 33 per cento del totale delle comunicazioni. Le nuove linee guida suggeriscono agli operatori economici misure di self-cleaning da mettere in atto per evitare l’esclusione dalle gare. Tale pubblicazione segue il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vedrà una serie di interventi su tutto il territorio nazionale, in attuazione del quale il ruolo di controllo dell'ANAC sulle stazioni appaltanti e sulla qualificazione giuridica dell'articolo 80 avrà un impatto notevole. Torna alla Home Fonte Anac #appalto #impresa #codice Legale Oggi
- Il Turbamento di funzioni religiose durante la processione.. è reato!
E' un reato turbare le funzioni religione. Lo stabilisce l'articolo 405 del codice penale, secondo cui chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni. La legge 24 febbraio 2006, n. 85 ha sostituito la precedente locuzione "del culto cattolico", così da unificare nella tutela apprestata da tale disposizione tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre. Contattaci Recentemente la Cassazione (20.01.2022) ha anche tenuto a precisare che in tema di delitti contro il sentimento religioso, integra il reato di “turbatio sacrorum”, di cui all’art. 405 cod. pen., la condotta di colui che interferisca con l’ordinato svolgimento di una processione religiosa alla presenza di un ministro del culto ordinando, in qualità di “capo vara”, ai portatori del fercolo soste ingiustificate del corteo dinanzi all’abitazione della famiglia di un capo-mafia. Seguici sui Social La pronuncia segue i vari episodi registrati nel recente passo durante le feste patronali di alcuni paesi a forte infiltrazione mafiosa, con pratiche di "rispetto" nei confronti dei capi mafia. Torna alla Home Legale Oggi
- Appalti, avvalimento: Nessun limite alla sostituzione dell'impresa ausiliaria irregolare.
Contattaci per ogni esigenza L’amministrazione appaltante è legittimata in corso di gara alle necessarie sostituzioni dell’ausiliaria per comprovati motivi documentati, senza che possa rilevare in materia alcun autovincolo alla possibilità di plurime o successive sostituzioni dell’ausiliaria, in conformità ai principi del favor partecipationis. Questo il principio ricavabile dalle recenti pronunce amministrative. Anche ad ammettere l’irregolarità contributiva dell’ausiliaria non è comunque vietata la pluralità delle sostituzioni, in quanto tale norma non prevede alcun limite alla sostituzione dell’ausiliaria: tanto risponde alla ratio dell’istituto dell’avvalimento, finalizzato ad assicurare la massima partecipazione alle gare a tutela della concorrenza tra le imprese. E ciò anche ove vi fosse precisazione dell'esistenza di tale "insostituibilità" da parte della stazione appaltante, avendo tali note una "mera portata sollecitatoria", ma non certamente impeditiva di un effetto (quello sostitutivo appunto) derivante in via obbligata dalla legge. In sintesi solo la legge potrebbe stabilire tale limite, ma così non è, infatti silenzio normativo sul punto, la relativa fissazione da parte della stazione appaltante di un termine entro cui effettuare la sostituzione dell'ausiliario è ragionevolmente legittima, come ha ritenuto la giurisprudenza, senza che tuttavia ciò comporti la sostanziale limitazione delle sostituzioni. Tale meccanismo, ovvero l'ammissibilità delle plurime sostituzioni dell'impresa ausiliaria priva dei requisiti di partecipazione ad una gara, è volto alla tutela dell'impresa ausiliata, la quale non può rispondere - nel meccanismo dell'avvalimento - per circostanze riconducibili solo alla sfera dell’impresa ausiliaria, delle quali però la prima non sia responsabile neppure a titolo di colpa. Contattaci (cfr. in analoghe fattispecie le decisioni del Consiglio di Stato hanno ritenuto non operante l’obbligo della stazione appaltante di escludere dalla procedura l’operatore e di revocare l’aggiudicazione eventualmente effettuata, senza procedere al previo invito alla regolarizzazione, nel caso di irregolarità della sola impresa ausiliaria della quale la concorrente intende avvalersi: Cons. St, sez. V, 26 aprile 2018 n. 2527; Id., sez V, 21 febbraio 2018 n. 1101). In definitiva, l'operatore ausiliato non può legittimamente subire le conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale non veridicità delle dichiarazioni dell'ausiliaria rispetto alle quali è privo di poteri di verifica, conseguendo l’esclusione dalla gara del concorrente soltanto alle dichiarazioni mendaci provenienti da quest’ultimo. Torna alla Home Legale Oggi - Appalti #appalto #società #avvalimento #srl #spa #esclusione Avvalimento, il codice degli appalti non pone limite normativo alla sostituzione delle imprese ausiliarie ai sensi dell'art. 89.
- Cessione di Credito tra Banche, la pubblicazione in gazzetta puo' non bastare, Quale è la prova?
L'argomento è di grande interesse perché può costituire difesa per il debitore nella eterna lotta avverso le azioni di recupero crediti avviate da Banche ed intermediari finanziari, in caso di "omessa documentazione". Come è noto l'articolo 58 del testo unico bancario regolamenta la cessione dei rapporti giuridici ad una Banca, siano crediti, o aziende, e impone il rispetto delle istruzioni, o anche autorizzazioni di Banca d'Italia. Tale meccanismo è utilizzato da tutte le grandi Banche per cedere linee di credito e rapporti giuridici che poi sono gestiti da società di recupero crediti appositamente costituite. La banca acquirente quindi dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. Tuttavia come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza dei Tribunali nell'anno 2020 “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, co. 1, TUB), non essendo sufficiente – in questa sua "minima" struttura informativa – a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi”. “E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016, e, nello stesso senso, più di recente Cass. civ. sent. n. 2780/2020). Seguici sui Social Ecco quindi che la Banca acquirente, deve fornire la prova documentale, non essendo di per sé sufficiente il generico e promiscuo modo della pubblicazione in gazzetta, dove per l'appunto dei molteplici rapporti ceduti non vi è alcuna indicazione specifica, trattandosi di operazioni avvenute in “blocco”. Ebbene, nel caso qui specificamente in esame, va evidenziato che secondo la prospettazione maggioritaria l’avviso di cessione deve considerarsi sufficiente a fornire la prova della titolarità del credito sebbene lo stesso non contenga l’indicazione/enumerazione specifica dei rapporti oggetto di cessione. Ma allora la pubblicazione in gazzetta è sufficiente? Non sempre infatti, è onere onere della Banca acquirente quindi produrre nel giudizio instaurato a seguito di opposizione, l'indicazione della sofferenza per la quale si agisce, delle linee di credito cedute, così fornendo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c. (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016, e, nello stesso senso, più di recente Cass. civ. sent. n. 2780/2020), l’evidenza della legittimazione attiva della Banca acquirente. Contattaci Ecco quindi che il meccanismo dell'art. 58 del Testo Unico Bancario per la giurisprudenza recente deve essere corroborato da una produzione documentale che dia indicazioni della posizione a sofferenza per cui la Banca agisce e della singola linea di credito/contratto ceduto, non essendo sufficiente la generica pubblicazione in gazzetta disposta dalla norma richiamata. Torna alla Home Legale Oggi
- Soci e Consorzio, quale valore ha la clausola arbitrale dopo la fine del rapporto?
Ci occupiamo di un quesito in tema di #Società, #Consorzio ed #Arbitrato. La clausola arbitrale, con cui quindi le questioni vengono demandate ad un arbitrato, ha valore anche dopo la fine del rapporto? Hai un caso? Contattaci In primo luogo va evidenziato che secondo la giurisprudenza dominate la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, comprende anche la controversia riguardante il recesso del socio del pari, quanto alla competenza del tribunale per le imprese con riguardo ai rapporti sociali, e, più in generale, tutti i casi in cui pure l'associato non sia più tale sin da un momento anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo, come per l'esclusione del socio o dell'associato. Varie sono le pronunce sul tema, tra le tante citiamo Cass., sez. un., 6 luglio 2016, n. 13722; Cass. 2 marzo 2009, n. 5019). In sostanza, restano situazioni afferenti la vita sociale o associativa, ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle così intese in senso ampio, con riguardo, quindi, non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti, sia pure "non più" o "non ancora" in corso, con l'ente, con gli organi di questo o con gli altri soci. Seguici Pertanto per rispondere al quesito, va detto che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto, si applica anche alle pretese avanzate dal consociato con riguardo al rapporto intercorso con l'ente collettivo, sebbene egli non prenda più parte della compagine associativa, in quanto tale pretesa continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, nonostante l'avvenuto scioglimento limitatamente al singolo rapporto. Torna alla Home Tale aspetto è applicabile anche in caso di società consorziata verso l'ente collettivo, ove lo statuto deferisca la controversia ad un collegio arbitrale o ad un singolo arbitro. #consorzio #appalto #società #fallimento #socio Legale Oggi A cura dell'Avvocato Aldo Lucarelli