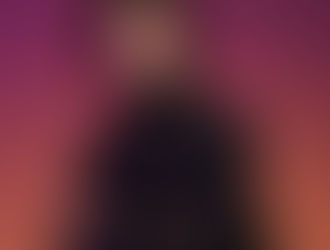Risultati di ricerca nel sito
717 risultati trovati con una ricerca vuota
- Fisco: Le ritenute 10 bis non versate non son più reato se non certificate.
Home Se non hai tempo vai alla Conclusione La Corte Costituzionale con la sentenza 175 del 14 luglio 2022, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione. Per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale – si legge nella sentenza – «viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicché da una parte l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall’altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario». Leggi gli altri articoli o proponi il tuo caso. Si ricorda, infatti, che il D.Lgs. 158/2015 aveva definitivamente eliminato ogni dubbio ermeneutico circa la problematica della condotta, e quindi del reato qualificandosi come reato il nuovo testo dell’art. 10-bis, infatti, punisce «chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti» In definitiva, il legislatore delegato ha introdotto nell’art. 10-bis una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione del sostituto), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti), senza essere autorizzato a farlo dalla legge di delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito per poter essere rispettoso anche del principio di stretta legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) Per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicché da una parte l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall’altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario. Seguici sui Social Su questo assetto del regime sanzionatorio non è privo di rilevanza il recente sviluppo della giurisprudenza civile (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 aprile 2019, n. 10378), secondo cui, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. in conclusione per l'art. 10 bis, D.Lgs 74/2000, dal 14 Luglio 2022 viene ripristinato il vecchio regime dell'art. 10 bis e si prosegue nella linea tracciata dalla Corte Costituzionale a Sez. Unite sentenza 22 marzo-1° giugno 2018, n. 24782 secondo cui «con riferimento all’art. 10-bis nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015, la dichiarazione modello 770 proveniente dal sostituto di imposta non può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova della avvenuta consegna al sostituito della certificazione fiscale e il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario». Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Agenzia delle Entrate, intimazione di pagamento e cartelle, come procedere.
L'esecuzione forzata da parte del concessionario - Agenzia delle Entrate Riscossione, Soget, Enti preposti o ex Equitalia, inizia una volta ricevuta la "cartella di pagamento". Home Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Seguici sui Social Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso, ovvero l'intimazione, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica. Ecco quindi che l'intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602/1973 costituisce una intimazione riassuntiva dei debiti verso la Pubblica Amministrazione, contenente somme a titolo di imposte, tasse e sanzioni che possono essere di diversa natura, IVA, IRPEF, IRAP, Addizionali Regionali, sino a Bolli e multe del codice della strada o di carattere amministrativo. Seguici on line Il punto dibattuto è quale sia il mezzo per rispondere ad una simile pretesa, che spesso risulta di difficile inquadramento proprio perché al suo interno contiene una moltitudine di "richieste erariali" anche molto differenti tra loro. Sul punto si registrano due importanti sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite, oltre che una serie di pronunce dei Tribunali Italiani e Commissioni Tributarie. E' stato quindi da ultimo precisato che quando si contesta il profilo del tributo in relazione ad una norma, la competenza sarà quella Commissione Tributaria Provinciale, quando invece il punto di critica attiene a profili formali, la competenza sarà del Tribunale Ordinario. Leggi gli altri contributi o proponi il tuo caso Quanto invece è in contestazione la prescrizione del diritto, la competenza sarà della Commissione Tributaria Provinciale, in relazione al quel singolo Tributo, essendo la Commissione chiamata a discernere delle diverse prescrizioni ove vi sia una moltitudine di imposte. Si segnalano diversi casi di ricorsi in appello alle commissioni Tributarie Regionali ove le Provinciali non abbiano differenziato la tipologia di prescrizione. (in sintesi il pensiero della Corte di Cassazione Sez. Un. 8465 del 15 Marzo 2022 e della Cassazione Civile ordinanza n. 2541 del 01 febbraio 2018, in senso difforme Cassazione 14648 del 2017). Torna alla Home Infine il problema della rottamazioni (bis/ter) decadute e delle rateizzazioni. Ove infatti tali contestazioni vadano a "colpire" la somma richiesta dall'amministrazione di pagamento nella intimazione, allora si potrà procedere una opposizione in Tribunale, vertendosi di fatti successivi al sorgere dell'imposta. Trattasi quindi di fatti sopravvenuti non deducibili nell’ambito del processo tributario esempio fattispecie estintive del credito come l’intervenuto pagamento o lo sgravio cd. “rottamazione” delle cartelle di pagamento), che possono certamente essere fatte valere dell’agente della riscossione a procedere all’esecuzione forzata. trovato piena conferma anche nella sentenza della Suprema Corte n. 11900/2019 e Corte di App. Catania ordinanza rg. 5000/19. Salvo che il Tribunale neghi la propria competenza! Insomma, la questione è molto articolata, ed andrà valutata caso per caso, oggi a seguito della ripresa delle attività di riscossione assistiamo ad una vasta attività di produzione giurisprudenziale. Hai un quesito? Contattaci Leggi i nostri articoli "Tributari" gratuitamente qui di seguito. Studio Legale Angelini Lucarelli
- E' regolare il DURC in caso di plurime rateizzazioni saldate in unica soluzione
Il ritardo nel pagamento di una rata alla Cassa Edile non costituisce circostanza significativa incidente sulla regolarità della posizione contributiva della società ausiliaria, al punto da determinarne l’esclusione. Seguici sui Social Anche i pagamenti (in ritardo) effettuati in un’unica soluzione, sebbene in ritardo rispetto alla scadenza dovuta, non possono riflettersi negativamente sulla regolarità del DURC richiesto dall'impresa. Contattaci se hai un quesito Regola di buona amministrazione è infatti il principio secondo cui per il requisito di partecipazione alle gare pubbliche della regolarità contributiva deve persistere per tutta la procedura di gara e anche nella fase esecutiva: Home infatti l’accoglimento di un’istanza di rateizzazione del debito pone nuovamente l’impresa in condizione di regolarità e, quindi, con possibilità di partecipare alla procedura (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15). Ai fini del possesso del requisito di regolarità la previa istanza di rateizzazione e la conseguente approvazione della rateizzazione dei pagamenti da parte degli enti previdenziali è sufficiente in assenza di atti successivi di questi ultimi idonei ad incidere in senso contrario sulla regolarizzazione accordata; Tanto è in linea con la disciplina di settore di cui all’art. 3 D.M. 31 gennaio 2015 sul documento di regolarità contributiva a mente del quale “La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti”. Inoltre, per quanto di interesse, l’art. 3, comma 2, lett. b) dello stesso decreto aggiunge che la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione di pagamenti in forza di disposizioni legislative. La correttezza del ragionamento non è scalfita neppure dalla normativa sopravvenuta di cui all’art. 8 del d.l. n. 76 del 16.7.2020, incidente sulle modalità di verifica della regolarità contributiva, ci si riferisce alla nota INPS "Messaggio n. 2998" del 30.7.2020 laddove si precisa, con rifermento alla portata della norma che: "il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva."). Torna alla Home Legale Oggi
- Operazioni oggettivamente inesistenti, a chi spetta provare che l'operazione non è stata realizzata?
Contattaci per ogni esigenza Per rispondere alla domanda, molto in voga in questo periodo riprendiamo i passi delle pronunce della Corte di Cassazione degli ultimi mesi. Secondo la giurisprudenza che si è andata consolidando sulla problematica relativa alla detraibilità dell'I.V.A. ed alla deducibilità dei costi nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui: spetterà all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto. Home Fiscale Tale prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (orientamento predominate dell'ultimo decennio). Pertanto, nel caso in cui l'Ufficio Finanziario ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l'indebita detrazione dell'I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l'onere di provare che l'operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari. Quindi solo a quel punto, dopo cioè che il primo passo sia stato compiuto dall'ufficio finanziario, passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Seguici sui Social Ma attenzione, tale prova non può tuttavia consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. E per l'iva è la stessa cosa? No, infatti con specifico riferimento all'I.V.A., inoltre, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'imposta non può in alcun modo farsi discendere - anche sul piano probatorio - dal solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell'I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all'attività dell'impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza. Ecco quindi che in tema di Iva, sarà necessario seguire il principio dell'inerenza dei costi. Prima di chiudere questa la disamina precisiamo che ai fini IVA, l’inerenza debba essere valutata secondo un giudizio di tipo qualitativo e non quantitativo, correlato all’attività d’impresa; con la conseguenza che la detrazione non possa essere esclusa solo in virtù di un mero giudizio fondato sulla congruità del costo. Contattaci per un quesito Unica eccezione al predetto principio è la possibilità per l’amministrazione finanziaria di dimostrare la macroscopica anti-economicità dell’operazione, la quale costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione dell’operazione Iva, con lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Legale Oggi a cura dello Studio Legale Angelini Lucarelli
- Quale indennizzo per gli Stabilimenti Balneari?
Home Stante la nota questione della illegittimità della proroga delle concessioni balneri fino al 31 dicembre 2033 ex art. 1, comma 682, della l. n. 145/2018, essendo stata tale proroga giudicata in sede nomofilattica contraria al diritto eurounitario e perciò disapplicabile anche dall’Amministrazione, sta sempre più prendendo corpo l'ipotesi degli indennizzi a favore dei gestori che abbiano effettuato consistenti investimenti. La questione non é di semplice soluzione in quanto il Consiglio di Stato nell'ultima sentenza sull'argomento del 2022 ha avuto modo di ribadire la necessaria valutazione caso per caso Le norme legislative nazionali di proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, tra cui in particolare l’art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”, e che deve pertanto escludersi che gli attuali concessionari vantino alcun “diritto alla prosecuzione del rapporto” in virtù di proroghe legali generalizzate. L’Adunanza Plenaria (n.17 e n.18 2021) ha infatti stabilito che le concessioni “già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”. Evidenziava poi la Plenaria che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative presentano un “interesse transfrontaliero” che rende il relativo affidamento soggetto al diritto sovranazionale. L’interesse in questione consiste nella “indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Stati membri”, il quale trae origine dal “dato di oggettiva e comune evidenza, legata alla eccezionale capacità attrattiva che da sempre esercita il patrimonio costiero nazionale (…) per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica”. Su tale base si giustifica, dunque, l’applicazione alle concessioni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative delle regole della concorrenza e dell’evidenza pubblica di matrice europea, finalizzate ad aprire settori di interesse economico alla concorrenza ed a rimuovere situazioni di ostacolo all’ingresso di nuovi operatori, invece favorite da norme di proroga dei rapporti in essere. Affermava la Plenaria altresi il carattere self-executing della direttiva n. 2006/123/CE in quanto “ha un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege fino al 2033” delle concessioni demaniali in questione “e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità”. Quindi, quando ad una tutela del legittimo affidamento e sulla ipotesi di indennizzi, la giurisprudenza amministrativa 2022 ha evidenziato come la tutela del legittimo affidamento richieda “una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti. Una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione”. Questione indennizzi.. concessioni balneri.. Ua recente pronuncia del Consiglio di Stato si precisa che «l’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi. La questione quindi in assenza di una normativa specifica andrà valutata caso per caso sopratutto per ciò che attiene al fattore temporale tra quanto disposto dalla direttiva del 2006 e quanto effettivamente provato dal gestore della concessione marittima. Cds 4934/2022. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Concorso Farmacie assegnazione con riserva ed assegnazione sub iudice, le sedi rimangono disponibili
Cosa accade se il vincitore di una sede di farmacia collocata in graduatoria si ritrova la dizione "Sede Sub iudice" o assegnata "con riserva" ? hai fretta? corri alla conclusione Per rispondere a questa domanda facciamo un esempio: La sede sub iudice è la sede sulla cui sorte pende un evento futuro ed incerto, ovvero un ricorso di altro partecipante al concorso collocato in posizione piu' utile in graduatoria, da cui potrebbe discendere una conseguenza sulla accettazione successiva. Trattasi quindi di "condizione" apposta sulla accettazione della sede che per l'appunto appare condizionata dall'esito del procedimento giudiziario avviato da altro partecipante. Ma ogni ricorso di una #candidato puo' inficiare la scelta delle sedi sub iudice? La risposta è no, infatti è necessario che quel determinato ricorso, da cui discende per l'appunto la definizione dell'accettazione "#sub #iudice" sia in grado di condizionarne la scelta del vincitore all'avveramento della condizione. E' necessario quindi che l'esito positivo di quel determinato procedimento possa incidere sulla accettazione compiuta dal candidato che abbia accettato la sede sub iudice. Da qui quindi la presenza di detta condizione. Su tale argomento abbiamo già scritto in altro articolo in relazione alle verifiche da compiere prima dell' #accettazione di una nuova #sede. Le sedi gravate da ricorso sono oggetto di apposito elenco regionale nel quale vengono classificate "con riserva" o "sub iudice" a secondo che si tratti di sedi che la Regione è in procinto di assegnare appunto "con #riserva" e che l'assegnatario potenziale accetta a condizione di essere "sub iudice". La questione espone il Candidato all’obbligo di accettare la sede sotto condizione sospensiva, con il rischio di vedersela revocare in via astratta, a fronte di una lunga procedura concorsuale di incerta durata. Si puo' poi discutere se la dizione "sub iudice" rivesta la figura di "condizione sospensiva" o di "condizione risolutiva". In ogni caso possiamo qualificare la clausola "accettazione con riserva" o sede "sub iudice" quali clausole di riserva condizionata che sono autonomamente impugnabili. Di recente è stato precisato che le sedi sub iudice, devono rimanere disponibili per i vincitori di concorso, e ciò in ragione dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Infatti una sede appetibile, qualora espunta dall'elenco delle sedi disponibili poiché soggetta a ricorso, andrebbe a nuocere il candidato che potrebbe optare per tale scelta, avvalendosi di apposita clausola contenuta nel modulo di accettazione, per l'appunto: "consapevole che trattasi di sede soggetta al ricorso", con ciò salvando l'effetto premiante della posizione utile in graduaotoria. Cosa accade quindi alla sede a cui è apposta una clausola di riserva non effettiva? In sostanza il perdurante stato di indeterminatezza dettato dalla situazione regionale considerato l’eccezionale protrarsi temporale della procedura concorsuale dal 2012 e l’assenza di un contenzioso pendente in merito alla sede farmaceutica assegnata appalesano come del tutto ingiustificata l’apposizione della clausola di riserva condizionata all’esito del contenzioso sub iudice; Quindi ogni clausola per essere apposta dalla regione deve essere vera ed effettiva e non meramente potenziale. E ciò è misurabile ove l'accoglimento del contenzioso, citato nella riserva regionale, proposto da altra candidata non potrebbe mettere in discussione l’assegnazione della sede. Sicché, se in generale può ritenersi ammissibile l’assegnazione regionale con riserva, è necessario però valutare caso per caso se ne ricorrono i presupposti. Cosa accade se viene apposta una clausola di riserva ad una sede che effettivamente non è soggetta ad alcun reale pericolo di riserva? Una clausola di riserva non effettiva - perché non collegata ad un reale pericolo giudiziario - andrà quindi in contrasto con i principi di "buon andamento" previsti dall'art. 97 della Costituzione e si potrà considererà quindi come non apposta. Occorre infatti considerare che l’apposizione della condizione ancorata ad un evento inesistente e destinata a rendere incerto l’ottenimento del bene della vita senza una effettiva data di scadenza, oltre a dover essere ritenuta come “non apposta” ai sensi dell’art. 1354 del codice civile, contrasta con il principio di buon andamento, di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Ed inoltre.. Invero, contrariamente a quanto dedotto la pendenza di giudizi aventi ad oggetto il perimetro delle sedi farmaceutiche messe a bando, non implica che un’eventuale assegnazione delle stessa debba essere necessariamente un’«assegnazione provvisoria», dal momento che la certezza della sede è indiscutibile, e sino all’esito del relativo giudizio resta incerta soltanto una zona comunque definita e circoscritta, rispetto alla più ampia area certa - non oggetto di contestazione; ne discende che nelle more del contenzioso in atto ben potranno essere individuati i locali in cui insediare l’esercizio farmaceutico , entro il perimetro iniziale, non oggetto di causa. In tal modo ben poteva essere soddisfatto l’interesse pubblico ad assegnare in titolarità le sedi farmaceutiche vacanti per poter garantire il servizio farmaceutico, esplicazione del fondamentale diritto alla salute da garantire alla popolazione residente, la quale peraltro riceverebbe dalla maggiore capillarità del servizio proprio quel beneficio che costituisce il fine pubblico primario perseguito dalla normativa di riferimento. Home Pertanto , considerato che l’ incertezza parziale sui soli confini non determina la impossibilità di procedere ad assegnazione della sede, l'apposizione di una clausola di salvaguardia come sopra descritta potrebbe salvare l'assegnazione, e ciò al fine di rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, di derivazione comunitaria a cui la Pubblica Amministrazione deve ispirarsi. Quindi Contattaci per ogni esigenza L’ordine di graduatoria è diretta esplicazione del principio di meritevolezza inerente ai pubblici concorsi , ed è idoneo a garantire i principi di imparzialità e parità di trattamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 Costituzione, atteso che “il criterio dell' assegnazione delle sedi … ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore” (Cons. Stato, Sez. IV, 18/1/2011 n. 5606, n. 5608, n. 56010, n. 5611; id., Sez. IV, 14/1/2013 n. 161; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 24/3/2016 n. 1609). Leggi anche "sedi sub iudice" di Farma&Diritto. Si rileva in proposito che l’esclusione delle sedi di nuova istituzione, in quanto sub iudice per il solo aspetto relativo alla perimetrazione, lede la situazione soggettiva dei partecipanti al concorso risultati vittoriosi, poiché preclude a coloro che sono in posizione favorevole in graduatoria, la scelta di una delle sedi oggetto di contenzioso. Per l’effetto risulta violato il principio dell’ordine di graduatoria, che la giurisprudenza considera ineludibile, atteso che le nuove sedi sarebbero assegnate in sede di secondo interpello a candidati in posizione inferiore in graduatoria. Conclusione Quindi chiarito il concetto di "sub iudice" si deve concludere che le sedi soggette a ricorso devono essere inserite in graduatoria per i principi di proporzionalità dell'agire della Pubblica Amministrazione, oltre che adeguatezza e ragionevolezza e rispetto della graduatoria, salvo l'inserimento di apposite clausole di salvaguardia, che rendano edotti i candidati vincitori. #farmacia #farmacista #concorso #farmacie Studio Legale Angelini Lucarelli a cura dell'Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie, quale controlli di vigilanza per le distanze?
Sovente viene richiesto di tornare su un argomento tanto caro ai Farmacisti titolari di sede insediata da anni, proprio ora, che a seguito del concorso straordinario farmacie, da poco concluso nel Lazio, 28.06.22, sono state aperte nuove farmacie da parte degli associati e dei singoli vincitori di concorso. - Ecco quindi la domanda, ma la zona di pertinenza della farmacia esiste ancora? - E' possibile contestare l'apertura della farmacia che invade la mia "zona" anche solo per dove è ubicata la croce verde o la porta di ingresso? Per rispondere sinteticamente a detti quesiti, già piu' volte analizzati, LEGGI QUI, possiamo dire che la ASL competente di zona su impulso del Comune, nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo sulle farmacie del proprio territorio ad essa spettanti, opera controlli sulle distanze e sulle nuove aperture ai sensi degli art. 111 e 127 del R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. (“Testo unico delle leggi sanitarie”) e degli artt. 14 e 15 della legge regionale Lazio n. 52/1980 per Roma capitale. Infatti, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 1265 del 1934 "L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualita' e quantita' dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.! e poi art. 127 del R.D. 1265 del 1934 secondo cui Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che puo' anche compiere ispezioni straordinarie. Nelle dette ispezioni il medico provinciale e' assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto. Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato e' diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzia la decadenza dall'autorizzazione. Da tali controlli deriva la legittimità o meno dell'istruttoria compiuta dall'amministrazione nel concedere l'autorizzazione all'apertura della nuova sede, oltre ovviamente ai controlli sull'iscrizione all'albo, sulla costituzione della società, sulla idoneità dei locali, e sulla collocazione utile in graduatoria, in caso di concorso, con il relativo possesso di tutti requisiti e l'assenza delle incompatibilità ex artt. 7 ed 8 della Legge 362/1991. Home Ecco quindi che la zona di pertinenza - o meglio la sede della farmacia esiste, ed è relativa alla pianta organica di cui ogni Comune, e Municipio nel caso delle grandi città, è titolare e responsabile, ma attenzione che le piante organiche spesso non vengono aggiornate, oppure cadono nel tranello di non computare quei presidi ancillari come dispensari che non sono compresi in tali piante, così come le farmacie istituite con modello topografico in deroga, ai sensi del noto articolo 104 T.U.. (Leggi Qui). A ciò si aggiunga, infine, come la fondatezza delle critiche sulle modalità di apertura delle porte di ingresso degli esercizi, e/o sulla istallazione delle croci verdi, sia comunque contraria a quel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, “ai fini della valutazione circa l'appartenenza dei locali prescelti per l'apertura della farmacia alla sede di competenza”, si debba - a ben vedere - aver riguardo “non già alla denominazione toponomastica ed alla relativa numerazione civica, bensì all’effettiva collocazione topografica di tali locali” (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 3391/2000 e da ultimo TAR Lazio Roma n. 12481/20). Ecco quindi che l'effettiva collocazione topografica dei locali, così come l'installazione di vetrine oscurate se aperte sulla strada di altra farmacia, sono i veri discrimen da tener presenti per il rispetto delle distanze e delle piante organiche. Hai un quesito? Contattaci Sei interessato all'argomento? Consulta il nostro vasto archivio di casi risolti ed affrontati. Leggi gli articoli correlati, qui sotto selezionati per Te. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Permesso di Costruzione art 20 dpr 380/01 sempre valido con il silenzio del Comune.
Il permesso di costruire, il suo iter, i tempi, ed il valore sel silenzio del Comune davanti ad una istanza illegittima. (Art. 20 dpr 380/2001). Cosa accade se il Comune non risponde e la domanda non ha tutti i requisiti? Il permesso di costruzione ex art 20 dpr 380/2001 in caso di silenzio del Comune é valido.. vediamo perché. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali.. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento... e le relative modifiche Il provvedimento finale, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni, che son 40 in caso di conferenza di servizi. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici. E comunque il SUAP entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Home cosa accade in caso di silenzio di elaborati illegittimi? Il silenzio-assenso si anche quando l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, e ciò in ragione dell’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore – rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo dell’amministrazione –, che viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi silentemente. Consulta i nostri articoli nel blog gratuito Ma attenzione la domanda priva di requisiti di validità può comunque ottenere l'assenso dato dal meccanismo del silenzio MA va distinta l’ipotesi della radicale ‘inconfigurabilità’ giuridica dell’istanza, ad esempio domanda di permesso di costruire quando il manufatto é già realizzato al momento della presentazione dell’istanza. Leggi i nostri articoli qui su - Abuso Edilizio - Vincolo Paesaggistico Contattaci per Ogni Esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Consiglio di Stato 5746/22)
- Diritto Bancario: E' Nullo il finanziamento per acquistare le azioni della stessa banca.
L'articolo 2358 cc prescrive una nullità assoluta per quei finanziamenti concessi dalla stessa Banca per l'acquisto esclusivo delle proprie azioni, e ciò con il chiaro scopo di evitare la dissoluzione del capitale sociale. La norma infatti ammette tali operazioni solo a determinate condizioni ed in particolare con riferimento all'autorizzazione da parte della assemblea straordinaria ed alla fissazione di un prezzo medio ponderato su gli ultimi 6 mesi. Ecco quindi che in assenza delle prescrizioni di legge tali finanziamenti edi relativi obblighi restituire devono ritenersi nulli per contrasto con le norme imperative Questa la sintesi del Tribunale si Verona nella recente sentenza del 22 giugno 2022. Infatti in si deve rilevare che l’art. 2358 cc, prevede un divieto chiaramente diretto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse dei creditori della società (v. pronuncia Corte Cass. n. 15398/2013) Trattasi nullità dell’atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto. (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007). Nel caso di specie come già esposto non ci si trova davanti a un mero collegamento obiettivo tra un qualsivoglia finanziamento erogato dalla Banca ed utilizzato “in autonomia” dal cliente per acquisti azionari propri del finanziatore ma ad un vero e proprio collegamento intenzionale tale per cui la concessione del finanziamento, o la concessione al cliente di operare “a debito” è addirittura effettuata intenzionalmente dalla Banca proprio allo scopo di finanziare l’acquisto/ sottoscrizione delle azioni o titoli della stessa banca finanziatrice, di tal che i negozi collegati risultano posti in essere intenzionalmente oltre che “obiettivamente” proprio e solo per conseguire acquisti finanziati vietati da normativa imperativa : di qui la nullità negoziale. Tale principio si può estendere anche alle società cooperative in assenza di delibera assembleare, stante l'inesistenza di una specifica deroga al riguardo. Sei interessato all argomento? Consulta l'archivio o contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Concorso Farmacie: i requisiti persi si possono riacquistare?
Ci è stato chiesto se per un candidato singolo, o in forma associata sia imprescindibile mantenere i requisiti di partecipazione al concorso durante l'intera procedura. La domanda appare assai pertinente oggi che a distanza di dieci anni, quelli che erano i requisiti e le compatibilità esistenti nel 2012 potrebbero non essere piu' pertinenti a distanza di tempo. E' giusto che l'amministrazione vincoli i partecipanti al concorso per un lasso di tempo così lungo, pregiudicando quelli che sono gli interessi della vita, e le opportunità di lavoro? A questa domanda la risposta era semplice, infatti piu' volte sia il Consiglio di Stato che i Tar avevano affermato circa la necessaria sussistenza dei requisiti per tutta la durata del concorso. Ma oggi qualcosa è cambiato grazie all'accostamento della procedura concorsuale del concorso farmacie al regime degli appalti e della gare pubbliche e mutando la disciplina delle gare pubbliche il risultato – innovativo – è differente. Infatti possiamo anticipare che la sussistenza dei requisiti dovrà sussistere nel doppio momento della presentazione della domanda al concorso e nel momento, assai distante e successivo, dell'effettiva possibilità di conseguire la sede, ma non – attenzione – durante la fase di scorrimento della graduatoria, periodo in cui in effetti, i partecipanti non assegnatari aspettano fiduciosi un nuovo interpello. Vediamo perché. Con una sentenza risalente al 2017 il CdS aveva evidenziato che le qualificazioni richieste dal bando devono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità MA, tale principio, non può essere letto se non coordinatamente al suo presupposto... #farmacia #concorso #requisiti Infatti, la Plenaria ha precisato che il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica. MA attenzione, quando dalla graduatoria emergono candidati farmacisti assegnatari vittoriosi, la posizione dei partecipanti non assegnatari deve differenziarsi in quanto questi sono in posizione non utile alla assegnazione della sede. Dalché “sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione”. Questa l'innovativo passaggio del CdS. Torna alla Home Quindi pretendere sine die, e quindi senza scadenza, che i concorrenti, non assegnatari ma in graduatoria, mantengano i requisiti inalterati, sarebbe una condizione sproporzionata, con la conseguenza che l’interpretazione del bando, alla luce dei canoni di proporzionalità e buona amministrazione, deve far ritenere che per la sussistenza del requisito previsto dal bando, deve farsi riferimento a due momenti distinti, ovvero, il momento di partecipazione al concorso ed il momento dell’assegnazione della sede farmaceutica. Ecco quindi che la permanenza dei requisiti per i candidati farmacisti non assegnatari avrà un differente valore temporale rispetto a coloro che si sono collocati utili in graduatoria. Tale articolata ricostruzione apre la strada a quel fenomeno per il quale il candidato, in possesso del requisito del concorso ed in graduatoria in posizione non utile, perda l'idoneità al concorso, durante le fasi di stallo della graduatoria, per poi riacquistarla in prossimità del nuovo interpello utile, e quindi dell'effettivo controllo operato dall'amministrazione. Per ogni esigenza contattaci Avv. Aldo Lucarelli
- Concorso Farmacie davanti alle Sezioni Unite in attesa del prossimo Concorso.
La Cassazione Civile a Sezioni Unite é chiamata a pronunciarsi sui criteri dei punteggi del passato Concorso Straordinario Farmacie. Sara discusso a settembre da questo Studio Legale avanti alle Sezioni Unite il ricorso presentato avverso il decreto sulle modalità di attribuzione dei punteggi del Concorso Straordinario Farmacie. Le Sezioni Unite sono a chiamate ad esprimersi sulla legittimità del criterio di calcolo dei punti e sulle attribuzioni del primo e del secondo decennio da parte dei candidati in forma associata. Contattaci In particolare é da valutare il peso delle esperienze maturate dai candidati nel secondo decennio di lavoro al fine del calcolo del punteggio e quindi sul bilanciamento tra esperienza maturata e titoli. Vero che lo spirito della legge così come interpretata dal Consiglio di Stato é stata quella di avvantaggiare i giovani farmacisti, ma è pur vero che la somma dei punteggi non può avvenire in modo lineare senza considerare l'effettivo svolgimento nelle annualità calcolate per gli associati. Ne aveva parlato anche la stampa specializzata. La somma dei titoli non può equivalente ad annualità di lavoro mai svolte, questo il pensiero di base dei ricorrenti. Tale criterio sarà recepito nel prossimo concorso ordinario Farmacie che erediterá le sedi rimaste vacanti o non assegnate con il concorso straordinario farmacie, concorso che sta volgendo al temine, come già accaduto nel Lazio con lo spirare del termine del 28 giugno. Sulle sedi vacanti andrà valutata la permanenza nelle liste di disponibilità, a meno che i rispettivi Comuni non provvedano a revocare la richiesta di sede. Sul punto occorre un gran lavoro da parte degli Enti (Comuni e Regioni) al fine di valutare la permanenza dei requisiti demografici e delle necessità effettive del posto visto che l'inserimento in lista delle attuali sedi necessarie da assegnare é stato disposto ormai oltre un decennio fa nel lontano 2010. Seguici sui Social Ci attende un autunno carico di sviluppi. Torna alla Home Rimani Aggiornato, seguici o contattaci per ogni esigenza.. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Medico ed Equipe la responsabilità medica.
L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Ci è stato chiesto di dare una indicazione sul metodo “logico” seguito nella disamina legale di una controversia di diritto sanitario e sulla responsabilità medica. Quando sussiste responsabilità medica? uccongli elementi da valutare: 1) un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (formula positiva); 2) non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento l'evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa). Da questo concetto nasce la nozione di giudizio controfattuale ("contro i fatti"), che è l'operazione mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta antigiuridica tenuta dell'imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza. Il giudizio controfattuale costituisce, pertanto, il fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. Hai un quesito o un caso? Contattaci In tema di #responsabilità #medica, è dunque indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito (Cass., Sez. 4, n. 43459 del 4-10-2012, Rv. 255008). L'importanza della ricostruzione è dirimente giacchè solo conoscendo in tutti i suoi aspetti #fattuali e #scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva #colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto (Cass., Sez. 4, 25.5.2005, Lucarelli) – Cass. 77/2022. Da ultimo é stato precisato che l’attività del #medico non può essere limitata all’intervento di cui il professionista risulta essere incaricato, ma deve ritenersi estesa, in coerenza alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso #followup prescritto dai protocolli ovvero comunque, nel caso accertato dal giudice di merito in relazione alla specifica, e non trascurabile diagnosi di melanoma effettuata nel caso di specie. Ecco che l’eventuale corresponsabilità di altri professionisti non può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo, ritenuto, quindi, responsabile per non aver fornito al paziente le necessarie indicazioni dopo un intervento chirurgico invasivo. Seguici e Rimani Aggiornato «In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 – pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia – non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, l’esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene». Cass. Sez. Un. 8770/2017. Torna alla Home Contattaci per Ogni esigenza . Studio Legale Angelini Lucarelli