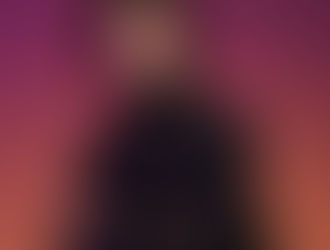Risultati di ricerca nel sito
717 risultati trovati con una ricerca vuota
- Cosa accade in caso di fallimento di un socio ove vi sia una controversia deferita ad arbitri?
#fallimento #arbitrato #società Contattaci Sul punto risponde l'articolo 83 della legge fallimentare secondo cui Va ancora osservato come a conclusioni opposte non si possa giungere sulla base dell'art. 83-bis 1. fall. Prevede la norma, inserita dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: «Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento #arbitrale pendente non può essere proseguito». Essa — alla stregua della sua lettera — dispone l'improcedibilità dell'arbitrato pendente, una volta sciolto il contratto contenente la clausola compromissoria in virtù delle regole sugli effetti del fallimento con riguardo ai rapporti giuridici preesistenti, di cui agli artt. 72 ss. 1. fall. (Cass., sez. un., 26 maggio 2015, n. 10800). La norma ha inserito ex novo la disciplina degli effetti del #fallimento in materia di clausola arbitrale, stabilendo che il procedimento arbitrale pendente alla data della declaratoria fallimentare non possa essere proseguito, nell'ipotesi in cui il contratto contenente la clausola arbitrale venga sciolto dal #curatore; la Relazione accompagnatrice al d.lgs. n. 5 del 2006 espressamente menziona la ratio di evitare che ad un mutato regolamento di interessi sopravviva la clausola arbitrale. La questione si pone, certamente, solo in presenza di una controversia relativa a diritti di #credito del fallito, dato che per i crediti di contro vantati verso il fallito vale necessariamente il procedimento di accertamento del passivo. Dunque, l'art. 83- bis 1. fall., nell'escludere la prosecuzione dei procedimenti arbitrali pendenti in caso di fallimento di una delle parti del contratto comprendente la clausola compromissoria, circoscrive tale effetto alle ipotesi in cui lo scioglimento del contratto abbia luogo a norma delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare — scioglimento del contratto ex lege o per volontà del curatore — ma non si applica quando lo scioglimento del rapporto sociale si verifichi per effetto della norma statutaria che prevede l'esclusione dal consorzio in caso di fallimento della consorziata (cfr. Cass. 23 ottobre 2017, n. 25054). Rimani aggiornato seguici sui social Ma non tutti i casi ricadono nella norma, infatti puo' capitare che la controversia non sia collegata al fallimento ma sia GIA' inerente la posizione del socio e/o della società in relazione ad esempio nella vita di un consorzio, e quindi sia relativa alla partecipazione in detto ente. In tali casi quindi la controversia è da annoverare tra quelle relative a diritti inerenti al rapporto associativo, perché inscindibilmente correlata alla partecipazione, non ad una posizione autonomamente attribuita al fallimento, ma già inerente la posizione della consorziata in bonis, quale diritto patrimoniale ricollegato alla partecipazione all'ente #collettivo. Hai un quesito sul tema? Contattaci. In tema di arbitrato quindi l'articolo 83 della legge fallimentare non si applica ove il rapporto tra società e consorzio si sia sciolto per previsione statutaria e non a seguito della #procedura fallimentare, secondo il principio dell'art. 72 della legge fallimentare. Torna alla Home Legale Oggi
- Traffico di influenze, ma quando è penalmente rilevante la mediazione?
Non tutte le mediazioni opache possono concretizzarsi nel reato ex art. 346 bis c.p., è necessario che la mediazione sia finalizzata alla commissione di un reato, idoneo a produrre vantaggio per il committente (privato). Questa la sintesi della ricostruzione della fattispecie del reato di traffico di influenze operata dalla recentissima pronuncia Cassazione del novembre 2021. Il problema sta infatti nella individuazione di quale sia la mediazione illecita, ovvero interferenza illecita, visto che la norma non tipizza o elenca quale siano le condotte ritenute interferenze lecite con la pubblica amministrazione, né quale siano quelle ritenute illecite, con l'evidente rischio di attrarre nella fattispecie penale tutte quelle condotte connotate da scarsa trasparenza, ma non per questo di per sé illecite. Ecco i passi della sentenza piu' significativi. In definitiva le parti devono avere di mira un'interferenza illecita, resa possibile grazie allo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente. Il legislatore ha inteso punire con l'art. 346 bis cp in via preventiva e anticipata il fenomeno della corruzione sottoponendo a sanzione penale tutte quelle condotte in precedenza irrilevanti prodromiche rispetto ai reati di corruzione consistenti in accordi aventi ad oggetto le illecite influenze su un pubblico agente che uno dei contraenti (il trafficante) promette di esercitare in favore dell'altro (il privato interessato all'atto) dietro compenso (per sé o altri o per remunerare il pubblico agente) La lettura della norma consente di individuare il nucleo dell'antigiuridicità della condotta penalmente sanzionata non nel mero sfruttamento (vero o vantato) di relazioni con il pubblico agente (che costituisce piuttosto il mezzo attraverso il quale il soggetto agente riesce ad ottenere dal privato la dazione indebita, anche solo come promessa) bensì in tutte quelle forme di intermediazione che abbiano come finalità l'influenza illecita sulla attività della pubblica amministrazione. Infatti la norma pone sullo stesso piano (anche sanzionatorio) la intermediazione finalizzata alla corruzione del pubblico agente e la mediazione “illecita” così chiarendo che anche per quest'ultima forma di traffico l'antigiuridicità della condotta debba postarsi necessariamente sull'elemento finalistico. La norma peraltro non chiarisce quale sia l'influenza illecita che deve tipizzare la mediazione e non è possibile, allo stato della normativa vigente, far riferimento ai presupposti ed alle procedure di una mediazione legittima con la pubblica amministrazione (la c.d. Lobbying) attualmente non ancora regolamentata. Il contenuto indeterminato della norma rischia di attrarre nella sfera penale a discapito del principio di legalità, le piu' svariate forme di relazioni con la pubblica amministrazione, connotate anche solo da opacità o scarsa trasparenza, ovvero quel sottobosco di contatti informali o di aderenze difficilmente catalogabili in termini oggettivi e spesso neppure patologici, quanto all'interesse perseguito. E' necessario quindi ancorare la fattispecie ad un elemento certo che connoti tipizzandola la mediazione illecita e che costituisca una guida sicura per gli operatori e per l'interprete della norma. A tal fine il Collegio ritiene che l'unica lettura della norma che soddisfi il principio di legalità sia quella che fa leva sulla particolare finalità perseguita attraverso la mediazione: la mediazione è illecita quando è finalizzata alla commissione di un “fatto reato” idoneo a produrre vantaggi per il privato committente. Cass. Pen.40518/2021 6a sez.
- Reati Informatici.. accesso abusivo, alterazione dei sistemi e carte di credito.. Scopriamoli.
Scopri anche il posto criptovalute & fisco. 1) Accesso abusivo al sistema informatico. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informaticoo telematico protetto da misure di sicurezza Ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. (accesso abusivo al sistema informatico art. 615 ter c.p) 2) Alterazione del sistema #informatico; Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032... Trattasi quindi di #frode informatica che necessita però di manomissione o alterazione di funzionamento sistema informatico con ingiusto profitto, previsto dall'art. 640 ter cp. 3) Uso indebito delle carte di #credito/di debito o solo dei codici. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa #pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi... Trattasi di uso indebito di carte di credito/debito/pagamento, come previsto dall'493 ter cp, ma attenzione, per cadere in tale reato basta il possesso dei codici, o della #carta, anche se clonata. Tre #reati informatici ma con profili differenti. Tralasciamo l'analisi dell'accesso abusivo a sistema informatico, che non desta particolari perplessità in quanto costituisce reato l'introduzione nell'account di un terzo senza averne diritto, scopo della norma infatti tutelare lo “spazio #virtuale” del titolare e la riservatezza informatica. Qualche perplessità in piu' desta invece il confine tra l'uso indebito delle carte di credito/pagamento, o anche la sola detenzione dei #codici, e il reato di truffa informatica. La truffa informatica tuttavia necessità di un vero e propria alterazione di funzionamento del sistema informatico e del raggiro. Infatti l’indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato 493 ter cp e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l’adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso #indebito di una carta di credito (Sez. 2, n. 48044 del 09/09/2015, Rv. 265363). Difatti il delitto di frode informatica richiede necessariamente che si penetri abusivamente nel sistema #informatico bancario e si effettui illecite operazioni sullo stesso al fine di trarne profitto per sé o per altri. Appare pertanto evidente che per consumare il suddetto delitto non è indispensabile il materiale possesso della carta di credito o di pagamento essendo anche solo sufficiente il possesso dei codici della stessa carta e dei codici personali utilizzati a fini di profitto personale od anche a vantaggio di terzi; Viceversa la #frode informatica ex art. 640 ter c.p. sanziona la condotta di colui il quale, "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno" e richiede quindi quale elemento differenziale e specifico l’accesso al sistema e non anche il semplice utilizzo di dati personali comunque illecitamente acquisiti. Pertanto la condotta di chi effettui operazioni di pagamento mediante una carta di credito o di #pagamento di cui non risulti titolare anche senza il materiale possesso della carta stessa ma utilizzando il numero ed i codici personali della medesima carta di cui è venuto illegittimamente in possesso integra il delitto ex art. 493 ter cp ovvero quello di Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Criptovalute & Fisco
- Le spese della coppia nella ex famiglia...
Cerchiamo di fare chiarezza su nodo ricorrente di litigio in caso di #separazione e #divorzio, il regime delle spese in relazione all'assegno di mantenimento. Prima di scendere nel dettaglio è importante evidenziare che in caso di affido condiviso tra #coniugi, entrambi avranno eguali diritti ed obblighi in relazione la figlio minore, quindi attenzione a non affrontare "spese" decise autonomamente senza il consenso dell'altro EX coniuge, in tal caso infatti sarà pressoché impossibile aver diritto alla restituzione della quota virtuale a carico del ex coniuge non informato preventivamente. In ogni caso sebbene non sussista un obbligo di ripartizione obbligatoria per spese voluttuarie non approvate, non sussiste nemmeno un vero e proprio diritto di "blocco" di tali spese. Sarà quindi onere del coniuge che riterrà tale spesa imprescindibile, affrontarla con il rischio di non vedersi riconosciuta la metà. Passando al regime delle spese, utilizzando le parole della giurisprudenza considereremo spese #straordinarie e quindi escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento, quelle relative ad eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita del figlio minore, oppure episodiche. Sono invece spese #ordinarie – e dunque incluse nell’assegno di mantenimento, le spese che ricorrono frequentemente, quotidianamente e sono quindi cicliche ed imprescindibili per la normali esigenze di vita della prole. Home #famiglia #separazione #divorzio #mantenimento Legale Oggi
- Il contratto di ormeggio, tra contenuto minimo ed essenziale.
Il contratto d’ormeggio rientra nei contratti atipico ma con una base tipizzazione secondo cui si sostanzia in un accordo per la messa a disposizione e l’utilizzazione di strutture portuali ma può ben includere anche altre prestazioni accessorie quali la custodia del natante e/o delle cose in esso custodite. Eventuali ulteriori elementi renderanno necessaria la prova da parte di chi voglia farli valere. Video Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Peraltro, il suo contenuto può del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell’altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell’oggetto e del contenuto. Il relativo accertamento si esaurisce in un giudizio di merito che, adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. Home Concludiamo la disamina evidenziando che manca nel nostro ordinamento una norma primaria che autorizzi l'obbligatorietà del servizio di ormeggio e nè il Ministro dei Trasporti e della Navigazione nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo o di intervento diretto in materia tariffaria ed altro, nè l'Autorità marittima, nè l'Autorità portuale possono introdurre con atto amministrativo alcuna riserva od esclusiva di fatto o di diritto in materia di ormeggio. Legale Oggi
- Banca: Il conto corrente ed il valore del piano di rientro.
I contratti bancari devono essere redatti per iscritto, come previsto dall'art. 117 del Testo Unico #Bancario, a pena di nullità. Tale prescrizione comporta che le eventuali prescrizioni tra #Banca e Cliente, ove non abbiano una base scritta non potranno costituire autonoma fonte di obbligazioni, e cio' nemmeno nell'ipotesi in cui vi sia stato un piano di rientro, il quale avrà quindi un valore meramente ricognitivo, e non novativo di nuovi obblighi, né comporterà preclusioni inerenti i rapporti in essere. Questo il principio che si ricava nella recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di conto corrente bancario. Seguici sui Social Infatti secondo la giurisprudenza della Cassazione in tema di conto #corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del #debito, non ne determina l'estinzione, nè lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicchè resta valida ed efficace la successiva contestazione della #nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. 19 settembre 2014, n. 19792). Consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Il principio è stato affermato in più occasioni con riguardo al tema degli #interessi ultralegali: si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo (Cass. 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n. 2690). Home Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle altre pattuizioni, regolanti le condizioni praticate al cliente, contenute nei #contratti bancari: i quali, a norma dell'art. 117 t.u.b., devono essere redatti per iscritto (comma 1), a pena di nullità (comma 3). Legale Oggi
- Società a Responsabilità Limitata e pagamento della quota al Socio receduto, quale termine?
La vicenda ricade nel disposto dell'art. 2289 c.c. secondo cui il pagamento della quota spettante al #socio che ha effettuato il recesso deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto nella #srl Ma che valore ha tale #termine? Tale termine deve intendersi a beneficio del debitore ovvero della società tenuta al pagamento, infatti il fatto che la società sia tenuta ad adempiere entro sei mesi dalla data indicata implica che essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non possa pretendere il pagamento prima di allora; e infatti la #Cassazione ha avuto modo di precisare che per la prestazione in questione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento, ai sensi dell'ultimo comma cit. art. 2289 c.c., e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si é verificato lo scioglimento del rapporto di società (Cass. 17 maggio 1974, n. 1427): Ciò sull'evidente presupposto che l'obbligazione divenga esigibile al decorso del semestre e che il diritto di credito del #socio receduto maturi alla scadenza del semestre è affermato, del resto anche da Cass. 27 aprile 2011, n. 9397. Home Ora, la prescrizione inizia il suo corso da quando la prestazione dovuta al creditore è esigibile e ciò, nel senso che, ove il termine per l'adempimento sia a favore del debitore, la prescrizione estintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il #creditore non può esigere la prestazione dovuta. Da quanto sopra ne deriva che : "In tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289 c.c. prevede, a beneficio del debitore, che il pagamento sia esigibile dal socio creditore decorsi sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; pertanto la prescrizione del relativo diritto di credito inizia a decorrere dalla scadenza di detto termine semestrale." Legale Oggi
- Si può sospendere l'approvazione di un Bilancio nella Srl?
Per rispondere alla domanda è opportuna una premessa. L’approvazione del Bilancio spetta all’assemblea dei soci nelle Società a responsabilità limitata (Srl). Tuttavia, tale approvazione non può avvenire liberamente. La normativa, infatti prevede un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio annuale. Tale procedura può essere così schematizzata: Redazione di un progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo; Presentazione del bilancio agli organi preposti al controllo; Deposito del bilancio presso la sede sociale; Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci; Deposito del bilancio presso il Registro Imprese. E bene le deliberazioni sociali dell'assemblea, così' come la deliberazione di approvazione del bilancio nella Srl così come nella Spa, sono soggette alla procedura "cautelare" che prevede per l'appunto la sospensione dell'efficacia. Infatti gioca ricordare che nel procedimento cautelare volto ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle delibere assembleari, il termine “esecuzione” a cui fa riferimento l’art. 2378 comma III c.c. in materia di S.p.A. – applicabile anche alle S.r.l. in forza del richiamo contenuto nell’art. 2479ter comma IV c.c. – non si rivolge soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per restringere immotivatamente l’ambito della tutela cautelare. Ne consegue che pure le delibere tecnicamente prive di esecuzione aventi mera efficacia dichiarativa, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di approvazione del bilancio, possono essere sospese ai sensi dell’art. 2378 comma III c.c. (cfr. Trib. Palermo, 12.3.2018; Trib. Milano, 31.5.2017; Trib. Torino, 15.11.2013). Invero l’ammissibilità della tutela cautelare anche in tema di impugnazione di delibere di approvazione di bilancio è ricavabile dal riferimento testuale all'efficacia della deliberazione assembleare, operato dall’art. 35, comma V, d.lgs. n. 5 del 2003, sui poteri cautelari degli arbitri in materia di delibere. Un analogo potere in punto di sospensione degli effetti delle delibere deve riconoscersi anche nell’ambito della giurisdizione ordinaria, pena la violazione del principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. Da ciò discende che ogni volta che una decisione dei soci sia produttiva, nell’assetto organizzativo della società, di effetti perduranti nel tempo, non può astrattamente negarsi al socio che ne lamenti la contrarietà a legge o a statuto, sussistendone tutti gli altri presupposti di legge, il potere non solo di eliminarla dall’ordinamento, ma di neutralizzarne gli effetti in corso di causa (cfr. Trib. Milano, 31.5.2017). Sul punto è opportuno segnalare la sussistenza di una tesi opposta da parte della giurisprudenza recente del Tribunale di Roma - sezione imprese, stante, ad avviso di siffatta corrente, di una natura "meramente dichiarativa" della delibera di approvazione del bilancio. Trib. Roma 12.05.2015. In punto di diritto, giova rammentare che l’art. 2377, comma VIII c.c. enuncia un principio generale che consente di sostituire la delibera annullabile o nulla, prevedendo un effetto di sanatoria ex tunc (c.d. rinnovazione sanante), idoneo a far salve le situazioni di fatto e i diritti acquisiti medio tempore in forza della delibera sostituita, a condizione che la delibera sostitutiva risulti conforme alla legge e allo statuto (cfr. Trib. Milano, Sez. XV, 02.07.2019, n. 6430; Trib. Roma, Sez. III, 28.11.2017, n. 22268). Ammessa quindi l'impugnabilità e quindi la sospendibilità, occorre precisare che la norma invocata (art. 2378 cc) richiede la valutazione della sussistenza di un nesso causale fra l’esecuzione (ovvero la protrazione dell’efficacia) della deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto e implica l’apprezzamento comparativo della gravità delle conseguenze derivanti, sia al socio impugnante sia alla società, dalla esecuzione e dalla successiva rimozione della deliberazione impugnata. Così, il provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia della delibera potrà essere concesso soltanto ove si ritenga prevalente, rispetto al corrispondente pregiudizio che potrebbe derivare alla società per l’arresto subito alla sua azione, il pregiudizio lamentato dal socio (cfr. Trib. Roma, Sez. XVI, 22.04.2018; Trib. Bologna, 22.05.2017; Trib. Firenze, 23.02.2017; Trib. Napoli, 24.02.2016). Torna alla Home Legale Oggi
- Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Oggi sussiste piena parità tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio, chiamati impropriamente "illegittimi". Il punto di partenza legale è presente nella carta costituzionale, che nell'art. 30 testualmente: "La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima". Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, alla nascita, oppure in epoca successiva, con dichiarazione davanti ad un ufficiale di stato civile, ma è sufficiente anche una forma meno solenne contenuta in un testamento o in un atto pubblico. Legittimati a riconoscere il figlio sono il padre dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento, Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso, e cio' al fine di tutelare la volontà del ragazzo che ha già maturato una propria identità, mentre il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Attenzione che il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, può ricorrere al giudice competente il quale deciderà con sentenza che terrà luogo del consenso mancante; se invece viene proposta opposizione dal genitore dissenziente , il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore, oltre che al suo cognome, ed ai diritti ad egli spettanti ex lege, come ad esempio il diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, oltre che mantenere rapporti significativi con i parenti. Seguici Sui Social E' solo il caso di evidenziare che il codice prescrive espressamente che il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e che l'educazione impartita dai genitori dovrà tener conto del rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio. Home Legale Oggi
- La cartella di pagamento: Il concessionario deve averne una copia per l'esecuzione.
La mancata copia della cartella esattoriale da parte del concessionario puo' portare all'arresto della procedura di esecuzione ove lo stesso non sia in grado di estrarne una nuova copia per l'avvio della procedura. Questo è quanto si deduce dalla recente giurisprudenza che ha parificato la cartella esattoriale al titolo ed al precetto, atti propedeutici per l'avvio dell'esecuzione forzata. Infatti: "Il concessionario, ai sensi dell’art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale. ed ancora "Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni (CdS AP 4/22 del 14.03.22. " Ha precisato il Consiglio di Stato che la cartella ha, invero, una funzione composita che si riflette inevitabilmente sulla sua natura giuridica: a) da una parte è lo strumento che nel procedimento di esecuzione esattoriale serve a portare a conoscenza del contribuente, mediante notifica, l’esistenza del titolo esecutivo b) dall’altro la cartella di pagamento incorpora anche il contenuto del “precetto” (tipico dell’esecuzione civile), in quanto “la cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”, nonché “l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo” (comma 2 bis dell’art. 25 cit.). Essa riporta inoltre le “avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione” (art. 6, comma 2, d.m. n. 321 del 1999 cit.); c) in alcuni peculiari e tassativi casi, inoltre, la cartella di pagamento può addirittura rivestire funzione impositiva in senso sostanziale, in tutto assimilabile ad un atto di accertamento (si pensi a titolo di esempio, alla cartella di pagamento emessa nell’ambito della procedura di controllo automatizzato delle dichiarazioni reddituali, ai sensi dell’art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973). Insomma è parificabile al come rilevato dalle Sezioni Unite, in generale e salvo casi specifici, “la notifica della cartella assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto” (Cass., sez.un., 14 aprile 2020, n. 7822). La modalità alternativa di conservazione dell’atto si è concentrata, dunque, di fatto, su una sola modalità: l’effettuazione della copia della cartella. In caso di indisponibilità della copia della cartella suscettibile di ostensione il concessionario dovrà rilasciare specifica attestazione della mancata detenzione della cartella, avendo cura di specificarne le cause, essendo evidente che l’obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità. #agenziariscossione #esecuzione #cartella Legale Oggi a cura dello Studio Legale Angelini Lucarelli
- Dispensario Farmaceutico: a chi tocca gestirlo?
#dispensario #farmaceutico #gestione #apertura #chiusura #farmacia Cerchiamo di fare il punto sul dispensario farmaceutico, oggi che a distanza di 10 anni dall'avvio del Concorso Straordinario, il numero di farmacie titolari si è esponenzialmente innalzato e quindi la sorte dei dispensari farmaceutici diventa sempre più precaria, sebbene gli stessi soggiacciono a logiche differenti da quelle delle Farmacie. Proveremo a rispondere ad alcune domande, visto che l'istituzione dei dispensari farmaceutici non è passata di moda ove sussistano oggettivi requisiti che altro non sono se non la traduzione pratica della difficoltà di accesso al sistema farmaceutico, problema questo irrisolto in alcune aree del nostro paese. In un altro contributo invece affronteremo il problema opposto, ovvero cosa accade ai dispensari delle aree che da sprovviste diventano invece coperte delle nuove sedi farmaceutiche. Per quel che qui rileva, laddove in un Comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti non risulti aperta “la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici” (art. 1, comma 2 L. n. 221/1968). Il seguente art. 1, comma 3 della L. n. 221/1968 prevede che “la gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune”; Va subito precisato che in presenza dei requisiti richiamati “le Regioni sono vincolate ad aprire dispensari, al fine di garantire l'effettiva copertura dell'intero territorio comunale” (Cons. Stato, Sez. III, 27.02.2018, n. 1205). Quindi emerge chiaramente come non sia necessario un prodromico atto istitutivo del dispensario farmaceutico, sicché l’amministrazione regionale procede unicamente e direttamente all’apertura del dispensario, ove non vi sia la relativa farmacia. Neppure è necessario che la Regione disciplini a monte regole procedimentali relative ad un confronto competitivo tra i farmacisti interessati alla gestione temporanea del dispensario istituito. Ciò è infatti chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha rilevato che l’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico (non stagionale) non è l’esito di una procedura ad evidenza pubblica, dovendo essere esclusa l'applicazione del metodo concorsuale, essendo i principi di imparzialità e non discriminazione rispettati a monte, posto che il dispensario costituisce un servizio aggiuntivo, estensivo dell'attività di altra farmacia posta in prossimità, e quindi non assimilabile all'ordinario servizio farmaceutico, in quanto privo di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale (Cons. Stato, Sez. III, 27 giugno 2018, n. 3958). Ne consegue che alcun procedimento competitivo partecipativo che coinvolga i titolari delle farmacie della zona deve essere disciplinato dalla Regione, né ci si può dolere del mancato rispetto dei principi partecipativi in quanto il dispensario esula dalla procedura concorsuale dell'art. 4 della legge 362/1991 vertendo nel'alveo della attività vincolata della Regione ove sussistano i requisiti. Nè è possibile richiamare contenuti tipici della concorrenza tra farmacie, il criterio principe per la gestione del dispensario è quello della accessibilità e vicinanza con la farmacia titolare piu' prossima. Anche il concetto di vicinanza deve essere però precisato infatti, oltre alla vicinanza è necessario anche il rispetto della migliore condizione di accessibilità del dispensario da parte del farmacista in rapporto al luogo nel quale questi svolge l'attività principale, che si riflette sull'efficienza, continuità, possibilità di assidua presenza per l'organizzazione e l'esercizio di compiti aggiuntivi a quelli ordinari. (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2906 ancora Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2019, n. 7620). Ma come dimostrare tali elementi? Per la Giustizia Amministrativa anche tramite Google Maps! Avv. Aldo Lucarelli
- Fallimento Società a Responsabilità Limita, attenzione ai piccoli debiti.
La società che non versa gli stipendi regolarmente ai proprio dipendenti è soggetta la fallimento, così' come il mancato pagamento anche di "piccoli" debiti può essere sintomo di insolvenza, ed esporre quindi la società alla procedura fallimentare. Sottovalutare situazioni debitorie ricorrenti e costanti, ancor più se documentate nelle scritture contabili può essere un chiaro segnale di insolvenza cronica e condurre alla procedura fallimentare. Questa la sintesi a cui si giunge dopo un'analisi della recente giurisprudenza del 2022. Gli stipendi dei dipendenti sono una partita di debito ricorrente, il mancato rispetto della scadenza, sia essa anche una sola ma rilevante, connota infatti un palese stato di "insolvenza", così come il mancato pagamento di un debito apparentemente piccolo può essere sintomo di "insolvenza". Il Tribunale Fallimentare infatti non é tenuto a valutare elementi esterni alla società o contro crediti per evitare la procedura fallimentare, quello che viene analizzata é invece il grado di solvibilità per la regolarità dei pagamenti. Un contro credito non salva dal fallimento. Infatti, la situazione di insolvenza connota uno stato di salute dell’impresa meno grave del vero e proprio deficit patrimoniale, ben potendo essere possibile che anche in caso di patrimonio netto negativo la società possa adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (ad esempio, grazie alle disponibilità creditizie di cui gode) e che, d’altra parte, un imprenditore può essere insolvente anche quando l’attivo prevalga sul passivo (come avviene tipicamente nell’ipotesi in cui le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di debiti pur di minore entità, ma immediatamente esigibili). In tale contesto assume rilevanza decisiva la circostanza prevista dalla disciplina legislativa relativa alla “regolarità” nell’adempimento, che fa passare in secondo piano anche il dato dell’eventuale superiorità in dati numerici dell’attivo rispetto al passivo. Presupposto oggettivo del fallimento è, quindi, una generale situazione di difficoltà economica riguardante l’impresa, che genera l’impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l’hanno generata. Tale situazione non deve essere momentanea e transitoria, ma deve consistere in una condizione ormai patologica dell’impresa, tale da non consentirle di onorare le obbligazioni assunte con mezzi ordinari.. con la conseguenza che l’insolvenza dell’imprenditore, ai fini del fallimento, si presenta quando si versa in una situazione di crisi finanziaria, indipendentemente dalla consistenza del patrimonio dell’imprenditore medesimo, posto che il dato preminente è costituito dal fatto che l’imprenditore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni senza che possa rilevare la circostanza che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile. Sul punto si veda la ricostruzione della Corte di Cassazione, tra le varie, la n. 6914/2015. Qualora quindi l'imprenditore voglia contrastare la domanda di fallimento, dovrà dimostrare l’insussistenza del suo stato di insolvenza, senza prospettare in termini ipotetici e futuri situazioni economiche prive, però, di obiettivi riscontri che dovrebbero essere funzionali ad una ristrutturazione del suo debito, magari relativi ad ipotetici incassi futuri. Quindi a fronte di un debito consistente nei confronti dei propri lavoratori, e/o di piccoli creditori, l'imprenditore sarà comunque esposto alla procedura fallimentare, ove non dimostri che la propria situazione di crisi sia reversibile e temporanea, e quindi non versi in un conclamato stato di insolvenza. Diversamente il debito rappresentato dal creditore procedente dimostrerà inequivocabilmente l’incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e pertanto la sussistenza dei requisiti per il fallimento. Ad avviso di chi scrive quindi l'assistenza legale dovrà focalizzarsi sulla fase PRE-Fallimentare, volta a verificare che l'impresa sia in grado di poter far fronte alle proprie passività, anche con il ricorso a meccanismi di indebitamento sostenibile. Per evitare quindi di incorrere nella procedura fallimentare è necessario non sottovalutare i piccoli debiti, e focalizzare l'attenzione sul requisito della "regolarità" e "sostenibilità" del proprio business, con l'ausilio di consulenti specializzati. Legale Oggi - Impresa a cura dello Studio Legale Angelini Lucarelli. #fallimento #società #srl #impresa #imprenditore #procedura